Doc. XXIII, N. 29
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
(istituita con legge 30 maggio 2014, n. 82)
(composta dai deputati: Fioroni Giuseppe, Presidente; Bazoli Alfredo, Bolognesi Paolo, Carra Marco, Cominardi Claudio, Cozzolino Emanuele, D'Alessando Luca, Distaso Antonio, Epifani Ettore Guglielmo, Galli Carlo, Garofalo Vincenzo, Garofani Francesco Saverio, Grande Marta, Grassi Gero, Guerini Lorenzo, Kronbichler Florian, Segretario, La Russa Ignazio, Lavagno Fabio, Minnucci Emiliano, Palladino Giovanni, Pastorelli Oreste, Pes Caterina, Piepoli Gaetano, Vicepresidente, Pini Gianluca, Pisicchio Pino, Pizzolante Sergio, Preziosi Ernesto, Sisto Francesco Paolo, Spessotto Arianna, Squeri Luca; e dai senatori: Bencini Alessandra, Buemi Enrico, Caliendo Giacomo, Cervellini Massimo, Compagna Luigi, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Di Biagio Aldo, Di Giorgi Rosa Maria, Fornaro Federico, Segretario, Gasparri Maurizio, Giovanardi Carlo, Gotor Miguel, Lepri Stefano, Liuzzi Pietro, Lucidi Stefano, Manconi Luigi, Mangili Giovanna, Maturani Giuseppina, Migliavacca Maurizio, Montevecchi Michela, Morra Nicola, Naccarato Paolo, Pagliari Giorgio, Sposetti Ugo, Stefani Erika, Tarquinio Lucio Rosario Filippo, Vicepresidente, Tronti Mario).
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
(Relatore: Giuseppe Fioroni, Presidente)
Approvata dalla Commissione nella seduta del 6 dicembre 2017
Comunicata alle Presidenze il 7 dicembre 2017
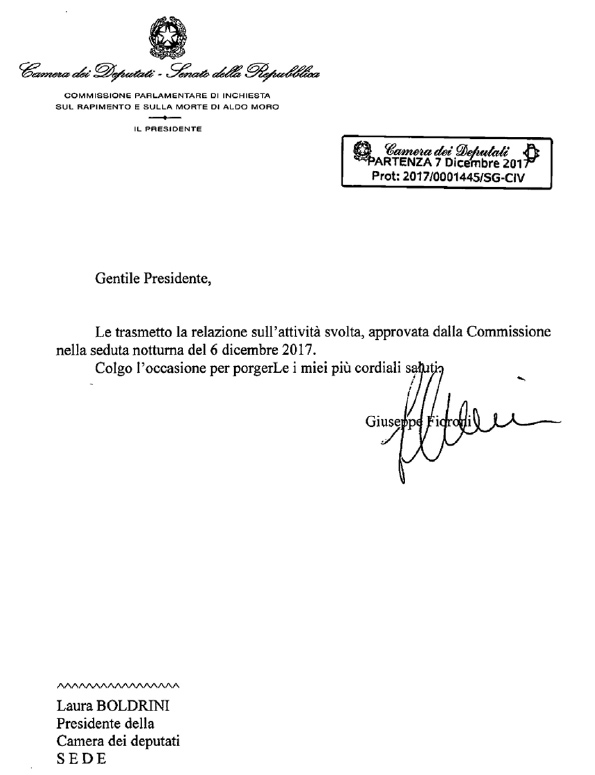
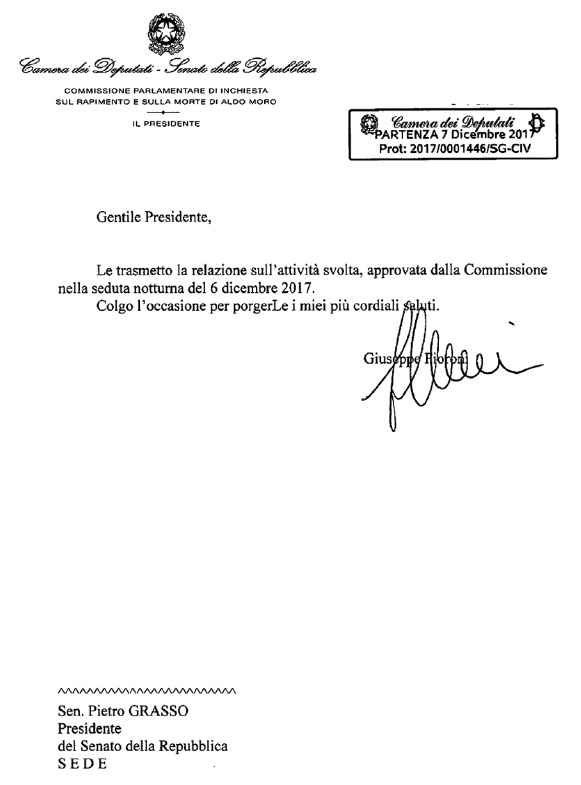
INDICE
| I. Istituzione, costituzione e attività istruttorie della Commissione | Pag. | 9 |
| 1. Elementi normativi | » | 9 |
| 2. Assetto organizzativo | » | 10 |
| 3. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta | » | 11 |
| 4. Le audizioni | » | 13 |
| 4.1. Il programma delle audizioni | » | 13 |
| 4.2. Le audizioni ed ex appartenenti alle Brigate rosse | » | 14 |
| 4.3. Le audizioni di investigatori (magistrati ed ex appartenenti alle forze di Polizia) | » | 39 |
| 4.4. Le audizioni di esponenti politici | » | 58 |
| 4.5. Le audizioni di periti | » | 66 |
| 4.6 Le audizioni di appartenenti a Servizi di sicurezza e a Reparti speciali | » | 71 |
| 4.7. Le altre audizioni | » | 78 |
| II. I principali filoni di indagine sviluppati e le risultanze | » | 93 |
| 5. Premessa | » | 93 |
| 6. Il «memoriale Morucci» | » | 93 |
| 6.1 Ulteriori accertamenti sulla latitanza di Morucci e Faranda | » | 94 |
| 6.2 L'arresto di Morucci e Faranda | » | 98 |
| 6.3. L'elenco dei 94 nomi | » | 107 |
| 6.4 Il «memoriale Morucci» e la sua genesi | » | 110 |
| 6.5 La diffusione del «memoriale» | » | 129 |
| 6.6 Conclusione | » | 138 |
| 7. Il sequestro Moro, le Brigate rosse, i palestinesi | » | 140 |
| 7.1. L'attività della fonte «Damiano» | » | 146 |
| 7.2. Intorno al sequestro Moro | » | 154 |
| 7.3. Conclusione | » | 167 |
| 8. Approfondimenti su Alessio Casimirri | » | 169 |
| 8.1. Premessa | » | 169 |
| 8.2. Il cartellino fotosegnaletico del 4 maggio 1982 | » | 172 |
| 8.3. Accertamenti sulla latitanza di Alessio Casimirri | » | 176 |
| 8.4. La missione SISDE del 1993 | » | 190 |
| 9. Iniziative per la liberazione di Moro e tentativi di recuperare scritti dello statista | » | 198 |
| 9.1. La testimonianza del maresciallo Incandela | » | 199 |
| 9.2. Ulteriori presenze in via Monte Nevoso | » | 211 |
| 9.3. Altri percorsi per liberare Moro: le dichiarazioni di Umberto Giovine e Aldo Bonomi | » | 212 |
| 9.4. Ulteriori accertamenti sulla «trattativa» della Santa Sede. | » | 216 |
| 9.5. La visita di un sacerdote ad Aldo Moro durante la prigionia e le affermazioni di Michele Galati | » | 219 |
| 9.6. La proposta di grazia in favore di Paola Besuschio | » | 221 |
| 10. I covi e la morte di Moro | » | 225 |
| 10.1. Accertamenti sul covo di via Gradoli | » | 225 |
| 10.2. Accertamenti sul covo di via Montalcini | » | 229 |
| 10.3. Gli esami tecnici del RIS | » | 231 |
| 11. Il covo di via Fracchia e la possibile presenza di carte di Moro a Genova | » | 238 |
| 11.1. Il covo di via Fracchia | » | 239 |
| 11.2. I tempi e i modi del rinvenimento della documentazione in via Fracchia | » | 245 |
| 11.3. La ricerca dei documenti | » | 247 |
| 11.4. La telefonata notturna al «Corriere mercantile» | » | 248 |
| 11.5. Le dichiarazioni del Pubblico ministero Maffeo | » | 249 |
| 11.6. Le dichiarazioni di Luigi Carli e i successivi approfondimenti | » | 250 |
| 12. Le indagini su un possibile covo nell'area della Balduina | » | 255 |
| 12.1. L'abbandono delle auto dei brigatisti | » | 256 |
| 12.2. Le indagini in area e la fonte della Guardia di finanza | » | 259 |
| 12.3. Le palazzine di via Massimi 91 | » | 261 |
| 12.4. La pubblicazione di Di Donato | » | 263 |
| 12.5. La latitanza di Gallinari in via Massimi | » | 266 |
| 13. Considerazioni conclusive | Pag. | 268 |
I. Istituzione, costituzione e attività istruttorie della Commissione
1. Elementi normativi
La legge istitutiva della Commissione (legge 30 maggio 2014, n. 82) ha assegnato alla stessa il compito di accertare (articolo 1):
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;
b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.
La medesima legge ha stabilito per la Commissione un termine di ventiquattro mesi dalla propria costituzione, termine entro il quale è chiamata a presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini condotte (articolo 2, comma 1).
Tale termine è stato prorogato al termine della XVII legislatura dall'art. 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21.
Nulla è stato innovato in relazione alla disciplina relativa all'organizzazione dei lavori, contenuta nella citata legge n. 82 del 2014.
Per quanto attiene alla dotazione finanziaria della Commissione, essa è pari a 17.500 euro per gli anni 2014 e 2016 e a 35.000 euro per l'anno 2015. Grazie alla linea di assoluta sobrietà che la Commissione ha adottato non sono state richieste integrazioni per l'anno 2017.
2. Assetto organizzativo
Con riferimento alle collaborazioni esterne, la legge istitutiva (articolo 7, comma 3) affida al regolamento interno il compito di stabilire il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.
La Commissione ha scelto di avvalersi esclusivamente di collaborazioni a titolo gratuito, senza fissare un tetto e adeguando il numero delle collaborazioni esterne alle necessità dell'inchiesta.
Sino alla data di presentazione del presente documento sono stati conferiti ventisei incarichi di collaborazione, tutti a titolo gratuito: tre ufficiali di collegamento con le forze di polizia (Laura Tintisona, primo dirigente della Polizia di Stato, Leonardo Pinnelli, colonnello dei Carabinieri, Paolo Occhipinti, colonnello della Guardia di finanza), sette magistrati (Gianfranco Donadio, Guido Salvini, Antonietta Picardi, Massimiliano Siddi, Antonia Giammaria; Paolo D'Ovidio e Carlo Mastelloni) e quindici tra esperti in discipline di interesse e ufficiali di polizia giudiziaria (i generali dei Carabinieri della riserva Giovanni Bonzano, Pellegrino Costa e Paolo Scriccia; il tenente colonnello dei Carabinieri Massimo Giraudo; il maggiore dei Carabinieri Gabriele Di Prete; i marescialli Marco Mezzetti e Danilo Pinna, appartenenti all'Arma dei carabinieri; i sostituti commissari della Polizia di Stato Maurizio Sensi e Cinzia Ferrante; il sovrintendente della
Polizia di Stato in quiescenza Pier Salvatore Marratzu; il dottor Angelo Allegrini; il professor Sabino Aldo Giannuli; l'avvocato Nunzio Raimondi; il maggiore Paride Minervini e il sottufficiale dei Carabinieri Pasquale Cicalese).
Tutti i suddetti incarichi sono a tempo parziale, ad eccezione degli incarichi affidati ai tre ufficiali di collegamento e al dottor Donadio, che sono a tempo pieno.
A tutti i collaboratori si applicano i criteri stabiliti nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, del 15 aprile 2015, in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno della Commissione.
3. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta
Come previsto dalla legge istitutiva, la Commissione ha assunto come principale finalità la individuazione di nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta.
Finalità della Commissione non è, dunque, quella di operare una completa riscrittura della vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro, che è stata del resto oggetto di più processi, ma di far emergere, per quanto possibile a quarant'anni dagli eventi, aspetti non approfonditi o approfonditi in maniera carente, e, eventualmente, specifiche responsabilità in merito.
Le cospicue ricerche documentali e le attività di indagine delegate hanno consentito, come già sottolineato nelle precedenti relazioni, di approfondire percorsi investigativi a suo tempo non adeguatamente valorizzati e di arrivare a chiarire diversi, importanti, aspetti della vicenda Moro, come sarà meglio specificato nel corpo della relazione.
Il complessivo riesame della documentazione processuale e di inchiesta ha consentito di individuare la presenza di piste investigative non adeguatamente valorizzate nelle indagini svolte a suo tempo e di avviare una complessiva riconsiderazione della vicenda Moro, sia attraverso approfondimenti di tipo documentale sia tramite l'acquisizione di nuove testimonianze sia anche tramite l'impiego, nelle indagini, di moderne tecnologie e nuove tecniche di indagine, non disponibili in precedenza.
I principali risultati conseguiti negli anni precedenti sono stati già esposti nelle precedenti relazioni. Questa relazione li assume per acquisiti e li completa con le ulteriori indagini compiute nel corso dell'ultimo anno di attività, che hanno portato significative acquisizioni in molteplici ambiti. Essa non si presenta pertanto come una relazione complessiva, ma deve essere letta insieme alle due precedenti. Proprio il complesso delle tre relazioni disegna una complessiva revisione di diversi aspetti della vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro.
Proprio i numerosi elementi emersi, anche in tempi recenti, hanno indotto la Commissione a programmare un proseguimento delle attività di indagine anche nei mesi successivi, fino al termine della legislatura.
Si segnala, infine, che la Commissione ha mantenuto, nello svolgimento dell'inchiesta, un rapporto di stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Tale collaborazione si è realizzata soprattutto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e con la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma - ciascuna delle quali è tuttora titolare di indagini concernenti il caso Moro - e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, per i temi relativi a un possibile ruolo della 'ndrangheta nella vicenda Moro.
Le attività istruttorie svolte dalla Commissione possono ricondursi a tre principali tipologie:
a) acquisizioni documentali;
b) accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia;
c) libere audizioni.
Per quanto attiene le acquisizioni, l'articolo 5 della legge istitutiva attribuisce alla Commissione la facoltà di disporre l'acquisizione di atti e documenti:
a) relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
b) relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3);
c) custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione (comma 5).
Sulla documentazione così acquisita, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto (comma 4).
La Commissione, avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria che le sono attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione e confermati dall'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva può, infine, disporre l'esibizione e l'acquisizione di documenti formati o custoditi da soggetti privati.
Nel complesso la documentazione acquisita ammonta a 2.250 unità documentali, per un totale di 700.000 pagine.
Tale patrimonio documentale - sulla base di quanto disposto al n. 2) della deliberazione di acquisizione e informatizzazione di atti e documenti approvata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 ottobre 2014 - è stato integralmente digitalizzato e indicizzato a cura del personale del Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché del personale del medesimo Nucleo addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.
Per quanto riguarda gli accertamenti delegati a collaboratori della Commissione o a strutture di polizia.
Complessivamente, sino alla data di approvazione della presente relazione sono stati affidati oltre 440 incarichi e sono stati svolte 256 escussioni, delegate a collaboratori della Commissione.
Gli accertamenti delegati sono di varia natura. Statisticamente il maggior numero di essi ha riguardato l'assunzione di informazioni testimoniali da persone al corrente dei fatti o approfondimenti documentali, anche finalizzati all'acquisizione di atti. A queste due tipologie si aggiunge l'esecuzione di accertamenti tecnici, anche irripetibili, delegati alla Polizia scientifica o al RIS di Roma.
Per quanto attiene alle attività, si ricorda infine che nel complesso sono state svolte 164 sedute plenarie e 130 riunioni dell'ufficio di presidenza, per complessive 251 ore e 15 minuti, ai quali si aggiungono 7 ore e 40 minuti di audizioni svolte nel corso di missioni.
4. Le audizioni
4.1. Il programma delle audizioni
Nel periodo di riferimento, la Commissione ha orientato il programma di audizioni in base all'evoluzione delle indagini in corso, in maniera da disporre prontamente di elementi utili all'inchiesta.
Si segnala che, in diversi casi, persone che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto di ascoltare in audizione hanno preferito declinare l'invito della Commissione, ritenendo di non voler aggiungere nulla a quanto già in atti o comunicando di non essere in condizioni fisiche tali da poter partecipare ad un'audizione.
Analogamente alle precedenti due relazioni approvate dalla Commissione, sono presentate in questa sezione le sintesi delle audizioni svolte nel terzo anno di attività, eccetto quelle interamente secretate: quella di Armando Sportelli, svolta a Taranto da una delegazione della Commissione il 16 maggio 2017, quella di Pietro Modiano, svolta il 5 settembre 2017, e le due sedute dedicate ad "esame testimoniale di persona informata dei fatti" (25 luglio e 14 settembre 2017).
4.2 Le audizioni di ex appartenenti alle Brigate rosse
Le audizioni di ex militanti delle Brigate rosse hanno riguardato uno dei capi storici già detenuti all'epoca del sequestro Moro, Alberto Franceschini, dirigenti e appartenenti alla colonna romana (Valerio Morucci, Adriana Faranda, Raimondo Etro, Walter Di Cera), e, infine, un importante militante genovese, Enrico Fenzi.
Nelle sedute del 27 ottobre 2016 e del 26 gennaio 2017 si è svolta l'audizione di Alberto Franceschini.
Nella prima delle due sedute, Franceschini, riguardo al sequestro Moro, ha affermato che, in carcere, i capi storici delle BR avevano la consapevolezza che «qualcosa di grosso» si stava preparando, ma non conoscevano né l'obiettivo né le modalità; pensavano che potesse essere un sequestro, ma quando giunse la notizia del rapimento di Moro, si stupirono della capacità «tecnico-militare».
Franceschini ha dichiarato che i rapporti con i brigatisti all'esterno erano tenuti tramite gli avvocati Edoardo Arnaldi e Sergio Spazzali e, nella seduta del 26 gennaio 2017, ha aggiunto: «Loro stessi ci dicevano che avevano un rapporto diretto con alcuni compagni che stavano fuori [...]. Io non so quanto poi i discorsi che facevamo noi con questi avvocati influenzarono l'attività dei compagni fuori». L'avvocato Giannino Guiso, invece, durante il sequestro Moro, «affermava che quello che diceva l'aveva concordato con Craxi». A Guiso, secondo Franceschini, lui e gli altri dirigenti delle BR detenuti dissero che una base per la trattativa poteva essere la chiusura del carcere dell'Asinara. L'audito ha ricordato che, comunque, i brigatisti reclusi cercarono di non farsi coinvolgere nella vicenda Moro, anche perché avevano presente la morte, l'anno precedente, di alcuni terroristi tedeschi detenuti: «Avevamo chiaro
che, se quelli fuori avessero ucciso Moro, probabilmente noi saremmo stati uccisi».
Ha poi riferito che varie persone - don Cesare Curioni, Franca Rame (a nome anche di Renato Dell'Andro) - andarono a trovarli in carcere, tutti sostanzialmente recando il messaggio: «Liberate Moro senza condizioni. [...] Non libereranno mai i compagni di cui voi richiedete la liberazione. [...] Liberate Moro e poi dopo si vedrà».
Il Presidente ha chiesto all'audito come si conciliava la loro richiesta di alleggerimento delle condizioni di detenzione con gli attentati agli agenti di custodia. Franceschini ha risposto che ciò corrispondeva all'idea di innalzare continuamente il livello dello scontro per ottenere quanto richiesto, fino al punto in cui «qualcuno dei due contendenti sarebbe crollato».
L'audito ha affermato che Curcio e lui, dal 1976 in poi, avevano un atteggiamento critico verso la linea delle BR, che a loro giudizio era estremista e aveva «abbandonato il terreno del movimento».
Il senatore Fornaro ha richiamato le affermazioni di Duccio Berio, secondo cui la divisione avvenuta nel 1970 era tra chi (Curcio, Franceschini, Cagol) era per il passaggio alla clandestinità e alla violenza e chi (il cosiddetto Superclan) non voleva seguirli su quella via. Franceschini ha detto di non ritenere molto credibile tale ricostruzione, individuando la differenza piuttosto nel desiderio degli appartenenti al secondo gruppo di sviluppare lo spirito comunitario, anche sulla base di novità che venivano dagli Stati Uniti, mentre quelli del primo gruppo (incluso lui stesso) privilegiavano la teoria marxista-leninista e volevano la costruzione del «partito comunista combattente».
Di Corrado Simioni, l'audito ha detto che i primi rapporti con lui risalivano al 1968-69, quando Simioni proponeva di fare un quotidiano del «movimento», facendo intendere di avere il denaro necessario. Ha inoltre aggiunto che Simioni affermava che «c'erano due parlamentari che erano infiltrati, da parte loro, all'interno del Parlamento dell'epoca», ma non ne faceva i nomi. Secondo l'audito, ciò che Simioni cercava di far capire era: «Se volete fare la rivoluzione, dovete scendere a dei compromessi». Nella seduta del 26 gennaio 2017 ha aggiunto, sempre in riferimento a Simioni: «Lui mi ha educato. Se io non avessi avuto un incontro con lui, non so se avrei... [...] L'incontro con lui per me è stato fondamentale. Mi diede quelle basi teoriche minime innovative che in qualche modo davano un senso a quello che noi volevamo fare».
Della scuola di lingue Hypérion l'audito ha detto di aver saputo solo più tardi e ha ricordato che Vanni Mulinaris, quando fu arrestato, incontrò in carcere Renato Curcio, al quale disse di essere innocente. Sui rapporti tra Simioni e Moretti, ha affermato che «erano anche conflittuali, però certamente Simioni stimava Moretti». Successivamente ha riferito che, in un dibattito con il generale Inzerilli, questi gli disse che il punto chiave era l'Hypérion spiegandogli che era una «camera di compensazione tra i vari Servizi».
Franceschini ha osservato poi, sempre rispondendo al senatore Fornaro, che se per il sequestro Sossi (che non era scortato) furono impiegate dalle BR complessivamente diciotto persone (sei eseguirono materialmente il rapimento, altre tre che presero in consegna l'ostaggio per trasportarlo al luogo di prigionia e le rimanenti nove erano nei dintorni, pronte a intervenire in caso di necessità). Pertanto il numero di persone coinvolte per l'agguato di via Fani - secondo la ricostruzione di Morucci - appare evidentemente molto esiguo.
Il senatore Gasparri ha chiesto, facendo riferimento al libro di Francschini Mara, Renato e io, e in particolare al primo capitolo (Il filo rosso), cosa pensasse delle ricostruzioni che, con eccessi di dietrologia, tentano di togliere alle Brigate rosse la «paternità» degli avvenimenti dei quali furono protagoniste, incluso il sequestro e l'assassinio di Moro. L'audito ha affermato di aver scritto il libro per dire «chi eravamo veramente» e ha espresso l'opinione che il problema principale non sia la dietrologia e che occorra fare una lettura «geopolitica» del terrorismo, anche quello di destra, nel contesto della guerra fredda. Ha quindi rievocato la «mitologia» nata nel 1945-47, la propria formazione comunista e l'atteggiamento che in quell'ambito esisteva verso la democrazia («Non eravamo certamente dei democratici»). Ha ricordato che dopo il sequestro Sossi, l'intenzione
era di sequestrare Andreotti e che egli immaginava, all'epoca, la foto che gli avrebbero fatto, mettendogli un rospo in bocca, perché pensava al rospo che i comunisti avevano dovuto ingoiare nel 1948, quando avevano perso le elezioni. Ha rievocato anche il clima che esisteva dal 1968, con «un movimento di lotta e di liberazione che ha riguardato veramente tutto il mondo» e ha affermato che il primo gruppo straniero con cui le BR ebbero rapporti era la RAF tedesca, fino al 1972 (in seguito ripresi col Movimento 2 giugno, pure tedesco), e poi con l'«arcipelago» palestinese; ha ricordato che il Mossad aveva cercato di avvicinare le BR, che rifiutarono, e che mentre Giangiacomo Feltrinelli sosteneva che occorresse allearsi con i Paesi del «campo socialista» (con i quali lo stesso Feltrinelli intratteneva rapporti), le BR ritenevano che la rivoluzione dovesse essere fatta in Italia («Da questo punto di vista eravamo dei
togliattiani»).
Franceschini ha osservato che nel 1976 le BR erano praticamente finite e che erano rimasti in libertà pochissimi brigatisti, ma che proprio allora venne sciolto il nucleo speciale del generale Dalla Chiesa e poi, per due o tre anni, non avvennero arresti significativi.
Riguardo a Francesco Marra, l'audito ha detto che, a suo giudizio, era un infiltrato dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, e ha ricordato che Marra (che poi lasciò le BR all'inizio del 1975) e Moretti votarono a favore dell'uccisione di Mario Sossi.
In merito ai documenti del Centro di resistenza democratica (CRD) di Edgardo Sogno, portati via dai brigatisti durante un'irruzione alla sede del CRD nel 1974, Franceschini ha affermato che contenevano, tra l'altro, un elenco di oltre mille nomi di persone; quando furono arrestati, Franceschini e Curcio avevano con loro quella documentazione, che però poi sparì.
Rievocando la nota vicenda dell'arresto suo e di Curcio, e della circostanza che Moretti, pur essendo stato avvisato della loro possibile cattura con tre giorni di anticipo, non li avvertì, Franceschini ha affermato di non voler accusare Moretti, ma ha aggiunto che, in seguito a questo episodio, sorsero dei sospetti: «Il primo che mi ha detto che, secondo lui, Moretti era un infiltrato è stato Curcio». Ha riferito che le BR fecero un'«istruttoria» su Moretti (a sua insaputa), condotta da Bonosoli e Azzolini, i quali conclusero che era «pulito». L'audito ha espresso l'opinione che Moretti non fosse una spia, ma che «avesse giocato le sue carte in un certo contesto», aggiungendo: «La contraddizione tra me e Moretti è sempre stata sui compromessi. Io non ero d'accordo sul fare certi compromessi». Ha ulteriormente precisato che la sua critica a Moretti è di natura
politica, attribuendogli la responsabilità di «aver distrutto, in base [...] a una linea politica assolutamente sballata, tutta un'ipotesi politica».
Nella seduta del 26 gennaio 2017, Franceschini, rispondendo a una domanda del Presidente, ha affermato di non aver mai avuto contatti con Khoury Ali (cioè Ronald Stark), ma di aver saputo che Curcio lo aveva incontrato, in carcere.
Tornando al sequestro Moro, Franceschini ha detto che «mentre i compagni fuori soprattutto dicevano che il senso del sequestro e di tutte le loro attività era quello di processare la Democrazia cristiana [...] noi invece sostenevamo che il discorso era l'attacco al compromesso storico»,
Riguardo ad Aldo Bonomi, l'audito ha dichiarato di averlo conosciuto nel 1972: «Era uno che forniva informazioni. [...] Su di lui ci furono una serie di chiacchiere e di giudizi da parte soprattutto [...] degli ambienti anarchici, che dicevano di stare attenti perché era un personaggio bivalente e pericoloso».
Franceschini ha poi risposto a una domanda sull'appartamento di Firenze nel quale si riuniva il comitato esecutivo delle BR al tempo del sequestro Moro, affermando: «Da discorsi che si facevano tra noi eccetera, ebbi la sensazione precisa che certamente a Firenze c'era un luogo importante». Ha proseguito dicendo che su Firenze nessuno dei brigatisti da lui conosciuti ha mai detto nulla e che Moretti, in particolare, diceva che Firenze «non c'entrava niente», aggiungendo che tale atteggiamento lo insospettì.
L'audito ha affermato che Senzani - da lui mai conosciuto allora - era in rapporto con le BR già prima del sequestro Moro e ha detto di aver avuto l'impressione che nel testo della "direzione strategica" reso pubblico durante il periodo del sequestro Moro ci fosse anche la mano di Senzani.
Rispondendo a una domanda dell'onorevole Bolognesi su eventuali sistemi anti-infiltrazione adottati dalle BR, Franceschini ha detto che la compartimentazione serviva appunto a questo scopo, facendo sì che ciascuno conoscesse solo alcune informazioni. A una domanda sui motivi per i quali nel 1972 fu respinta la richiesta di Morucci di entrare nelle BR, l'audito ha risposto che il primo motivo era che «a me e ad altri non piaceva Morucci. Era un personaggio che per noi non era molto affidabile»; ha aggiunto che invece Moretti era favorevole a far entrare Morucci nelle BR.
In risposta a domande del senatore Fornaro, Franceschini ha affermato che Riccardo Dura, da lui mai conosciuto, era legatissimo a Moretti.
L'audito, infine, ha osservato che mentre nella prima fase del sequestro Moro i rapitori fecero sapere che Moro stava parlando, poi affermarono che non aveva detto nulla. Ha rilevato anche che dal giorno del ritrovamento del covo di via Gradoli l'atteggiamento delle BR verso i brigatisti detenuti cambiò: «Quelli fuori [...] fanno sapere a noi dentro: "Ci dispiace, non possiamo tirarvi fuori". [...] Poi [...] a noi non dissero più nulla».
Il 17 gennaio 2017 la Commissione ha svolto l'audizione di Valerio Morucci, che preliminarmente ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere a domande inerenti a fatti per i quali era stato imputato. Il presidente della Commissione ha chiarito che Valerio Morucci veniva ascoltato in sede di libera audizione, non di esame testimoniale, e che quindi era libero di rispondere o meno a qualsiasi domanda postagli.
Alla prima domanda, riguardante il numero di persone coinvolte nelle attività connesse all'agguato di via Fani, Morucci ha osservato che la Commissione, a suo avviso, poteva disporre di tutto il materiale necessario, poiché egli aveva già deposto sia in numerosi processi sia presso due precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta, e aveva inoltre scritto libri e articoli, nonché concesso interviste; per tale motivo non ha risposto al quesito. Analogo atteggiamento Morucci ha tenuto durante l'audizione riguardo a numerose altre domande postegli dal presidente, dichiarando di non voler rispondere e, spesso, aggiungendo (non di rado in tono polemico) di aver già dato abbondanti risposte in sede giudiziaria alle stesse domande. Ha anche affermato che l'audizione era posta «in termini inquisitoriali».
Rispondendo a un quesito sulla collaborazione con le BR di medici o infermieri in funzione di "copertura medica" in occasione di azioni cruente (pratica riferita da Prospero Gallinari nel volume Un contadino nella metropoli) e sulla possibilità che i brigatisti avessero pensato all'utilità di una simile "copertura" per l'agguato del 16 marzo 1978 (ad esempio nel caso che Aldo Moro rimanesse ferito nella sparatoria), Morucci ha risposto che le BR non si posero il problema.Riguardo alla possibilità che il nome di un intermediario per le comunicazioni con la famiglia Moro fosse stato indicato alle BR dalla signora Eleonora Moro - come aveva affermato monsignor Antonio Mennini nell'audizione del 9 marzo 2015, basando il suo ricordo su una telefonata fattagli da Morucci (il "professor Nicolai") - Morucci ha affermato che doveva trattarsi di un intermediario indicato da Aldo Moro, non dalla moglie.
In riferimento a ulteriori domande, Morucci ha affermato che delle lettere di Moro, durante il sequestro, esistevano soltanto gli originali e le relative fotocopie, ma non esisteva alcuna versione dattiloscritta.
All'audito è stata poi riferita la notizia - riferita in un rapporto da Beirut del 21 giugno 1978 del colonnello Stefano Giovannone - secondo cui le Brigate rosse avrebbero trasmesso a George Habash (capo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina) copia di dichiarazioni rese da Moro durante il sequestro, per ristabilire un rapporto di collaborazione che nei due anni precedenti era venuto meno. Morucci, dopo aver affermato di non sapere nulla al riguardo, ha obiettato che la notizia riferita da Giovannone risulterebbe in contraddizione con la circostanza, secondo lui certa, che i rapporti tra BR e palestinesi iniziarono solo dopo la vicenda Moro e che quindi a giugno del 1978 non poteva esserci alcun rapporto precedente da ristabilire.
Il presidente ha quindi informato Morucci che la Commissione aveva accertato che un informatore aveva permesso alla Polizia, nel maggio del 1979, di individuare l'appartamento di viale Giulio Cesare nel quale si erano rifugiati lui e Adriana Faranda, causandone così la cattura. Il presidente ha specificato che l'informatore era uno dei tre gestori di un autosalone in zona Portuense (AutoCia), presso il quale negli anni precedenti Adriana Faranda aveva acquistato due automobili; uno dei tre gestori dell'autosalone, inoltre, risultava in rapporti di conoscenza con Morucci fin dall'infanzia. Morucci ha replicato di non aver nulla da dire al riguardo. In momenti successivi dell'audizione, però, ha affermato di non aver mai saputo fino a quel momento chi lo aveva "tradito" e che la rivelazione gli aveva procurato «un certo shock».
Il presidente ha proseguito indicando che alcuni reperti trovati a suo tempo nell'abitazione di viale Giulio Cesare facevano ipotizzare un possibile coinvolgimento dei gestori della società AutoCia nella contraffazione di documenti per auto da usare nelle attività delle BR. Morucci ha dapprima risposto: «Non gradisco questo tipo di impostazione d'indagine». Quindi ha sostenuto che le BR nel periodo del sequestro Moro già da tempo non usavano più auto nei loro spostamenti, bensì mezzi pubblici, e che nelle azioni, notoriamente, erano utilizzati veicoli rubati per i quali non occorreva procurarsi documenti contraffatti. Riguardo ai documenti automobilistici trovati nell'appartamento di viale Giulio Cesare, Morucci ha affermato di non avere idea del perché fossero lì.
Il presidente ha poi chiesto all'audito spiegazioni su un altro documento trovato nell'abitazione di viale Giulio Cesare: due fogli contenenti un elenco di nomi di appartenenti alle Brigate rosse (incluso quello di Morucci stesso) e di altre persone, incluse anche alcune identità di copertura usate da alcuni brigatisti. Morucci ha risposto che era impossibile che un simile elenco fosse in possesso suo o di Adriana Faranda e ha osservato che nel verbale di sequestro non risulta indicato se i due fogli fossero stati trovati tra le carte e gli oggetti suoi e della Faranda o in altro luogo dell'appartamento.
Rispondendo al senatore Federico Fornaro sulla dinamica dell'agguato di via Fani, Morucci ha affermato che ci fu un tamponamento tra l'auto in cui viaggiava Aldo Moro e la Fiat 128 dei brigatisti e ha negato che occorresse una particolare perizia per colpire i due carabinieri che sedevano nei sedili anteriori della Fiat 130 senza ferire l'onorevole Moro, in quanto, a suo dire, la distanza tra gli sparatori e i due uomini era molto ridotta (due metri). Ha inoltre precisato che vennero sparate raffiche, non colpi singoli, e che, a suo parere, il movimento di torsione compiuto dal maresciallo Leonardi aveva lo scopo di proteggere Moro. Ha inoltre ribadito che si sparò dal lato sinistro rispetto alle auto. Al senatore Fornaro, che chiedeva perché, quando Moro fu portato via, nell'auto c'era un solo brigatista accanto al sequestrato - anziché due (uno per lato) come sarebbe stato più sicuro, per evitarne tentativi di fuga - Morucci
ha replicato che l'onorevole Moro era stato rapito dopo una sanguinosa sparatoria e che la sua condizione psicologica, in quei momenti, era tale da renderne pressoché impossibile un tentativo di fuga. Ha quindi specificato che Moro venne collocato sdraiato sul sedile posteriore, con una coperta sopra.
Valerio Morucci si è quindi soffermato sul tema dell'attendibilità dei testimoni, citando studi secondo i quali essa sarebbe scarsamente affidabile in numerosi casi.
Rispondendo al presidente, l'audito ha poi escluso che nel cosiddetto "memoriale Morucci" siano presenti ricordi erronei, anche se poco più tardi, in risposta a un'altra domanda, non ha escluso che possano esserci discordanze tra il "memoriale" e la realtà.
Il senatore Gotor ha domandato a Morucci se, a distanza di tanti anni, non ritenga di avere, nel riferire le vicende alle quali ha partecipato, maggior libertà e minori condizionamenti rispetto a quando era un imputato che rischiava l'ergastolo. L'audito ha risposto di no, affermando di aver fornito elementi ai magistrati quando aveva già subito una condanna all'ergastolo e sottolineando che quanto da lui narrato allora confermava le sue responsabilità e la giustezza della condanna ricevuta; ciò, a suo parere, dimostrava che già allora nel parlare era libero da condizionamenti dovuti al timore di una condanna.
Il senatore Maurizio Gasparri ha chiesto all'audito un'opinione sulle diverse ricostruzioni secondo le quali le Brigate rosse erano eterodirette. Morucci ha risposto dicendo di aver affrontato il tema anni prima in una lunga intervista al quotidiano «l'Unità» e aggiungendo: «Secondo lei chi aveva interesse ad agitare un fumus sul fatto che le Brigate rosse non fossero una banda armata di comunisti?».
L'onorevole Gero Grassi è intervenuto per affermare che non era accettabile che Morucci dicesse quel che gli piaceva e non rispondesse alle domande che gli risultavano sgradevoli. Pertanto, l'onorevole Grassi ha chiesto che, prima di decidere un eventuale prosecuzione dell'audizione in una seduta successiva, ne venissero chiarite le modalità di svolgimento. Il presidente ha osservato che, sia ascoltando Morucci in libera audizione, sia ascoltandolo in sede testimoniale, non era tenuto a fornire risposte, nei casi in cui non avesse inteso darne; ha quindi proposto di proseguire l'audizione in una successiva seduta. Valerio Morucci ha però dichiarato l'intenzione di non rispondere ad ulteriori domande e l'audizione perciò si è conclusa senza continuare in altre sedute.
Nella seduta del 31 gennaio 2017 si è svolta l'audizione di Raimondo Etro, che fu coinvolto in varie attività, legate al sequestro Moro: l'«inchiesta preliminare», a partire dalla fine di settembre o dall'inizio di ottobre del 1977, nella chiesa di Santa Chiara, quando le BR progettavano di compiere lì il rapimento; il furto di autovetture che dovevano essere usate per il rapimento; la custodia delle armi dopo l'azione in via Fani».
Riguardo a Prospero Gallinari, l'audito ha confermato di averlo conosciuto nel giugno o luglio del 1977 e di averlo poi incontrato spesso, ma di non aver mai saputo dove abitasse. Ha ricordato che una volta, verso la fine del 1977, presso il "Ponte bianco" (non lontano da viale Marconi), Gallinari gli disse che si stavano avvicinando alla zona in cui un militante stava predisponendo la struttura in cui sarebbe stato tenuto prigioniero Moro.
Ha affermato che tra i suoi compiti c'era anche quello di verificare presso il Pubblico registro automobilistico a chi fossero intestate alcune targhe; inoltre, ha detto che c'era un blocchetto di tagliandi assicurativi in bianco, che servivano poiché i dati assicurativi dovevano corrispondere alle targhe (rubate).
Circa il suo ruolo in via Fani, Etro ha ricordato che - prima di essere estromesso da qualunque partecipazione attiva alle operazioni delle BR, poiché non era riuscito a sparare al giudice Riccardo Palma e quindi era stata posta in dubbio la sua «determinazione militare» - era previsto che insieme ad Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri dovesse far parte del «gruppo di copertura», incaricato di controllare che non ci fossero persone e di fermare le forze dell'ordine, se fossero sopraggiunte durante l'azione. Ha detto che, invece, non ritiene che fosse stata predisposta una «copertura medica».
Etro ha poi confermato una sua dichiarazione del 2015, circa una frase dettagli da Gallinari riguardo all'impossibilità di una trattativa: «Faremo talmente tanti morti che lo Stato non tratterà mai». In precedenza - ha proseguito Etro - quando si pensava di rapire Moro nella chiesa di Santa Chiara, il progetto prevedeva che gli uomini della scorta fossero soltanto immobilizzati, non uccisi, e quindi ci sarebbe stata maggiore possibilità di una trattativa con lo Stato; ma dopo la metà di gennaio del 1978 Adriana Faranda gli comunicò che Moro non sarebbe stato sequestrato a Santa Chiara, ma in altro luogo. Ha anche confermato un'altra dichiarazione da lui fatta nella stessa intervista del 2015, relativamente al ruolo svolto da Casimirri e Lojacono in via Fani: «Ricordo benissimo che Casimirri mi riferì [...] che si erano inceppati diversi mitra e, quindi, lui e Alvaro Lojacono erano stati
costretti a intervenire. Ricordo perfettamente che Casimirri mi disse che Iozzino era uscito dalla macchina strillando come un'aquila e che loro avevano dovuto sparare. Adesso non ricordo bene se era stato Casimirri o era stato Lojacono». Ha aggiunto, anche in questo caso confermando sue precedenti dichiarazioni, che Casimirri gli riferì che a via Fani era passata una motocicletta con «due cretini» a bordo, ma ha precisato di non poter precisare se Casimirri avesse riconosciuto i due oppure se fossero stati due passanti casuali.
Etro ha ricordato che si aspettava, anche sulla base di ciò che gli aveva detto in precedenza Gallinari, che Moro avrebbe rivelato clamorosi segreti, ad esempio sugli autori della strage di piazza Fontana o della strage del treno Italicus; perciò, dopo l'uccisione di Moro, una volta chiese ad Adriana Faranda se Moro avesse rivelato qualcosa, ma ne ottenne solo una risposta vaga. Ha poi detto di non essere mai stato interpellato sulla scelta se liberare o uccidere Moro, e ha aggiunto di credere che non fossero stati interpellati neanche Casimirri e Algranati.
Riguardo al periodo trascorso a Parigi nel 1982, ha ricordato che Casimirri e Algranati («che erano molto attivi in quel periodo in Francia, perché cercavano una soluzione, che fosse quella nicaraguense o che fosse quella arabo-palestinese») lo spingevano ad andare con loro in Nicaragua e ha affermato di non aver mai sentito parlare allora di Hypérion.
Circa una sua dichiarazione, riportata in un'intervista, secondo cui il padre di Alessio Casimirri sarebbe stato in rapporti di conoscenza e frequentazione con il generale Santovito, l'audito ha detto di non averne mai avuto conoscenza diretta, ma di aver sentito da altri questa notizia. Etro ha specificato di aver frequentato Alessio Casimirri dal 1974 al 1982, quando Casimirri lasciò Parigi, ma di non averne conosciuto la famiglia e di non aver neanche saputo, allora, che il padre fosse il portavoce della Santa Sede. Ha anche ricordato di essere entrato nelle Brigate rosse, insieme a Rita Algranati, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, proprio su invito di Casimirri, che era già entrato in contatto con le BR.
Riguardo a Morucci, l'audito ha affermato che quando entrò nelle BR egli gli apparve un dirigente «che ci stimolava a leggere, a studiare, a fare inchieste»; ha aggiunto che in seguito, uscito dalle BR, cominciò a dubitare sia dell'ideale sia delle persone delle BR e che quando emerse il fenomeno della dissociazione, dapprima lo considerò con favore, ma poi lo giudicò «un movimento di maniera, costruito ad arte, e che Valerio Morucci ha fatto i suoi interessi». Secondo Etro, Morucci dapprima aveva spinto i giovani alla lotta armata, ma poi, dopo l'arresto, «ci ha denunciato tutti in maniera più o meno chiara», perciò ha detto di ritenerlo una persona equivoca. Ha anche affermato che, a suo avviso, Morucci gestì una trattativa «non so con chi» fin dal 1979, che il carcere di Paliano nel 1982 divenne «la nuova sede delle Brigate rosse, gestita da
Savasta» e che Savasta nel 1982 diede indicazione di parlare solo degli omicidi commessi dalle Brigate rosse, non di quelli fatti dal «movimento»; ha ricordato, al riguardo, i numerosi omicidi insoluti, come quelli di Mario Zicchieri e quelli di via Acca Larentia.
Circa i rapporti tra Autonomia e Brigate rosse, Etro ha dichiarato che in quel periodo erano molto conflittuali poiché Autonomia di dedicava ad attacchi contro militanti di destra, obiettivi americani e obiettivi democristiani, però mirava a costruire il cosiddetto «partito rivoluzionario».
La Commissione ha svolto nella seduta del 13 giugno 2017 l'audizione di Enrico Fenzi, entrato nelle Brigate rosse nel 1976 e arrestato a Milano nel 1981 insieme a Mario Moretti.
Fenzi ha affermato di non sapere nulla di preciso sul sequestro Moro, di non essere stato consultato, all'epoca, sulla decisione relativa all'uccisione del presidente del Consiglio nazionale della DC (che, secondo quanto gli venne detto, coinvolse invece tutti i capi colonna) e di non aver avuto nulla a che fare, nel periodo del sequestro, con il comitato esecutivo delle BR. Ha confermato di aver partecipato all'attentato all'ingegner Carlo Castellano, ferito a Genova nel 1977, dichiarando che si era trattato di un coinvolgimento voluto per "comprometterlo" definitivamente con le Brigate rosse; ha affermato di non aver mai partecipato ad altre azioni delle BR.
Sulla "colonna genovese" delle BR, Fenzi ha detto che si muoveva in maniera «largamente autonoma» rispetto all'azione delle BR a livello nazionale. Ha ricordato che il suo "reclutatore" fu Rocco Micaletto e che, successivamente, passò «sotto la tutela» di Luca Nicolotti.
Riguardo ad una dichiarazione da lui resa al primo processo Moro, nel 1982 («Io sono convinto che a via Fani ci fossero anche Nicolotti e Dura»), l'audito ha detto che riguardo a Riccardo Dura la sua convinzione che avesse partecipato all'agguato del 16 marzo 1978 probabilmente derivò dai discorsi tra brigatisti detenuti a Palmi, all'epoca della morte di Dura durante l'irruzione dei Carabinieri nel covo di via Fracchia; ha invece affermato di non ricordare da cosa nascesse la convinzione relativa alla presenza anche di Nicolotti.
Circa un'altra dichiarazione da lui resa al primo processo Moro, relativa alla certezza che fosse stato direttamente Mario Moretti a condurre gli "interrogatori" di Moro, ha spiegato che la sua sicurezza nasceva dal modo col quale Moretti parlava di alcuni comportamenti di Moro: «Ne parlava come di una persona che avesse assistito e fosse stata lì nel momento in cui Moro era prigioniero». Ha anche fatto un esempio, al riguardo, ricordando che Moretti diceva, parlando di Moro: «Durante tutta la prigionia abbiamo parlato molto, ma non ha mai manifestato né una domanda, né una parola, né un pensiero riferiti alla sua scorta»; ha aggiunto che Moretti, sempre con il tono di chi era stato presente, parlava con grande apprezzamento del comportamento lucido, calmo e determinato di Moro durante il periodo del sequestro. Rispondendo a una domanda sulla capacità di Moretti nel condurre l'interrogatorio di
Moro da solo, senza l'aiuto di persone più competenti, Fenzi ha detto che «se c'era uno abbastanza intelligente, era Moretti», il quale, a suo avviso, esprimeva il meglio delle capacità delle BR e non aveva bisogno di altri, anche se non era perfettamente in possesso di tutte le qualità e le conoscenze necessarie per poter gestire una vicenda così complessa come il sequestro di Aldo Moro. Più in generale, in merito ai sospetti che Moretti fosse un infiltrato, Fenzi ha detto di non aver mai avuto motivo di pensarlo e di aver sempre ritenuto che tali accuse fossero false, anche se era al corrente di alcuni profondi rancori che altri (Alberto Franceschini e forse anche Giorgio Semeria) avevano contro Moretti fin da prima del sequestro Moro. Ha espresso, inoltre, l'opinione che all'origine delle diffidenze e dei rancori ci fosse qualche aspetto legato alla figura di Mara Cagol e, più specificamente, alla morte di
quest'ultima, alla cascina Spiotta, nel 1975: «Lì qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sono stati degli errori». Fenzi ha riferito che gli era stato fatto capire che il brigatista che era riuscito a fuggire e che non è stato mai individuato era appunto Moretti.
Fenzi ha affermato che suo cognato Giovanni Senzani, per quanto a lui noto, non ebbe nulla a che fare con il sequestro e l'uccisione di Moro, aggiungendo di non sapere neanche quale fosse, in quel periodo, il livello di coinvolgimento di Senzani nelle BR e di averne scoperto molto tardi l'appartenenza all'organizzazione. A suo avviso, Senzani dapprima può aver svolto un ruolo da "consulente" delle BR, come persona di estrema sinistra esperta del mondo carcerario; in seguito, nelle BR, Senzani si è mosso in maniera «abbastanza autonoma» (avendo, comunque, più rapporti con i brigatisti romani che con quelli dell'Italia settentrionale) per poi staccarsi dall'organizzazione.
Riguardo a ciò che Moro disse ai suoi sequestratori, Fenzi ha espresso l'opinione che Moro avesse detto «cose politicamente molto rilevanti, ma che non erano quelle che le BR si aspettavano, o lungo la linea sulla quale si erano sintonizzate», precisando poi che le BR si attendevano da Moro rivelazioni senza però sapere avere chiarezza su cosa, perciò andavano un po' a tentoni.
Secondo l'audito, per le BR ottenere qualcosa in una trattativa con lo Stato e poi, eventualmente, rilasciare Moro sarebbe stato il massimo successo, che avrebbe sancito la loro preminenza rispetto a tutte le altre forze eversive allora presenti in Italia. Fenzi ha asserito che, per quanto gli risultava, il nucleo storico delle BR, allora in carcere, non ebbe voce in capitolo nel sequestro Moro, anche se era favorevole alla trattativa.
Rispetto alla questione dell'esaustività o meno di ciò che gli ex brigatisti hanno riferito, nel corso degli anni, sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Moro, Fenzi ha detto di ritenere che Moretti «abbia detto ragionevolmente tutto quello che poteva pensare fosse utile dire e che ci siano dei limiti oltre i quali è difficile andare». Ha aggiunto di essere molto critico verso quelle che ha qualificato come «manovre diversive, tentativi di confondere le acque, letteratura fasulla», riferendosi ad esempio all'affermazione che a via Fani erano presenti la 'ndrangheta o i servizi segreti. Ha ulteriormente precisato che, a suo avviso, i brigatisti hanno detto quel che potevano dire per chiarire la dinamica dei fatti e che i punti non chiariti riguardano non le BR, ma semmai i servizi segreti, come la vicenda del falso comunicato del lago della Duchessa.
Sull'affermazione fatta in audizione il 26 aprile 2017 da Michele Riccio, secondo cui i Servizi nell'autunno del 1978 tenevano d'occhio una boutique di abbigliamento in cui lavorava una persona vicina a Fenzi (forse la figlia), questi ha dichiarato che la notizia è inverosimile e deve trattarsi di un errore, anche perché né la sua compagna né sua figlia avevano una boutique.
In merito ai rapporti internazionali di Moretti, l'audito ha risposto che, durante il periodo in cui ebbero occasione di parlarne, Moretti sosteneva di averne avuti («Non mi ha mai voluto dire con chi e in che termini») e poi lasciati; secondo Moretti non era il momento di riallacciarli in quanto pericoloso e inutile, ma aveva comunque la possibilità di riattivarli.
Interrogato sul ferimento di Moretti da parte di un altro detenuto, avvenuto nel carcere di Cuneo nel 1981, Fenzi - che in quell'occasione venne anch'egli ferito - ha detto di ritenere che la causa fosse del tutto estranea a motivi politici o all'azione dei Servizi (come aveva pensato subito dopo l'episodio) e connessa invece dall'attenzione che l'aggressore aveva per un giovane detenuto.
Riguardo ad alcune dichiarazioni del 1982-83 di Michele Galati - secondo cui Fenzi gli aveva confidato che Senzani aveva tentato di stabilire un rapporto con l'onorevole Giacomo Mancini e con ambienti della 'ndrangheta - l'audito ha affermato anzitutto che Galati «faceva il doppio gioco», che si mostrava uno dei detenuti più duri ma al contempo riferiva regolarmente al colonnello Giampaolo Ganzer. Circa il contenuto delle affermazioni di Galati, Fenzi ha affermato che, a suo parere, Senzani aveva rapporti con il senatore Domenico Pittella, non con Mancini, e che era tipico della linea d'azione di Senzani cercare di attirare nell'area dell'eversione e politicizzare alcuni esponenti della delinquenza organizzata. L'audito ha anche ricordato che, quando era detenuto a Paliano, ricevette la visita di due agenti dei Servizi («di cui non voglio dire di più») che lo minacciarono, dicendogli: «Se lei non ci dice entro
domani che l'onorevole Mancini in qualcosa c'entra, troveranno anche lei con la testa tagliata, come il medico Semerari». Ha aggiunto che su Mancini indagava con tenacia soprattutto il giudice Imposimato e che c'era una fortissima pressione per coinvolgere Mancini, che partiva anche da settori del suo stesso partito, il PSI.
Relativamente al rapporto di Moretti con la "colonna genovese", l'audito ha detto di non aver mai considerato questa come la "colonna di riferimento" di Moretti, anche se Moretti aveva un forte rapporto con Micaletto.
Nelle sedute dell'11 luglio, del 19 luglio e del 20 settembre 2017 la Commissione ha svolto l'audizione di Adriana Faranda.
Durante la seduta dell'11 luglio 2017, rispondendo alle domande del presidente, l'audita ha affermato che, per quanto a lei noto, nell'agguato di via Fani non furono impegnate (neanche indirettamente, in funzione di supporto logistico o sanitario) altre persone oltre a quelle note e che non era stato previsto un covo alternativo dove condurre l'onorevole Moro nel caso che non potesse essere raggiunto quello di via Montalcini. Qualora quest'ultimo fosse risultato inagibile, Moro sarebbe stato spostato in uno degli altri covi già in uso da parte delle BR, come quello di via Chiabrera. Riguardo alle lettere di Moro, ha specificato che lei e Valerio Morucci ne consegnarono solo a Roma, non in altre località, né seppero di lettere destinate altrove. Circa il luogo dove andarono ad abitare Mario Moretti e Barbara Balzerani dopo la scoperta del covo di via Gradoli, l'audita ha detto che il primo andò fuori Roma, in altra città
(che non ha saputo indicare), e che quando doveva dormire a Roma probabilmente si fermava a via Montalcini, e la seconda si trasferì nell'appartamento di Borgo Pio dove abitava Bruno Seghetti.
Adriana Faranda ha poi risposto ad alcune domande relative ai contatti con Lanfranco Pace e, per suo tramite, con esponenti del Partito socialista. Ha dichiarato di ritenere che il primo incontro con Pace avvenne in una data successiva al comunicato delle BR in cui si menzionava uno scambio di prigionieri e ha detto che la notizia della ricerca di un contatto arrivò tramite Seghetti. Ha affermato che non vi furono contatti diretti con esponenti del PSI né con Piperno, ma che Pace nominava Claudio Signorile e Antonio Landolfi (come persone che riportavano le posizioni di Craxi, non le loro individuali) e che del contenuto dei colloqui con Pace lei e Morucci riferivano alla direzione della "colonna" romana delle BR, nella quale si svolsero lunghe discussioni al riguardo; ha inoltre precisato che Morucci e lei, negli incontri con Pace, potevano solo riferire le decisioni e l'orientamento delle BR, senza prendere iniziative personali. Ha poi
ricordato che nell'ultimo incontro Pace chiese di aspettare ancora ad eseguire la decisione di uccidere Moro, poiché il senatore Giuseppe Bartolomei avrebbe dovuto fare un intervento pubblico contenente un'apertura alle richieste delle BR (o un annuncio di un'apertura da parte di Fanfani), e che però la dichiarazione di Bartolomei non parve contenere alcuna apertura significativa e ciò provocò una reazione irritata nella direzione della "colonna", che si sentì presa in giro e considerò l'accaduto come un tentativo, da parte delle autorità, di prendere tempo per poter cercare di individuare i rapitori. Secondo Adriana Faranda, Moretti, pur avendo un mandato vincolante del comitato esecutivo delle BR ad uccidere Moro, ne aveva rinviato l'attuazione e aveva atteso fino ad allora, ma dopo la mancata apertura di Bartolomei la situazione precipitò e Moro fu ucciso. Moretti, peraltro, nel ricordo di Adriana Faranda, si
era mostrato sempre scettico rispetto agli esiti dei contatti con il PSI che avvenivano tramite Pace, anche perché il comitato esecutivo - come, in generale, le BR - aveva la convinzione che l'interlocutore dovesse essere la DC, non altre forze politiche.
Riguardo ai luoghi degli incontri con Pace, Adriana Faranda ha sottolineato che non avvenivano mai in case, ma sempre in luoghi pubblici, che consentivano un controllo di quel che accadeva intorno e una rapida fuga in caso di necessità.
Sull'ipotesi di un atto umanitario unilaterale dello Stato, come la grazia a un detenuto, l'audita ha osservato che non era quel che chiedevano le BR, le quali sarebbero state messe in forte crisi da un gesto simile e, a quel punto, difficilmente avrebbero potuto uccidere Moro.
Adriana Faranda ha affermato che l'esito tragico del sequestro di Aldo Moro non era stato deciso fin dall'inizio. Il senatore Fornaro le ha ricordato che altri ex brigatisti avevano affermato il contrario, ma l'audita ha ribadito che non era stato deciso fin dall'inizio di uccidere Moro, anche se era ben chiaro che non sarebbe stato liberato in assenza di contropartite, come invece era accaduto nel caso di Sossi. Ha sostenuto che le Brigate rosse ritenevano che la liberazione senza contropartita avrebbe fatto perdere credibilità all'organizzazione rispetto al movimento rivoluzionario e che le BR volevano che venisse riconosciuta l'esistenza di un problema di prigionieri politici, anche perché lo chiedevano con forza i brigatisti detenuti (che accusavano i brigatisti in libertà di fare poco per coloro che erano in carcere). Adriana Faranda ha anche aggiunto che inizialmente le BR sbagliarono completamente le loro valutazioni,
poiché erano convinte che da parte della DC e dello Stato si sarebbe fatto di tutto per riavere Moro e non si aspettavano l'atteggiamento intransigente che fu assunto, così come non si attendevano che esponenti del PCI dichiarassero che le Brigate rosse erano manovrate da forze nazionali e internazionali. A giudizio dell'audita, i brigatisti (inclusa lei) non erano dotati di grande capacità politica: «Eravamo dei ragazzi un po' sprovveduti, mediamente intelligenti, che avevano fatto una cosa di cui non avevano saputo prevedere in anticipo la portata e le conseguenze».
Riguardo alla consultazione tra i militanti delle BR in merito alla decisione sulla sorte di Moro, Adriana Faranda ha dichiarato di aver personalmente consultato tutti i militanti delle brigate di cui era allora responsabile, come fecero gli altri militanti regolari della colonna romana. L'audita ha ricordato che le si disse che la stessa cosa era avvenuta nelle altre colonne e che, per quanto ne seppe, l'esito fu unanime (con le sole eccezioni di lei stessa e Morucci), nel senso che tutti si espressero per l'uccisione di Moro se non si fosse riusciti a ottenere alcuna contropartita. Dai brigatisti detenuti venne l'indicazione: «Fate quello che dovete fare, noi ce la caveremo», anche se temevano di essere uccisi.
L'audita, rispondendo a una domanda, ha affermato che durante il sequestro Moro non seppe di alcun altro contatto delle BR oltre a quello col PSI tramite Pace.
Riguardo all'allontanamento suo e di Morucci dalle Brigate rosse, Adriana Faranda ha detto che dapprima pensarono di influenzare la linea delle BR rimanendo all'interno dell'organizzazione e dosando le critiche in modo che potessero venire accolte, e che «il periodo dell'uscita fu molto lento». Ha ricordato che si arrivò così alla stesura di un documento che condusse inevitabilmente alla loro espulsione e ha sottolineato che non si trattò di una loro condanna da parte delle BR, ma solo di un'espulsione per incompatibilità politica; perciò, a suo avviso, lei e Morucci non rischiarono di essere uccisi dalle BR. L'audita ha aggiunto che lei e Morucci non riconobbero più l'autorità dell'organizzazione e non vollero sottostare alle decisioni che li riguardavano, come quella secondo cui sarebbero dovuti andare all'estero, "congelati"; volevano invece rimanere e costituire un'altra organizzazione,
alternativa alle BR e politicamente loro avversaria. Ritennero, quindi, loro diritto riprendere quello che ritenevano di aver dato all'organizzazione in termini di armi e denaro. Il nuovo gruppo che intendevano costituire, comunque, rifiutava l'omicidio politico e non prevedeva neanche ferimenti, ma gogne e azioni «legate ai bisogni del proletariato e delle borgate».
Attorno a lei e a Morucci si raccolsero, secondo l'audita, numerose persone che dissentivano dalla linea delle BR; si trattava di persone in gran parte note alle forze di polizia e, perciò, non in grado di offrire rifugi sicuri. Di qui la decisione di trattenersi a casa di Giuliana Conforto, dove Morucci e Faranda, secondo il ricordo di quest'ultima, abitavano dal marzo del 1979, senza che la stessa Conforto conoscesse la loro identità né fosse al corrente della presenza di armi; secondo l'audita Giuliana Conforto sapeva solo che le due persone che abitavano da lei erano del gruppo di «Metropoli», collegate a Franco Piperno. Adriana Faranda ha affermato di aver completamente ignorato, allora, chi fosse il padre di Giuliana Conforto, pur avendolo visto una o due volte quando era venuto in visita alle nipotine.
Riguardo ai sospetti su chi avesse potuto far scoprire il loro rifugio, l'audita ha detto di aver pensato, allora, a un haitiano che aveva precedentemente abitato in casa di Giuliana Conforto oppure a Saverio Tutino, giornalista del quotidiano «la Repubblica», che frequentava spesso la casa poiché aveva una relazione con Giuliana Conforto.
Rispondendo a domande sulla dinamica del suo arresto, Adriana Faranda ha affermato di non aver opposto resistenza e di aver ricevuto un colpo sulla nuca, dato con il calcio di una pistola. Ha anche ricordato che, mentre veniva portata via in auto, vi fu un contrasto tra coloro che l'avevano catturata, perché uno non voleva che fosse portata in Questura e un altro rispondeva che gli ordini erano di portarvela.
Riguardo all'elenco con 94 nomi di brigatisti e di altre persone, trovato tra le sue carte subito dopo la cattura, Adriana Faranda ha asserito che si trattava di una lista di persone sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche, redatto dalle forze dell'ordine o da un ufficio ministeriale, datole dal "fronte della contro" e che era stato probabilmente sottratto a un commissariato. Ha anche dichiarato di non essere mai stata interrogata su tale elenco.
Nella seduta del 19 luglio 2017 Adriana Faranda ha risposto a numerose domande, anzitutto confermando che la Skorpion con la quale era stato ucciso Aldo Moro era in possesso di Morucci e suo, al momento della loro cattura.
Riguardo all'ora in cui la mattina del 9 maggio 1978 incontrò Morucci davanti alla stazione "Piramide" della metropolitana, l'audita ha detto di non esserne certa e che, sebbene nel volume L'anno della tigre compaia l'orario delle 11, in realtà probabilmente l'incontro era avvenuto in orario antecedente, verso le 10.30 o forse anche prima, e che Morucci era arrivato in ritardo all'appuntamento. Ha spiegato il notevole lasso di tempo intercorso prima della telefonata con cui Morucci annunciò - a Francesco Tritto alle 12.13, con una telefonata effettuata dalla stazione Termini - l'uccisione di Moro asserendo che lei e Morucci erano sconvolti e sostenendo che occorreva arrivare alla stazione Termini, provare a chiamare qualcuno magari meno esposto di Tritto (che già aveva ricevuto varie telefonate dalle BR) e scegliere una cabina telefonica controllabile. Per quanto riguarda l'uso che Morucci fece del tempo trascorso tra
l'abbandono dell'auto con il corpo di Moro in via Caetani e l'incontro con lei alla Piramide, Adriana Faranda ha detto che Morucci dovette o portare via l'auto "di copertura" che aveva accompagnato nell'ultimo tratto la Renault con a bordo il corpo di Moro, oppure portare via e lasciare da qualche parte l'auto che era stata parcheggiata la sera precedente in via Caetani per occupare il posto destinato ad accogliere la Renault con il corpo di Moro. Riguardo all'orario dell'uscita di casa (in via Chiabrera) di Morucci la mattina del 9 maggio, ha dichiarato che era presto ma non prestissimo, cioè probabilmente dopo le 7.30.
Adriana Faranda ha affermato che nella riunione tenutasi nell'appartamento di via Chiabrera la sera dell'8 maggio 1978 (presenti, oltre a lei, Morucci, Moretti, Balzerani e Seghetti) era stato affidato a lei il compito di fare l'indomani mattina la "copertura", cioè la scorta all'auto con il corpo di Moro, ma che la sua reazione emotivamente intensa - di dissenso sull'uccisione di Moro anche se di accettazione «per disciplina» dell'incarico - aveva indotto gli altri a cambiare idea; il compito passò quindi a Morucci.
L'audita ha dichiarato di non aver mai saputo dove si riunisse in quel periodo il comitato esecutivo delle BR, perché vigeva la compartimentazione; inoltre, non si facevano domande in base al principio per il quale era bene per ciascuno sapere la minor quantità possibile di informazioni, in modo tale che in caso di arresto con trattamento brutale non si sarebbero potute rivelare molte notizie. Ha affermato che l'unico tramite tra il comitato esecutivo e la direzione della colonna romana era Mario Moretti.
Adriana Faranda ha ricordato di aver conosciuto un amico d'infanzia di Valerio Morucci, di nome Olindo, che gestiva un autosalone nel quale lei, quando ancora non era entrata in clandestinità né era ricercata, aveva acquistato due automobili, e ha aggiunto che Olindo «di tanto in tanto ci dava una mano per piccole cose». Ha aggiunto che probabilmente Morucci e lei lo incontrarono un paio di volte anche durante il periodo successivo al sequestro Moro.
L'audita ha escluso di aver mai conosciuto Giustino De Vuono, il cui nome compariva nel primo elenco dei ricercati predisposto dopo la strage di via Fani, e ha affermato che in quella lista apparivano molte persone che non facevano parte delle BR e che non avevano nulla a che fare con l'agguato del 16 marzo.
In merito al processo di dissociazione dalla lotta armata da parte sua e di Morucci, Adriana Faranda ha ricordato che il loro primo documento in tal senso fu una lettera durante il primo processo Moro e che era necessario evitare di essere assimilati sia - da un lato - ai pentiti sia - dall'altro lato - alla «dissociazione politica che veniva da altre esperienze che non avevano fatto parte di organizzazioni armate, come i compagni arrestati il 7 aprile, il gruppo di Toni Negri». Il loro intento era di avviare «una dissociazione che venisse dall'interno dell'esperienza clandestina». Ha ricordato che in carcere andavano spesso politici a discutere, ma il primo interlocutore fu il magistrato Nicolò Amato, che colse «quale sarebbe stata la portata dirompente di questa esperienza».
Riguardo all'aver fatto rivelazioni "a tappe successive", l'audita ha detto che ciò era dovuto principalmente al non voler compromettere altri. Circa l'aver taciuto, a suo tempo, sugli incontri con Lanfranco Pace e sulle comunicazioni tramite lui con il PSI, Adriana Faranda ha sottolineato che all'epoca il Governo era presieduto da Bettino Craxi e che, quindi, a detta di tutti, e anzitutto degli avvocati (incluso Giannino Guiso), se lei e Morucci avessero rivelato di aver avuto quei contatti sarebbero stati certamente smentiti e accusati di voler mettere in crisi il Governo.
L'audita ha negato che suor Teresilla Barillà avesse detto a lei e Morucci di non parlare né con i magistrati né con i giornalisti. Ha ricordato che entrambi avevano già ricostruito le vicende delle quali erano personalmente responsabili, senza fare nomi di altri, prima al giudice Ferdinando Imposimato e poi nel corso del processo d'appello; ha detto che in quel periodo «c'era un interesse politico sia da parte dei detenuti che portavano avanti questo discorso, sia da parte delle forze politiche in generale, a cercare di capire se era possibile arrivare appunto a una soluzione politica, come la chiamavamo noi». Ha aggiunto che era diffusa e ricorrente, anche sulla stampa, oltre che nelle conversazioni con esponenti politici che andavano a parlare con loro in carcere, l'affermazione secondo cui nessuna soluzione politica sarebbe stata possibile se non si fosse giunti alla verità sul caso Moro e ha ricordato
che suor Teresilla disse loro: «Guardate che i politici della Democrazia cristiana con cui sono in rapporto mi hanno detto che loro sono disponibili a prendere in esame comunque un'ipotesi, una ricerca su quale possa essere una soluzione politica, però l'importante è che si svelino i misteri che ci sono». Fu così, secondo l'audita, che Morucci e lei, dopo alcune perplessità, decisero di fare i nomi delle persone coinvolte in un testo dato a suor Teresilla (che, come ha precisato l'audita nella seduta del 20 settembre 2017, disse loro che lo avrebbe fatto avere all'onorevole Flaminio Piccoli), molto probabilmente nel 1986; non fecero qui nomi ai magistrati, perché ciò avrebbe fatto passare lei e Morucci dalla condizione di "dissociati" a quella di collaboratori di giustizia. Del testo, poi divenuto noto come "memoriale", l'audita ha detto di non essersi più interessata dopo averlo consegnato; ha
altresì detto di aver visto una sola volta nella vita Remigio Cavedon.
Nella seduta del 20 settembre 2017, sempre in risposta a domande del presidente e dei componenti della Commissione, Adriana Faranda ha avuto modo di precisare che la colonna romana delle BR si era rafforzata, con l'ingresso di nuovi militanti, fin dalla fine del 1976 e che i contatti con Norma Andriani iniziarono dopo la conclusione del sequestro Moro, in un periodo in cui vi era un grande afflusso di persone che chiedevano di avere contatti con le Brigate rosse e, in molti casi, di entrare a farne parte.
Riguardo al modo di procurarsi abitazioni, l'audita ha affermato che - in seguito alle nuove norme che obbligavano i proprietari a denunciare i nomi degli affittuari - le BR si servivano prevalentemente di prestanome, cioè persone lontane da indagini e sospetti delle forze dell'ordine, che potessero ospitare clandestini e ricercati. Ha detto che, però, i militanti clandestini delle BR abitualmente non abitavano insieme a prestanome o a simpatizzanti o ad irregolari, ma solo con altri militanti clandestini.
A proposito della circostanza che Saverio Tutino non avesse riconosciuto lei e Morucci, durante la loro permanenza a casa di Giuliana Conforto, Adriana Faranda ha sostenuto che il suo volto non era molto noto e che nelle immagini segnaletiche era scarsamente riconoscibile; al riguardo, ha raccontato che una volta chiese informazioni a una pattuglia della Polizia che si trovava sotto la sede del quotidiano della DC «Il Popolo», a piazza delle Cinque Lune, proprio per vedere quale fosse la sua fotografia che avevano sul cruscotto dell'auto, tra quelle dei ricercati, e in quell'occasione constatò che non le somigliava affatto, tanto che gli agenti non la riconobbero.
Di Alessio Casimirri l'audita ha detto che apparteneva al "fronte della controrivoluzione", che era considerato un militante «efficiente e capace, anche militarmente» e che non fu contattato da lei e da Morucci al momento della loro uscita dalle BR.
Il Presidente ha poi fatto riferimento alla collaborazione di Morucci col SISDE nel 1990, quale fornì sue valutazioni sul secondo ritrovamento di carte nel covo di via Monte Nevoso a Milano. In proposito, Adriana Faranda ha dapprima detto che la notizia la sgomentava e, quindi, ha affermato che probabilmente qualcuno aveva chiesto una consulenza a Morucci. Ha altresì ricordato che ci fu un periodo in cui sia lei sia Morucci furono contattati da agenti di polizia e carabinieri; in particolare, lei fu avvicinata, tramite Imposimato, da due funzionari del SISDE, con i quali però interruppe subito i rapporti.
Sugli originali dei testi scritti da Moro durante la prigionia (il "memoriale Moro"), l'audita ha riferito di essersi spesso chiesta perché si fosse considerato necessario distruggerli e di aver sempre ritenuto improbabile che ne esistesse una sola copia (quella ritrovata in via Monte Nevoso), specificando che comunque si trattava di una questione gestita esclusivamente dal comitato esecutivo.
Rispondendo, infine, ad ulteriori domande, Adriana Faranda ha detto che il 16 marzo 1978 si trovava in via Chiabrera ad ascoltare le trasmissioni radio della Polizia e dei Carabinieri e aveva il compito di «rimettere in piedi» la colonna romana se l'azione di via Fani fosse finita male e fossero rimasti uccisi i brigatisti. Ha affermato che non si era deciso di collocare l'auto col corpo di Moro in punto specifico di via Caetani: si era scelto di lasciarla in un luogo centrale che fosse simbolicamente significativo poiché vicino sia alla sede della DC sia a quella del PCI, senza preordinare esattamente neanche la strada; l'8 maggio venne trovato un posto libero in via Caetani e fu lasciata lì l'auto destinata a occupare il luogo fino al mattino dopo, quando venne sostituita dalla Renault col corpo di Moro. Ha detto che il suo difensore fu dapprima l'avvocato Tommaso Mancini, che difendeva anche Morucci; poi l'audita, quando
confermò l'identità del "quarto uomo" di via Montalcini, cioè Germano Maccari, cambiò avvocato poiché era insorta una questione di incompatibilità, in quanto Mancini era anche il difensore di Maccari. Ha precisato di non ricordare esattamente chi scelse Mancini come suo difensore, ma di ritenere che fosse stata la propria madre. Quando l'onorevole Carra ha affermato che in passato c'era stata «una polemica che voleva l'avvocato Mancini legato ai servizi segreti», l'audita ha dichiarato di non saperne assolutamente nulla. Riguardo alla circostanza che le BR, dopo aver annunciato in un loro comunicato che Moro stava fornendo completa collaborazione durante gli interrogatori, non ne diffusero poi i contenuti, Adriana Faranda ha detto che di non ritenere che si sia verificato un cambiamento nella linea di comportamento delle BR, ma che c'era l'intenzione di raccogliere tutto il materiale e fare poi un documento che
costituisse una sorta di bilancio dell'intera operazione. Ha ricordato anche che le venne chiesto ripetutamente, da «altre organizzazioni» con cui era in rapporto, come mai non venisse detto nulla; i componenti dell'esecutivo ai quali riferì la richiesta le risposero che c'erano gravissimi problemi logistici e politici. Ha anche detto che Moretti, durante il sequestro, «ci riportava le sue valutazioni su come andavano i cosiddetti interrogatori».
Al termine delle domande, l'audita ha voluto fare una considerazione sul rapporto tra il sequestro di Moro e il processo ai componenti delle BR allora in corso a Torino, e quindi alle relazioni tra il nucleo storico in carcere e i militanti che erano in libertà. Al riguardo, ha affermato di ritenere non corretta una netta separazione tra le "prime" e le "seconde" BR, poiché «noi in quel periodo ci muovevamo [...] in stretta relazione con quello che usciva fuori dal carcere e, quindi, con quello che proveniva dal nucleo storico». Ha ricordato che all'avvio del processo di Torino nacque il cosiddetto "processo guerriglia", con minacce ai difensori d'ufficio e con l'uccisione dell'avvocato Fulvio Croce nel 1977; che furono i componenti del nucleo storico, dal carcere, ad elaborare la linea delle BR, che serviva come indicazione ai militanti in libertà; e che dal carcere provenivano continue esortazioni a colpire di
più, ad essere più efficaci.
Nella seduta del 7 novembre 2017 si è svolta l'audizione di Walter Di Cera, entrato nelle Brigate rosse nel 1977, diciannovenne, e uscitone nel 1980.
L'audito ha affermato che le "brigate" periferiche come quella di cui egli faceva parte (era un irregolare della brigata Centocelle) non erano coinvolte nel dibattito sulla gestione del sequestro Moro, a causa della compartimentazione; le brigate territoriali, infatti, erano utilizzate per la diffusione di volantini e operazioni secondarie. Ha dichiarato che la brigata Centocelle non fu mai coinvolta nella decisione riguardante l'uccisione di Moro. Su Germano Maccari, l'audito ha ricordato di averlo conosciuto negli anni del liceo e ha confermato di aver saputo da Odorisio Perrotta che Maccari e Morucci erano i responsabili dell'omicidio di Mario Zicchieri, avvenuto nel 1975. Ha specificato di non aver mai sospettato che Maccari facesse parte delle BR e che nel quartiere, dopo la chiusura del Comitato comunista Centocelle (Cococen), si diceva che Maccari fosse vicino alla microcriminalità locale, perciò era criticato. Le BR - ha proseguito Di
Cera - evitavano contatti con gli ambienti della criminalità. L'onorevole Grassi ha osservato che «la storia dice altro» e che probabilmente Di Cera non era informato dei rapporti tra BR e criminalità sia a causa della compartimentazione sia a causa del suo ruolo marginale nell'organizzazione. L'audito ha replicato che le persone da lui conosciute nelle BR erano concordi nell'atteggiamento fortemente critico verso i rapporti con la criminalità comune.
A proposito di Casimirri e Algranati, l'audito ha affermato di averli conosciuti nella preparazione dell'azione di piazza Nicosia, ma di non aver mai avuto notizie riguardanti la loro partecipazione al sequestro e all'omicidio dell'onorevole Moro, ricordando che la compartimentazione era particolarmente rigida nei confronti delle strutture periferiche delle BR, che erano composte di militanti irregolari. Ha aggiunto che tra lui, Casimirri e Algranati si stabilì poi «un feeling di veduta, anche di atteggiamento critico verso un certo tipo di gestione delle Brigate rosse in quel momento».
Di Cera ha ricordato di essere stato sospettato dalle BR di essere un infiltrato quando non partecipò a una rapina presso il Ministero dei trasporti (perché «per me era assolutamente impensabile [...] sparare su chicchessia»); fu allora «riverificato» e inserito dalla direzione di colonna nel gruppo che effettuò l'omicidio di Girolamo Minervini.
Riguardo a Norma Andriani, l'audito ha dichiarato di averla conosciuta nell'ambito del Cococen ma di non aver saputo che appartenesse alle BR.
Il senatore Gotor ha domandato all'audito come pensasse di conciliare il suo rifiuto di usare le armi con la militanza nelle Brigate rosse. Di Cera ha risposto facendo riferimento all'intensità, in quegli anni, del conflitto sociale e ricordando che l'uccisione di Fabrizio Ceruso durante una manifestazione per le case a via San Basilio «fu uno degli elementi scatenanti, che [...] determinò quasi una scelta di campo da parte di interi settori della militanza dell'estrema sinistra nelle periferie». L'audito ha detto che molti militanti aderirono alla lotta armata in forza di dinamiche di gruppo, più che di scelte personali, e ha distinto il momento della «propaganda armata», che non causava vittime, da quello in cui si iniziò a effettuare omicidi. Il senatore Gotor ha osservato che però nel 1977, quando Di Cera entrò nelle BR, già da anni si praticava la lotta armata e le BR stesse
praticavano da tempo l'omicidio politico e l'audito ha detto che ne era ben consapevole, ma «a diciannove anni la vita non si capisce».
Rispondendo al Presidente, Di Cera ha confermato che nel 1979 Casimirri predispose, insieme a Prospero Gallinari, Mario Moretti e Renato Arreni, un piano per far evadere i brigatisti reclusi all'Asinara e che, a tale scopo, Casimirri e Arreni si stabilirono per un periodo a Stintino.
Di Cera ha dichiarato di aver conosciuto Prospero Gallinari nella primavera del 1979, in una riunione tenutasi a Trastevere e ha detto di non conoscere la zona dove Gallinari si appoggiava logisticamente, ma ha ricordato di aver visto una volta Gallinari e la Braghetti presso il portone di un edificio in via dell'Amba Aradam e di aver sospettato che lì potesse esservi una base delle BR.
Riguardo alla sua uscita dalle BR, Di Cera ha ricordato che all'epoca vi erano diverse tendenze critiche rispetto alla gestione sia della colonna romana sia, più in generale, di tutta l'organizzazione delle Brigate rosse, anche in conseguenza di una serie di omicidi di appartenenti alle forze dell'ordine, e ha sostenuto di essere uscito dalle BR a causa della tendenza di queste a «dare priorità alle armi» rispetto al «lavoro politico, lavoro di massa». Ha affermato che comunicò la decisione di lasciare le BR a Emilia Libera e che più tardi Roberta Cappelli (componente della direzione di colonna) gli propose di rifugiarsi in Francia con documenti falsi e denaro. In merito alla possibilità di rifugiarsi in Francia, da lui rifiutata, Di Cera ha detto che si trattava di una prassi normale, anche in virtù della cosiddetta dottrina Mitterrand, aggiungendo che coloro che andavano in Francia non
erano necessariamente esclusi dalle BR, ma potevano stare lì temporaneamente e poi tornare in Italia e riprendere la militanza attiva.
L'audito ha quindi descritto, su richiesta dell'onorevole Grassi, la cattura di Gallinari, alla quale era presente. Di Cera ha affermato che, mentre si trovava in via delle Mura Latine con Pietro Vanzi, Mara Nanni e Gallinari (quest'ultimo intento a sostituire la targa di un veicolo), vide avvicinarsi un'auto della Polizia e avvisò Gallinari, che gli disse di sparare. Ha dichiarato di non aver sparato e di essere fuggito, mentre Gallinari apriva il fuoco contro gli agenti. Alla domanda sul perché fosse riuscito a sfuggire alla cattura, l'audito ha risposto che, non avendo estratto la pistola, non venne individuato come uno dei brigatisti; anche Vanzi riuscì a fuggire, mentre Gallinari e la Nanni furono arrestati.
Circa il proprio arresto e fotosegnalamento, Di Cera, rispondendo a specifiche domanda del Presidente, ha ricordato che la notizia del suo arresto, avvenuto mentre svolgeva il servizio militare, non fu resa nota alla stampa per non intralciare le indagini e ha dichiarato di essere stato fotosegnalato il 2 marzo, subito dopo l'arresto. Il Presidente ha rilevato che su un brogliaccio contenente un elenco di fotosegnalamenti effettuati dai Carabinieri, la registrazione del fotosegnalamento risale al 7 maggio. Il Presidente ha quindi mostrato all'audito un cartellino di fotosegnalamento intestato ad Alessio Casimirri, recante la data del 4 maggio 1982; Di Cera ha affermato che la fotografia di Casimirri presente nel cartellino era un'immagine segnaletica da lui vista sul tabellone dei latitanti che era presente in una sede dei Carabinieri.
Infine, in risposta a una domanda dell'onorevole Lavagno, l'audito ha dichiarato che la sua collaborazione con i Carabinieri, iniziata subito dopo l'arresto, si è prolungato in un'«opera di consulenza verso l'Arma dei Carabinieri e verso altri apparati dello Stato fino al 2013».
4.3.Le audizioni di investigatori (magistrati ed ex appartenenti alle forze di Polizia)
Relativamente a questa tipologia di audizioni sono stati ascoltati magistrati inquirenti (Giovanni Salvi, Luigi Carli, Federico Cafiero de Raho e Giuseppe Lombardo), ex ufficiali dei Carabinieri (Michele Riccio e Domenico Di Petrillo) ed ex funzionari della Polizia (Elio Cioppa e Carlo Parolisi), in alcuni casi in riferimento a indagini direttamente connesse con il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, in altri invece in relazione a indagini su altre vicende, sulle quali la Commissione ha ritenuto necessario effettuare un approfondimento per verificare le possibili connessioni.
Il dottor Giovanni Salvi, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, è stato audito il 1° febbraio 2017, per un approfondimento - su proposta dell'onorevole Piepoli, vicepresidente della Commissione - sulle indagini da lui condotte, a suo tempo, sul tentato omicidio dell'esponente della DC cilena Bernardo Leighton, avvenuto a Roma nel 1975, e più in generale sulla cosiddetta operazione Condor. In precedenza, era stato ascoltato dalla Commissione il 24 febbraio 2015 sulla tematica dei documenti del Ministero dell'interno rinvenuti nel 1996 in un deposito della Circonvallazione Appia.
Nell'introdurre la sua illustrazione, il procuratore generale Salvi ha evidenziato che nell'indagine da lui condotta sulla vicenda Leighton «ci sono alcuni profili di sicuro interesse, però [...] non è emersa nessuna possibilità di ipotizzare un collegamento tra queste vicende e il sequestro e l'omicidio dell'onorevole Moro». Ha ricordato che per il tentato omicidio di Leighton e della moglie furono assolti per insufficienza di prove Stefano Delle Chiaie e Pierluigi Concutelli; in seguito furono raccolti nuovi elementi, con la collaborazione di autorità straniere, e si accertò che l'esecutore materiale era stato Concutelli, con l'appoggio di Delle Chiaie e di Avanguardia nazionale, ormai assolti con sentenze definitive. Furono invece condannati Michael Townley, agente della DINA (il servizio segreto cileno, in precedenza denominato DINAR) e il generale Manuel Contreras Sepulveda, capo della DINA, e Raul
Eduardo Iturriaga Neumann, direttore delle operazioni estere della stessa DINA.
Il dottor Salvi ha sottolineato che Townley, con ogni probabilità, era anche un agente dei Servizi americani, anche se ciò non è mai stato provato, e che secondo le sue dichiarazioni Leighton non era originariamente compreso nella lista delle persone da assassinare predisposta dal servizio segreto cileno, ma vi fu inserito subito dopo le elezioni regionali italiane del giugno 1975, nelle quali il PCI aumentò in modo consistente i suoi voti; il motivo fu che Leighton cercava di unificare le opposizioni al regime cileno, entrando in contatto anche con l'opposizione di sinistra, e si ritenne che, nel clima favorevole al compromesso storico che sembrava crearsi in Italia, Leighton potesse realizzare il suo progetto unitario.
Townley si appoggiò ad Avanguardia nazionale e ad Ordine nuovo per realizzare l'attentato nel quale Leighton e la moglie vennero feriti in modo molto grave.
Il procuratore generale ha posto in rilievo che nell'indagine vi fu la possibilità, tramite l'acquisizione dei documenti del servizio segreto cileno occulto che operava in Argentina - di avere «uno spaccato unico nella vita e nell'operatività di un Servizio segreto». In particolare, ha affermato che emerse, tra l'altro, che «più i documenti sono segreti, meno sono trattati con le procedure del segreto», ma appaiono come documenti informali, e che vi erano nomi di struttura e nomi di copertura. I nomi di struttura erano quelli, identici nel tempo anche se cambiavano le persone, che corrispondevano a un determinato incarico (chiunque svolgesse la funzione di direttore per i rapporti con l'estero, per esempio, si chiamava sempre Luis Gutierrez).
Giovanni Salvi ha dichiarato che all'epoca delle prime indagini sull'attentato a Leighton, i magistrati inquirenti non ricevettero collaborazione né dalle forze di polizia italiane né dalle «comunità del law enforcement internazionale», in particolare dagli Stati Uniti, e si è soffermato su alcuni elementi che dimostrano tale mancata collaborazione; in particolare, ha riferito che la notizia della presenza a Roma di otto "carabineros" cileni venuti per fare una ricognizione in vista dell'attentato a Leighton venne trasmessa dal SID alla polizia e all'autorità giudiziaria con alcune modifiche e che alcuni giorni in un'informativa si indicava che probabilmente l'attentato era maturato nell'ambito dell'estrema sinistra cilena.
Rispondendo a una domanda sul possibile collegamento con l'omicidio di Vittorio Occorsio, commesso da Concutelli nel 1976, il dottor Salvi afferma che il collegamento sia solo «di contesto», in quanto l'omicidio Occorsio sarebbe avvenuto - anche se ciò non è provato - nell'ambito del percorso di tentata unificazione tra Avanguardia nazionale e Ordine nuovo
A una domanda su Stefano Delle Chiaie, il dottor Salvi ha risposto di non ritenere che Delle Chiaie abbia avuto collegamenti con brigatisti.
Rispondendo a una domanda dell'onorevole Grassi sull'elenco dei 622 appartenenti a Gladio, il procuratore generale ha risposto che «la lista corrisponde effettivamente a persone che hanno fatto parte della struttura così come riconosciuta negli elenchi ricostruiti dopo il 1973» e che «non possiamo dire se prima del 1973 vi fossero altre persone». Ha dichiarato di non ricordare che, in attività relative alle Brigate rosse, fossero mai emerse liste di nominativi di Gladio e ha affermato che il generale Maletti non distrusse, prima di rifugiarsi in Sudafrica, l'archivio di Gladio.
All'onorevole Fabio Lavagno, che chiede all'audito di precisare ulteriormente l'affermazione secondo cui chi fu addestrato a Capo Marrargiu non necessariamente era coinvolto in Gladio, il dottor Salvi risponde citando una sentenza della Corte d'assise di Roma su un'operazione organizzata dalla cosiddetta "sezione K" del SISMI, quando tale Stoppani, avrebbe dovuto sequestrare o uccidere, in Austria, un terrorista altoatesino, Kienesberger, che aveva assassinato alcuni carabinieri; Stoppani era stato sottoposto all'addestramento di Gladio, ma in quel caso non operava come struttura Gladio.
Il 26 aprile 2017 si è svolta l'audizione di Michele Riccio, già ufficiale dei Carabinieri in servizio dall'ottobre 1978 a Genova come comandante della sezione speciale anticrimine, agli ordini del generale Dalla Chiesa.
Riccio ha affermato di non aver riscontrato indizi su un possibile ruolo della colonna genovese nel sequestro di Moro, eccetto la partecipazione di Riccardo Dura. Il senatore Fornaro ha chiesto di precisare l'affermazione su Dura e l'audito ha detto che secondo notizie da lui reperite all'epoca, Dura aveva preso parte «ad alcune riunioni dove fu trattato il problema Moro», aggiungendo che secondo lui aveva avuto il ruolo di far accettare nella colonna genovese nelle BR la decisione di uccidere Moro, ma non aveva svolto un ruolo operativo.
Rispondendo ad altre domande del senatore Fornaro, Riccio ha dichiarato che la "colonna genovese" era ritenuta la più affidabile e che poi entrò in crisi a causa dell'assassinio di Guido Rossa, che provocò una frattura interna. Ha ricordato che Guido Rossa, inizialmente ferito alle gambe, fu ucciso per iniziativa personale di Riccardo Dura e che lo stesso Dura, a suo giudizio, non era la persona che godeva della maggior fiducia di Moretti; dal punto di vista politico e di gestione della colonna, le persone che davano maggiori garanzie erano Rocco Micaletto e Livio Baistrocchi, anche se Dura era più preparato dal punto di vista militare.
Riguardo alla abitazione di Rapallo nella disponibilità delle BR, in cui si sarebbe anche riunito il comitato esecutivo, Riccio ha detto che un appartamento venne individuato, ma solo nell'ultimo periodo, quando la colonna era in via di dissoluzione.
Sulla situazione delle attività di contrasto al terrorismo all'epoca del suo arrivo a Genova, Riccio ha detto che il livello era molto basso e che il personale più preparato si trovava a Milano e a Torino.
L'audito ha poi ricordato di aver accompagnato spesso - rimanendo però in auto - il generale Dalla Chiesa in visita ai senatori Ugo Pecchioli e Paolo Emilio Taviani. Riccio ha riferito che Fenzi non sembrava né un organizzatore né un decisionista e che prima di essere cooptato dalle BR «nella parte più organizzativa», probabilmente non aveva avuto alcun ruolo, mentre il cognato Senzani era già oggetto di attenzione da parte del SISMI (in particolare in riferimento a una boutique nella quale lavorava una donna vicina a Fenzi) che, tuttavia, fornivano scarsa collaborazione. Secondo l'audito, il SISMI conosceva già allora il rapporto tra Fenzi e Senzani.
Il Presidente ha chiesto se gli avvocati di Soccorso rosso (Arnaldi, Spazzali, Cappelli, Sorrentino) avessero potuto avere qualche rapporto con la vicenda Moro, l'audito ha risposto negativamente, anche se Arnaldi tutelava la colonna genovese, alla quale forniva informazioni, e ne era parte organica.
A proposito del covo di via Fracchia, Riccio ha ricordato di aver fatto eseguire scavi nel giardino, ma di aver trovato solo, interrati in sacchi di plastica, volantini e risoluzioni strategiche, in parte macerati dall'acqua, mentre nella casa furono trovati erano archivi e armi, ma nulla che potesse riguardare Moro. L'audito ha confermato che le BR erano solite interrare i materiali, ricordando di aver trovato vari depositi interrati di documenti e armi in alcune località liguri.
Al covo di via Fracchia - ha raccontato Riccio - si arrivò a partire dalle dichiarazioni di un componente della banda 22 ottobre, che dopo l'arresto disse che il vertice delle BR si riuniva a Genova in una villetta con giardino, di una ragazza insospettabile, e poi tramite le dichiarazioni di Patrizio Peci, che parlò di via Fracchia, sebbene sbagliando alcune indicazioni, poiché era stato lì una sola volta. Ha anche ricordato che l'intenzione originaria era di intervenire la mattina presto, quando Annamaria Ludmannn usciva di casa, e poi con lei entrare in casa, e che fu il generale Dalla Chiesa a volere che si agisse prima, in contemporanea con l'intervento che era prevista la stessa mattina a Torino, alle 4; ciò per evitare che la notizia dell'azione dei Carabinieri a Torino raggiungesse i brigatisti genovesi e vanificasse la sorpresa. L'audito ha poi rievocato alcuni dettagli dell'irruzione nell'appartamento,
ricordando che, dopo aver fatto sfondare la porta, ci si trovò davanti a una tenda, scostata la quale apparve tutto buio, e affermando che, sebbene egli avesse detto «Non sparate, siamo Carabinieri», coloro che erano nell'appartamento spararono subito, colpendo all'occhio il maresciallo Benà.
L'audito ha ribadito che non c'era materiale riguardante il sequestro Moro e ha poi introdotto il tema di alcune notizie collegate alla vicenda Moro da lui trovate in Sicilia nel 1994, nel corso di indagini sulle stragi del 1992-93.
Riccio ha dichiarato che le informazioni gli giunsero da Luigi Ilardo, di "Cosa nostra", appartenente alla famiglia Madonia, che gli disse che le stragi erano state ispirate da «ambienti della destra extraparlamentare ordinovista e e da ambienti deviati istituzionali legati ai servizi segreti, massoneria e a certi ambienti della politica», gli stessi soggetti che avevano ispirato le azioni del 1973 e 1974 a Savona. L'audito ha proseguito riferendo che Ilardo gli disse che il suo mentore era stato Giovanni Chisena, massone affiliato ai servizi segreti con cui incontrava uomini del SID e con cui, negli anni 1976-77, era andato a Torino dove incontravano presso la chiesa di Santa Rita un imprenditore di 50-55 anni esponente delle Brigate rosse. Sempre secondo le parole di Ilardo riferite da Riccio alla Commissione, il contatto con il brigatista a Torino era favorito da Luigi Moschella, magistrato piemontese di origine siciliana - «notoriamente
conosciuto per i suoi rapporti con la criminalità organizzata» e successivamente «condannato per la ricettazione di alcuni lingotti d'oro» - che fu pubblico ministero nel processo alle BR del 1978 Riccio ha ricordato che Ilardo gli raccontò che il giorno della morte di Moro, di rientro in Sicilia in auto dopo un incontro con uomini del SID a Roma, alla notizia del ritrovamento del corpo, Chisena disse: «Allora l'hanno fatto. L'hanno voluto fare», lasciando intendere che si attendeva un esito e invece se ne era verificato un altro.
Riccio ha aggiunto di aver voluto approfondire e di aver verificato che Moschella era amico di un pregiudicato torinese, Germano La Chioma, che aveva partecipato alla rapina alla Brink's Securmark effettuata da Chichiarelli. L'audito ha sottolineato che nel borsello fatto ritrovare in un tassì da Chichiarelli era contenuto, accanto ad altri oggetti, un biglietto della tratta ferroviaria Villa San Giovanni-Messina, dal quale era stata asportata la parte relativa alla targa. Riccio ha dichiarato: «Ilardo a me aveva riferito [...] che, quando incontrava gli esponenti dei servizi segreti [...], si incontravano sovente sul traghetto tratta Villa San Giovanni-Messina». Secondo l'audito, quindi, Chichiarelli, asportando deliberatamente dal biglietto la parte relativa alla targa, «ha voluto legare il biglietto e i proprietari della targa dell'auto alle carte di Moro, dicendo in sostanza: "Guardate che, se mi succede qualche
cosa...".».
Riccio ha precisato che le dichiarazioni rilasciategli da Ilardo furono registrate, che del loro contenuto riferì a suo tempo al procuratore Caselli e al colonnello Mori e che i rapporti e i verbali «sono nella disponibilità delle Procure di Caltanissetta e Palermo». In un momento successivo dell'audizione ha indicato di aver inviato il suo rapporto denominato "Grande Oriente" alle autorità giudiziarie di Catania, Palermo, Caltanissetta e Messina.
L'audito ha espresso l'opinione che vi fosse una «struttura deviata» e che «Chisena [...], Luigi Savona, il dottor Moschella, Chichiarelli e gli agenti del SID [..] gestivano questa situazione», ma «sicuramente era una struttura che doveva essere più vasta». In un momento successivo dell'audizione, rispondendo al senatore Fornaro che gli chiedeva se nella «struttura» ci fossero persone «con licenza di uccidere» ha risposto affermativamente, «sia nelle carceri sia fuori».
Riccio ha ricordato che Ilardo venne ucciso nel 1996, prima di iniziare a collaborare con l'autorità giudiziaria e Chisena era stato ucciso nel 1991 nel carcere di Fossombrone, e che per quell'omicidio era stato emesso ordine di cattura nei confronti del brigatista Franco Bonisoli.
Rispondendo al senatore Gotor, l'audito ha detto di non aver mai indagato su Chichiarelli. Ha aggiunto di ritenere che la figura di Chichiarelli non fosse quella di un semplice falsario e che fosse stata molto sottovalutata. Ancora rispondendo al senatore Gotor, Riccio ha dichiarato di non aver mai saputo che un ufficiale dei Carabinieri, Raffaele Imondi (del quale si è detto amico), era in rapporti amichevoli con Chichiarelli.
In risposta a una domanda del senatore Fornaro, Riccio ha detto di non ritenere che il generale Dalla Chiesa si aspettasse di trovare nel covo di via Fracchia altre carte, oltre a quelle reperite. Ha affermato che il generale era solito telefonare subito, in simili casi, per sapere tutto ciò che era stato trovato nel covo e che, quindi, la telefonata che fece dopo l'irruzione in via Fracchia rientrava nel suo normale comportamento. A successive domande dello stesso senatore Fornaro, riguardanti i documenti contenuti nella cassaforte di Dalla Chiesa, a Palermo, che qualcuno aprì subito dopo la sua uccisione, e il loro eventuale collegamento con quanto riferito dall'audito alla Commissione, Riccio ha risposto che doveva trattarsi di documenti «pregiudizievoli per l'interesse di chi ha voluto l'azione di recupero». Ha aggiunto: «A me il generale non ha detto se aveva documenti particolari sul caso Moro. Potrei presumere che li
avesse o che qualcuno interessato al caso lo sospettasse, per via dell'apertura della cassaforte».
Nella seduta del 2 maggio 2017 si è svolta l'audizione di Elio Cioppa, già funzionario di Polizia in servizio a Roma dal 1968, dapprima occupandosi ordine pubblico e poi alla guida della sezione antisequestri e antirapine della Squadra mobile fino la giugno del 1978.
Il Presidente ha ricordato che Cioppa, nel corso del sequestro Moro, non si occupò direttamente delle indagini, ma che il suo nome emerse in relazione alla mancata perquisizione, il 18 marzo 1978, dell'appartamento di via Gradoli usato dai brigatisti, che venne scoperto poi un mese più tardi. Il Presidente ha quindi brevemente riassunto la vicenda: una squadra del Commissariato Flaminio Nuovo guidata dal brigadiere Domenico Merola e composta da altri tre agenti, effettuò - nell'ambito di una più vasta azione di controlli su abitazioni - un controllo dello stabile di via Gradoli 96; nell'appartamento che poi risultò un covo delle BR nessuno rispose agli agenti, che non ravvisarono motivi per sospettare una presenza brigatista e passarono oltre, senza sfondare la porta. Lucia Mokbel, abitante in un appartamento che era sullo stesso condominio, dichiarò il 23 novembre 1979 al giudice Amato (e poi in dibattimento al
primo processo Moro) che nella notte precedente tra il 17 e il 18 marzo aveva sentito dei ticchettii simili a segnali Morse provenire dall'appartamento dei brigatisti e aveva segnalato ciò il 18 marzo agli agenti di polizia che effettuavano il controllo, scrivendo anche un biglietto da far recapitare al dottor Cioppa in Questura. Gli agenti dichiararono di non ricordare tale episodio, anzi il brigadiere Merola nel 1981 escluse di aver ricevuto la segnalazione relativa agli strani rumori notturni; furono posti a confronto con la Mokbel, che li riconobbe ma non fu in grado di ricordare a quale degli agenti avesse dato il biglietto. Nel 1998 un ispettore del Commissariato Flaminio Nuovo, Consiglio Pacilio, riferì di aver appreso dal suo collega Ferdinando Di Spirito la veridicità del racconto della Mokbel e disse che la stessa sarebbe stata «in un primo momento, malmenata e ricoverata presso un ospedale di Roma. Poi le fu promessa una somma di
denaro, forse 200 milioni, come ricompensa», in particolar modo per non aver riconosciuto il poliziotto a cui avrebbe dato il biglietto. Fu comunque accertato che nel periodo considerato non risultavano agli atti ricoveri della donna presso ospedali romani.
Cioppa ha affermato che Lucia Mokbel nel 1976 aveva detto «di voler fare la poliziotta» e ha ricordato di averla mandata in alcuni locali frequentati dalla malavita; la Mokbel però dopo pochi mesi interruppe la sua collaborazione con la Polizia poiché temeva per la sua vita. Ha aggiunto che la Polizia sapeva benissimo che il fratello della ragazza era un estremista di destra. In un momento successivo dell'audizione, in risposta ad alcune domande, ha chiarito che con le parole «fare la poliziotta» non intendeva dire che la donna volesse entrare nella Polizia, ma che aspirava a diventare una confidente, un'informatrice della Polizia.
L'audito ha detto che nella zona dove il brigadiere Merola effettuò i controlli il 18 marzo vi erano edifici notoriamente caratterizzati dalla presenza di residence, in genere monocamera, dove abitualmente si trovavano prostitute, ma anche di terrorismo sia di destra sia di sinistra, oltre che da criminalità comune. Ha poi riferito che, secondo quanto a lui risulta, Lucia Mokbel segnalò effettivamente il ticchettio notturno proveniente dall'appartamento dell'«ingegner Borghi», che il brigadiere Merola le suggerì: «Vada dal dottor Cioppa», e che la Mokbel abbia replicato di non poterlo fare perché non aveva tempo (Cioppa però ritiene che fosse una scusa e che il reale motivo fosse il timore di recarsi alla sede della Squadra mobile); ha aggiunto: «Pare che [...] Merola si fece dare anche un biglietto in cui la donna si rivolgeva a me dicendo di fare accertamenti su questo ingegner
Borghi». Cioppa ha ricordato che Merola bussò tre volte all'appartamento abitato dai «Borghi», ma siccome nessuno aprì, senza abbattere la porta e che Mario Moretti e Barbara Balzerani confermarono poi di aver sentito bussare tre volte e di essersi preparati a sparare sugli agenti, se fossero entrati. Ha anche rilevato che Merola - che non era alle dipendenze di Cioppa, bensì del funzionario Guido Costa - non fece alcuna relazione, al momento, né gli portò il biglietto della Mokbel. Ha riferito che seppe del biglietto, nel settembre del 1978, quando la Mokbel, che non incontrava da tempo, gli chiese se avesse ricevuto una sua lettera; al suo diniego, la donna si stupì ma non gli comunicò il contenuto del messaggio.
Alla domanda sulla ragione per cui, a suo avviso, Merola non gli recapitò il biglietto, Cioppa ha risposto che Merola aveva scarsa professionalità e non capì che la Mokbel era una confidente.
Il Presidente ha quindi letto una dichiarazione del 1979, dalla quale risulta che Lucia Mokbel affermò di aver sentito i rumori somiglianti a segnali Morse «quattro o cinque giorni dopo l'eccidio di via Fani» e disse che «la mattina dello stesso giorno in cui avevo sentito gli strani rumori e poche ore dopo da ciò [...] bussarono alla porta alcuni agenti in borghese». Il Presidente e il senatore Fornaro hanno pertanto rilevato una discordanza di date, dal momento che gli agenti si recarono nello lo stabile il 18 marzo, cioè il secondo giorno dopo l'agguato di via Fani.
Elio Cioppa ha dichiarato che all'epoca non sapeva che la Mokbel abitasse in via Gradoli, né conosceva Gianni Diana, che allora viveva con lei, e ha specificato di non aver mai visto l'appartamento in questione.
Il senatore Fornaro, dopo aver rilevato che le dichiarazioni del brigadiere Merola e quelle di Lucia Mokbel sono in contrapposizione e che uno dei due ha sicuramente dichiarato il falso, ha chiesto all'audito quale dei due ritenesse credibile. Cioppa ha risposto che, secondo lui, fu Merola ad affermare il falso per difendersi dalle accuse.
L'onorevole Grassi ha affermato che in via Gradoli c'erano sei appartamenti dell'UCIGOS o dei Servizi e l'audito ha detto di non esserne a conoscenza.
Il Presidente ha quindi introdotto un diverso tema, chiedendo all'audito del suo intervento in via Caetani il 9 maggio 1978. Elio Cioppa ha ricordato di essere stato inviato lì dal questore De Francesco e di aver visto, appena arrivato sul luogo, due agenti della DIGOS; ha raccontato di aver aperto l'auto (dopo essersi accertato che non vi fossero fili sporgenti) e sollevato la coperta, e di aver quindi telefonato in Questura per confermare che si trattava del corpo di Aldo Moro. In una precisazione inviata successivamente all'audizione, Elio Cioppa ha dichiarato che prima di lui in via Caetani si era recato un altro funzionario di Polizia, Federico Vito, specificando di non averlo incontrato al suo arrivo, perché Vito aveva già lasciato il luogo per rientrare in Questura.
Circa i suoi rapporti con la loggia P2, il Presidente ha ricordato che Cioppa dapprima negò di avervi aderito, poi nel 1999 dichiarò di esservi entrato nell'ottobre del 1978 «per esclusivi motivi di servizio, perché ritenevo di poter ottenere sul terrorismo sia di destra sia di sinistra» e di non aver rinnovato l'iscrizione nel 1979, indicando di aver incontrato Gelli due volte, nel settembre del 1978 e nel settembre del 1980. Al riguardo, l'audito ha affermato che, in seguito a un episodio avvenuto durante le indagini sul sequestro di Giovanna Amati si erano acuite alcune difficoltà tra lui e il capo della Squadra mobile romana, Fernando Masone; perciò dovette lasciare la Squadra mobile dapprima per dirigere il commissariato Appio Claudio e poi, su proposta del generale Grassini (da lui non conosciuto in precedenza), entrò in servizio al SISDE. Ha ricordato di aver effettuato, quando era al SISDE,
un'operazione importante contro le BR a Genova, denominata operazione Canepa, grazie a un confidente - un criminale comune, pregiudicato, legato a una brigatista, la quale poi in cambio di sei milioni di lire fornì informazioni su Fenzi e altri brigatisti - del capitano Maurizio Navarra, della Guardia di finanza. Alla domanda su chi fosse la brigatista che gli fornì le informazioni sui brigatisti liguri, Cioppa ha risposto: «Non lo dirò mai», soggiungendo poco dopo di non ricordarne il nome. Ha dichiarato di non aver mai incontrato il pregiudicato e di non ricordare neanche chi fosse. Cioppa ha affermato di aver scritto per il giudice Sica una relazione di trenta pagine sull'operazione da lui svolta a Genova e di ritenere che la relazione fosse stata trasmessa al generale Dalla Chiesa
Cioppa ha ricordato che una volta il generale Grassini gli diede un appunto, da sviluppare, su Spazzali e altri, in relazione al sequestro Moro, che secondo l'appunto sarebbe stato «perpetrato proprio per il compromesso storico». Il Presidente, leggendo da una copia dell'appunto, ha elencato i nomi ivi contenuti: Guiso, Spazzali, Di Giovanni, Piperno, Toni Negri, Sivieri, Scialoja, Tessandori, Isman, Battistini. Cioppa ha proseguito affermando di essersi meravigliato che Grassini gli avesse trasmesso quell'appunto, che a lui sembrava un'informazione di carattere soltanto politico e quindi scarsamente interessante, e di averlo trasmesso al collega della DIGOS di Milano. Ha poi dichiarato che Grassini stesso gli disse che la fonte dell'appunto era Licio Gelli. Il Presidente ha ricordato che Grassini, invece, negò di aver ricevuto quelle informazioni da Gelli e disse che Gelli era una fonte del Centro SISDE di Roma, diretto da Cioppa.
Rispondendo all'onorevole Grassi, l'audito è tornato sulla sua iscrizione alla loggia P2, riferendo di essere stato per questo sottoposto nel 1986 a procedimento disciplinare e prosciolto. Ha asserito di aver conosciuto Gelli attraverso Umberto Ortolani (da lui conosciuto in occasione del sequestro del figlio Amedeo Ortolani, nel 1975) e di non aver sottoscritto alcuna domanda di ingresso nella P2, aggiungendo di essere persuaso di essere stato iscritto da altri.
In risposta a una domanda del senatore Fornaro, Cioppa ha detto che all'epoca era convinto che Moro fosse tenuto a breve distanza da via Fani, in quanto i rapitori potevano prevedere che sarebbero stati collocati rapidamente numerosi posti blocco, tali da impedire la loro uscita da Roma.
Il 30 maggio 2017 la Commissione ha ascoltato Carlo Parolisi, che ha ricordato di essere entrato nella Polizia nel 1978 e di esser stato assegnato dapprima alla DIGOS di Genova e poi, dal 1981 al 1988 alla DIGOS di Roma, successivamente passò al SISDE fino al 2004 e quindi al SISMI, dove rimase fino al collocamento in quiescenza, all'inizio del 2014.Invitato dal Presidente a fornire notizie in merito alle indagini svolte su Tony Chichiarelli, l'audito ha dichiarato di ricordare vagamente la vicenda, aggiungendo che le modalità dell'omicidio di Chichiarelli - la cui personalità è stata definita dall'audito come «molto misteriosa, molto contorta» - erano apparse strane, poiché era stato ucciso con un'arma di piccolo calibro, dettaglio che apparentemente escludeva apparentemente il coinvolgimento di criminaltà organizzata o politica.
Parolisi ha poi dichiarato di non ricordare e di non aver visto i due frammenti di fotografia fatti ritrovare da Chichirelli nel 1984 a piazza Belli, a Roma. Su Raimondo Etro ("Carletto"), l'audito ha raccontato come questi quasi subito dopo l'arresto accettò di collaborare, fornendo informazioni interessanti. Secondo Parolisi, però, in seguito emerse che Etro era stato reticente, avendo omesso di parlare del suo coinvolgevano, sia pure con un ruolo marginale, nel sequestro di Aldo Moro (in particolare, aveva avuto il compito di ritirare le armi dopo l'azione di via Fani). Rispondendo a una domanda del Presidente, Parolisi ha affermato di non ricordare che Etro avesse riferito dettagli sulla fuga in Francia di Alessio Casimirri, precisando che tali dettagli furono invece forniti, in seguito, da Casimirri, in Nicaragua.
In merito alle indagini svolte nel 1982 su Casimirri, Parolisi ha ricordato che quando egli arrivò alla DIGOS romana, tra le molte indagini in corso, c'era quella relativa a due militanti che non si riusciva a identificare, una coppia di coniugi nota con i nomi di battaglia «Camillo» e «Marzia», dei quali pian piano si capì che provenivano dalla zona di Roma nord. Successivamente i emerse che, prima di unirsi sentimentalmente alla moglie, «Camillo» era stato legato a un'altra militante delle BR, Mara Nanni, catturata insieme a Prospero Gallinari; in particolare, Parolisi ha ricordato che fu il padre della Nanni, da lui incontrato dopo l'arresto della figlia, a fargli il nome di Casimirri come persona con cui in precedenza Mara Nanni aveva avuto una relazione. Parolisi ha riferito che a quel punto, anche grazie alla circostanza che egli aveva studiato nel liceo Dante Alighieri negli stessi anni in cui era
stato frequentato proprio da Casimirri, poté facilmente identificarlo come «Camillo» e, sapendo che aveva sposato Rita Algranati, si identificò subito questa come «Marzia».
Parolisi ha poi aggiunto che da una serie di elementi si comprese che Casimirri si era allontanato dalla famiglia già da molto tempo e successivamente si scoprì che la coppia era entrata in attrito con le BR e ne era uscita tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982. L'audito ha dichiarato che allora ci si convinse che Casimirri e Algranati si fossero rifugiati all'estero e ha ricordato come si svolgeva in quegli anni la collaborazione con la polizia francese: «I francesi non erano mai molto sinceri e molto aperti nei nostri confronti, anche perché dovevano obbedire a dettati politici [...], quindi erano portati non dico a proteggere, ma in qualche modo a coprire questa comunità di latitanti in Francia»).
L'audito ha detto che in seguito i Servizi comunicarono Casimirri poteva trovarsi a Cuba e successivamente lo localizzarono in Nicaragua.
Dopo una domanda posta dal Presidente in merito ai colloqui con Casimirri avuti da Mario Fabbri e Parolisi in Nicaragua tra il 23 e il 29 agosto 1993, l'audizione è proseguita in forma segreta.
Il 19 giugno 2017 si è svolta l'audizione di Domenico Di Petrillo, già ufficiale dei Carabinieri, che ha avuto ad oggetto la colonna romana delle Brigate rosse e il suo smantellamento.
Di Petrillo ha riferito di essere entrato in servizio il 24 maggio 1978 alla Sezione anticrimine di Roma, che si occupava dell'eversione di sinistra, e ha ricordato le difficoltà iniziali delle indagini e la mancanza di un archivio, anche perché nell'Italia settentrionale «la matrice operaista consentiva di concentrare in ambiti più ristretti la ricerca, mentre Roma era caratterizzata da numerosissimi collettivi di diverso tipo». Ha ripercorso brevemente la serie di incarichi successivamente assunti, fino all'ultimo, quello di direttore della divisione antiterrorismo del SISDE nel 1995-96 e ha quindi rievocato alcune importanti indagini contro il terrorismo alle quali prese parte.
Di Petrillo ha sottolineato che a metà degli anni Settanta, quando venne sciolto il Nucleo speciale del generale Dalla Chiesa (costituito appena un anno prima), vennero create delle Sezioni anticrimine nelle principali città, osservando che tuttavia il problema del terrorismo era più sentito al Nord e quindi i reparti delle città settentrionali erano maggiormente dotati di personale e mezzi rispetto a Roma, dove solo con ritardo si ottennero più uomini e materiali.
Riguardo alle indagini sulla colonna romana delle BR, Di Petrillo ha riferito che si era riusciti a fotografare in via Galvani il direttivo della colonna e poi in piazza Cola di Rienzo un incontro tra Bruno Seghetti, Salvatore Ricciardi e una ragazza che, pedinata, è poi risultata essere Alessandra De Luca, la segretaria del pubblico ministero del processo Moro, il sostituto procuratore generale Guasco. A proposito del covo di via Montalcini, l'audito ha ricordato che un carabiniere individuò in un bar di piazza Sforza Cesarini il 27 maggio 1980 Anna Laura Braghetti, che venne arrestata insieme a due altre persone; dopo l'arresto, esaminando il fascicolo della Braghetti, si trovò un appunto del 1978 che riferiva di un accertamento eseguito su sollecito del generale Dalla Chiesa in via Montalcini, dove però era risultato già presente l'UCIGOS e circolava la voce che l'UCIGOS stesse per procedere a un'irruzione. L'audito
ha detto di essersi recato, dopo l'arresto della Braghetti, sia presso l'abitazione del fratello della brigatista, in via Laurentina, sia in via Montalcini, ma di non aver effettuato il sopralluogo all'interno dell'appartamento, poiché questo era stato acquistato nel 1979 da una famiglia che aveva fatto eseguire dei lavori. Ha aggiunto che allora non immaginava che quell'appartamento potesse essere stato il luogo della detenzione di Moro e che ciò divenne noto solo a seguito delle dichiarazioni di Morucci e Faranda al giudice Imposimato.
Tornando alle indagini sulla colonna romana, Di Petrillo ha affermato che in un'occasione si riuscì a identificare una persona fotografata durante incontri con brigatisti soltanto grazie alla collaborazione di uomini del PCI, contattati attraverso l'avvocato Fausto Tarsitano.
In merito al ruolo dei pentiti, Di Petrillo ha raccontato che Roberto Buzzatti, arrestato dalla Polizia, chiese di parlare con i Carabinieri e identificò Walter Di Cera come il capo della brigata di Centocelle; Di Cera venne immediatamente arrestato mentre svolgeva il servizio militare e, subito pentito, fornì informazioni importantissime, che portarono a numerosi arresti e alla scoperta di moltissimi covi.
L'audito, in risposta a una domanda del Presidente, ha ricordato l'attività investigativa nata dall'infiltrazione nelle Brigate rosse di un militante del PCI e ha negato che tale attività abbia condotto all'arresto di Barbara Balzerani, al quale si giunse molto più tardi e con attraverso altre attività investigative.
Riguardo alla fonte "Nadia", evocata dal generale Cornacchia, Di Petrillo ha affermato di non averla mai sentita nominare, e riguardo a Paolo Santini, che fu una fonte di Cornacchia, l'audito ha dichiarato che lo incontrò e giudicò inconsistente il «valore antiterrorismo che poteva esprimere».
Domenico Di Petrillo ha dichiarato di non aver avuto esperienza diretta della vicenda Moro e ha espresso la persuasione che «dietro le Brigate rosse c'erano le Brigate rosse», affermando di aver sempre avuto difficoltà a credere che al sequestro Moro avessero concorso entità diverse dalle BR, anche se la vicenda poteva «essere stata sfruttata da varie entità - istituzionali (partiti, lotte interne di partiti) o altre situazioni - come lotta politica o come strumento politico di lotta interna».
Nella stessa seduta del 19 giugno 2017 la Commissione ha ascoltato Luigi Carli, già magistrato presso la Procura di Genova, che condusse inchieste sulle Brigate rosse, in particolare tra il 1979 e il 1983. L'audizione ha riguardato soprattutto la colonna genovese delle BR e la vicenda del covo brigatista di via Fracchia, scoperto il 28 marzo 1980.
Carli ha ricordato come le Brigate rosse a Genova nacquero sostanzialmente all'interno dell'università, soprattutto dopo l'irruzione nel covo di via Fracchia. In precedenza, le azioni dei brigatisti a Genova non erano state condotte dalla "colonna genovese". La colonna, ha proseguito Carli, era formata di circa 60-80 persone, con scarsissima presenza operaia, e dopo l'episodio di via Fracchia si distinse, rispetto alle colonne brigatiste di altre città, per una impostazione di tipo militaristico e omicidiario sotto la spinta di Lo Bianco e Baistrocchi.
Carli ha affermato che Riccardo Dura, ucciso in via Fracchia, era destinato a divenire il capo della costituenda colonna genovese, anche se era vista con un certo sospetto, anche perché aveva deciso autonomamente di uccidere Guido Rossa, anziché limitarsi a ferirlo alle gambe, come era stato stabilito dalle BR.
Secondo Carli, la collaborazione di Enrico Fenzi con le autorità portò all'arresto di Lo Bianco e alla cattura a Milano di Moretti; quando il Presidente gli ha fatto osservare che Fenzi fu arrestato proprio insieme a Moretti, l'audito non ha approfondito la propria affermazione. Carli ha anche detto che Fenzi, dovendo passare da irregolare a clandestino, soprattutto per la sollecitazione della sua compagna Isabella Ravazzi, dovette partecipare ad un'azione di fuoco, cioè il ferimento di Carlo Castellano. Rispondendo a una domanda sull'ipotesi di una partecipazione della colonna genovese, e in particolare di Dura, al sequestro Moro e sul rapporto tra Dura e Moretti, l'audito ha dichiarato che all'epoca non si occupava di indagini sulle BR e che non non era ben visto dai vertici della Procura, aggiungendo di essersi occupato poi delle indagini sulla colonna genovese, ma di non aver saputo nulla di quanto successo prima se non quanto
riferitogli dai colleghi torinesi Laudi, Caselli e Miletto (ha affermato «che poi entrarono in possesso dei documenti di via Fracchia, che io non vidi mai, perché restarono esclusivamente in possesso del procuratore della Repubblica Antonino Squadrito e del procuratore aggiunto Luigi Francesco Meloni»).
Sull'avvocato Edoardo Arnaldi, l'audito ha dichiarato che era il trait-d'union tra i brigatisti in carcere e i brigatisti all'esterno, un "irregolare" con le conoscenze e il ruolo di un "regolare". Secondo Carli, Arnaldi era soprattutto succube della moglie, molto impegnata ideologicamente e legata agli ambienti genovesi dei radicali e del PSI.
Rispondendo ad una domanda del Presidente, Carli ha detto di aver saputo da Fulvia Miglietta, vicecapo della colonna genovese, e da altri che un carico di mitra Sten (inadatti alla guerriglia urbana) proveniente da Fatah arrivò a Venezia, trasportato su uno yacht; dalla Bulgaria arrivarono mitragliette Skorpion e e da Action directe provennero esplosivi. Ha aggiunto che seppe da Fenzi che Senzani non era ben visto dalle BR perché tendeva «ad appoggiarsi sulla malavita locale» campana.
Tornando alla vicenda di via Fracchia, l'audito ha confermato, come già aveva dichiarato a collaboratori della Commissione, di non aver mai avuto a disposizione il materiale sequestrato nel covo, ma di aver lavorato esclusivamente sul fascicolo degli atti istruttori relativi alla dinamica dell'azione, che gli era pervenuto perché delegato dal procuratore Squadrito a formulare le conclusioni scritte del pubblico ministero, di non aver mai visto alcun documento riferibile ad Aldo Moro e di non essere stato informato né degli scavi nel giardino né del rinvenimento di sacchi di plastica poiché della modalità di trasmissione degli atti sequestrati all'autorità giudiziaria se ne occupava lo stesso procuratore della Repubblica. Ha anche confermato di aver avuto notizia dell'esistenza di carte di Moro in via Fracchia in occasione di riunioni operative coi magistrati torinesi Laudi, Caselli, Maddalena e Miletto.
Carli ha, inoltre, ricordato di aver sentito parlare di ritrovamento di «materiale eccezionale» nel covo di via Fracchia da Maria Giovanna Massa, la compagna di Patrizio Peci; dapprima irriducibile, la Massa era diventata una pentita dopo aver subito in carcere un tentativo di strangolamento da parte di un'altra detenuta.
Riguardo alla dinamica dell'azione in via Fracchia, Carli ha dichiarato di aver saputo che a uno dei carabinieri, prima della loro irruzione nell'appartamento, partì per errore una raffica che finì contro il muro.
L'audito ha poi ricordato di aver appreso da alcuni brigatisti che Moro era stato ucciso perché era diventato impossibile gestire il sequestro e l'attività investigativa era diventata pressante, e perché, non avendo ottenuto il riconoscimento politico delle Brigate rosse, era prevalsa la volontà di ucciderlo perché altrimenti l'organizzazione si sarebbe indebolita l'organizzazione anche dal punto di vista militare.
In risposta a ulteriori domande, Carli, dopo aver ripetuto di non essersi occupato né dell'istruttoria sommaria né delle indagini preliminari su via Fracchia, ha dichiarato di aver saputo che «giravano nelle cancellerie dei funzionari dei soggetti del SISMI e del SISDE»; ha affermato di aver sentito dire da diversi pentiti che le BR ricevevano anche finanziamenti dal Mossad e che Israele agiva in tal senso perché «aiutare ad 'indebolire la situazione interna dell'Italia avrebbe giovato [...] ad accrescere il prestigio e l'autorevolezza di Israele».
Rispondendo all'onorevole Bolognesi circa la possibilità, riferita alla Commissione da Fenzi, che Dura avesse partecipato all'agguato di via Fani, Carli ha dichiarato di ritenere tale ipotesi «una fantasia di Fenzi». Ad un'altra domanda dello stesso deputato, relativa alla possibilità che a via Fracchia molto materiale reperito nel covo fosse stato per alcuni giorni lungo sottratto all'esame dei magistrati, l'audito ha risposto: «Sono cose su cui potrebbero riferirvi molto meglio i torinesi. Sono loro [...] i destinatari di queste cose. Sanno tutto loro. Quello che ho sentito io sono informazioni de relato quando i torinesi parlavano con i romani».
Carli, rispondendo all'onorevole Grassi, ha detto di non essere mai entrato nel covo di via Fracchia, specificando che il magistrato di turno allora era un giovane collega, Filippo Maffeo, ma il procuratore aggiunto preferì mandare un altro collega, Michele Marchesiello. Ha ricordato di aver ricevuto, in seguito, dal procuratore della Repubblica l'incarico di formulare la requisitoria per i fatti di via Fracchia solo a causa di ragioni di incompatibilità di varia natura che riguardavano altri magistrati.
Il 28 settembre 2017 sono stati auditi Federico Cafiero de Raho e Giuseppe Lombardo, rispettivamente procuratore e procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria per acquisire elementi su un eventuale ruolo della 'ndrangheta nel del sequestro Moro.
Il procuratore Cafiero de Raho ha esordito affermando che i Nirta, i Piromalli e i De Stefano sono le dinastie fondamentali della 'ndrangheta. In riferimento alle dichiarazioni di Saverio Morabito sul coinvolgimento di Antonio Nirta, detto "Due nasi", nel sequestro Moro, ha specificato che sono attive due famiglie Nirta, entrambe provenienti da San Luca. Una si ricollega agli Strangio, è in contrasto con la famiglia Pelle-Vottari ed è meno importante rispetto all'altra famiglia Nirta, detta "La Maggiore" o Scalzone. Ha ricordato che Morabito riferì di aver appreso la notizia su Nirta da Domenico Papalia e Paolo Sergi e ha brevemente delineato il profilo criminale di questi ultimi, sottolineando che Domenico Papalia e il fratello Antonio furono condannati per l'omicidio di Umberto Mormile, rivendicato da una sedicente «Falange armata», sigla di un'inesistente associazione politico-sovversiva utilizzata in molte occasioni,
come, nel 1993, l'attentato di via Fauro a Roma e le stragi di via dei Georgofili a Firenze e di via Palestro a Milano. L'audito ha riferito che i collaboratori di giustizia hanno dichiarato che la sigla fu usata da Domenico Papalia con l'autorizzazione dei Servizi di sicurezza, con i quali era in rapporto, e che secondo Antonino Cuzzola (esecutore materiale dell'omicidio Mormile), Antonio Papalia aveva rapporti con il generale Francesco Delfino. Ha aggiunto che secondo Filippo Barreca il Nirta "Due nasi" era in buoni rapporti con lo stesso generale Delfino.
Riguardo alla frase della conversazione telefonica del 21 novembre 1993 tra il generale Delfino e il tenente colonnello Lombardi secondo cui Nirta avrebbe fatto parte del "gruppo di fuoco" a via Fani perché doveva «contraccambiare il favore per l'eliminazione dei due Strangio», il procuratore ha rilevato che «diventa difficile inserirla nell'ambito del panorama che si era all'epoca realizzato».
Cafiero de Raho ha poi rievocato i legami tra la 'ndrangheta, in particolare i De Stefano, e figure del terrorismo di destra come Franco Freda e Pierluigi Concutelli.
Ha dichiarato che i Nirta, i De Stefano e i Piromalli sono famiglie al vertice della 'ndrangheta e che nel passaggio dalla 'ndrangheta di Sgarro alla 'ndrangheta di Santa si osserva che la 'ndrangheta «non è più solo crimine, ma deve entrare in rapporti con le istituzioni, con la massoneria e con tutti coloro che contano».
Ancora, il magistrato ha asserito che quanto Morabito ha dichiarato su Nirta «non è [...] privo di fondamento, anche se certo dal punto di vista giudiziario è tutto da verificare e da supportare con elementi significativi».
Il procuratore Cafiero ha riferito anche di ritenere attendibili le dichiarazioni di Antonino Fiume, collaboratore di giustizia che parla di due mitragliette custodite dalla 'ndrangheta presso la ditta della quale era titolare, che erano simili a quelle impiegate in via Fani, secondo quanto gli disse Orazio De Stefano.
Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo si è soffermato su Antonino Fiume - «perno delle ricostruzioni processuali che riguardano la cosca De Stefano» - già fidanzato con la figlia di Paolo De Stefano e quindi in grado di conoscere notizie riservatissime della famiglia. Dopo aver illustrato il percorso collaborativo di Fiume, Giuseppe Lombardo ha raccontato come, parlando con lui delle due pistole mitragliatrici Skorpion, custodite da Fiume stesso con moltissime altre armi, il collaboratore di giustizia gli disse: «Non so se questa è una cosa di cui io posso parlare, perché non ne ho mai parlato [...] è una cosa che mi intimorisce». Fiume poi gli riferì che Orazio De Stefano, nell'affidargli le due Skorpion, gli disse di averne molta cura perché erano simili a quelle usato per uccidere Moro. Ad avviso del procuratore aggiunto Lombardo, «quel "simile" di Fiume è un
atteggiamento prudenziale».
Giuseppe Lombardo ha ricordato che nell'officina dei fratelli Fiume venivano assemblate e modificate per conto della 'ndrangheta reggina le armi - anche armi giocattolo - e si costruivano silenziatori artigianali. Ha poi sottolineato che le dichiarazioni sulle Skorpion (armi attualmente nella disponibilità dalla Procura di Reggio Calabria) vengono fatte da Fiume non nella prima fase della sua collaborazione, ma molto più tardi, nel 2008, dopo aver già ricevuto sentenze definitive di condanna.
Il procuratore aggiunto ha affermato che Fiume ha riferito delle protezioni di cui godevano i De Stefano e dei loro legami con appartenenti ai servizi di sicurezza, nonché dei legami dei De Stefano con i Nirta "La Maggiore", che si pensava di consolidare facendo sposare un De Stefano con una Nirta "La Maggiore". Tale legame, ad avviso del procuratore aggiunto Lombardo, «rende compatibile il fatto che Antonio Nirta "Due nasi", ovviamente se questo viene accertato, possa essere stato presente in via Fani e, se quella presenza non era una presenza passiva [...] le armi possano essere arrivate dai De Stefano».
Il dottor Lombardo ha poi ricordato che nel 2004 emersero rapporti di Paolo Sergi con Elfino Mortati, per scambio droga/armi. Ha proseguito affermando che il padre di Antonio Nirta "Due nasi" già negli anni '70 partecipava a incontri romani con i vertici di Cosa nostra, che il ruolo dei tre fratelli Nirta (pare e zii di Antono "Due nasi") non era «parificabile a tutti gli altri» e che il rapporto tra i Nirta e i De Stefano era molto forte.
Relativamente al generale Delfino, il procuratore aggiunto Lombardo ha sottolineato che era nato a Platì e che esistono «tracce costanti che accostano Delfino da una parte ai Papalie, dall'altra ai Nirta».
Tornando sull'intercettazione della conversazione telefonica tra il generale Delfino e il tenente colonnello Lombardi, il procuratore aggiunto ha espresso l'opinione che, siccome gli Strangio non facevano parte del gruppo dei Nirta "La Maggiore", «astrattamente» sarebbe possibile che Nirta abbia partecipato al sequestro Moro per ricambiare qualcosa che era connesso all'uccisione degli Strangio.
Il Presidente ha quindi chiesto se i legami dei De Stefano con la destra eversiva provocavano una preclusione totale verso il terrorismo di sinistra. Il dottor Lombardo ha risposto negativamente, affermando che la 'ndrangheta non ha colore politico. Al riguardo, ha ricordato che l'avvocato Paolo Romeo, in origine soggetto di destra estrema, venne poi eletto quale parlamentare socialdemocratico.
4.4.Le audizioni di esponenti politici
La Commissione, dopo aver proceduto negli anni precedenti ad audizioni di diversi uomini politici attivi nel periodo del sequestro Moro, ha ritenuto utile ascoltare alcuni esponenti della Democrazia cristiana dell'epoca, sia di rilievo nazionale (Giuseppe Zamberletti, Guido Bodrato) sia di livello locale (Luigi Ferlicchia), che, ciascuno dal punto di vista dell'incarico ricoperto all'epoca, hanno riferito sulle rispettive conoscenze.
Nella seduta del 19 gennaio 2017 è stato ascoltato Giuseppe Zamberletti, già Sottosegretario all'interno tra il 1974 ed il 1977 e Sottosegretario agli affari esteri dal 1979 al 1980.
Il Presidente ha posto domande in riferimento a notizie di stampa del 1978 secondo Zamberletti era stato coinvolto in un contatto con brigatisti dissidenti disposti a rivelare dove era tenuto prigioniero Moro. Zamberletti, che allora non faceva parte del Governo, ha, ricordato che nella settimana di Pasqua del 1978 (la Pasqua fu 26 marzo) venne contattato dal Ministro dell'interno Cossiga, che gli disse che «c'era un contatto che doveva svilupparsi attraverso un incontro che richiedeva la presenza di un politico» e che aveva pensato a lui; Cossiga non indicò dove dovesse avvenire l'incontro, chiedendogli solo di non muoversi da Roma, e non precisò neanche a cosa il contatto avrebbe potuto portare. Secondo l'audito, Cossiga non sapeva esattamente di cosa si trattasse, se di informazioni sul luogo di detenzione di Moro oppure di una richiesta di trattativa o altro, ma sapeva che «veniva dall'interno». Zamberletti ha
riferito anche che Cossiga lo informò che sarebbe stato accompagnato all'incontro dal colonnello Varisco, che avrebbe fatto da autista. Negli incontri che ebbe con Varisco, ha proseguito l'audito, emerse che il colonnello non ne sapeva molto di più e, anzi, sospettava che si trattasse di una trappola o di un agguato. Secondo quanto Varisco disse a Zamberletti, «probabilmente il messaggero di questo contatto era stato direttamente o indirettamente l'onorevole Signorile» e la notizia gli fu poi confermata dallo stesso Cossiga. Infine, Zamberletti seppe da Cossiga che l'ipotesi dell'incontro era svanita.
Zamberletti ha poi ricordato che in quel periodo gli accadde di incontrare più volte a Montecitorio Sandro Pertini, che, essendo ostile alla possibilità di trattare, lo invitava a dire a Cossiga di non cedere e non ascoltare chi sosteneva la linea della trattativa.
Il Presidente ha richiamato dichiarazioni del 2001 di Nicola Lettieri (Sottosegretario all'interno nel 1978), secondo cui la notizia del possibile contatto a lui fu data dal comandante generale dei Carabinieri, Pietro Corsini.
Riguardo a dichiarazioni di Cossiga, secondo cui furono Varisco o Zamberletti ad appurare che si trattava di un millantatore, e nella vicenda entrava in qualche modo un confessionale a Milano, Zamberletti ha detto di non saperne nulla.
Sulla dimensione internazionale del terrorismo, l'audito ha affermato che in quel periodo si stava avviando la fase dei governi di solidarietà nazionale ed erano presenti «preoccupazioni parallele» da parte sovietica e da parte occidentale; di qui la sua persuasione che il terrorismo non fosse eterodiretto, ma fosse certamente tenuto sotto controllo, osservato dalle due superpotenze.
Rispondendo a una specifica domanda, Zamberletti ha smentito di aver commissionato nel giugno 1978 uno studio a un giornalista americano di nome Webster Tarpley, affermando di non averlo neanche mai conosciuto.
Riguardo alla fase della riorganizzazione dei servizi di informazione, con la nascita del SISMI e del SISDE, alla quale prese parte quando era Sottosegretario all'interno, Zamberletti ha ricordato di aver suggerito - trovando il pieno consenso di Cossiga - la nomina del generale Giulio Grassini, da lui conosciuto personalmente, come capo del nuovo servizio per la sicurezza interna, il SISDE. Quanto al generale Giuseppe Santovito, capo del SISMI, l'audito ha ricordato che in seguito lo conobbe, in occasione della conclusione del trattato sulla garanzia della neutralità di Malta, al quale il generale era contrario. Il trattato, ha proseguito Zamberletti, era contrario agli interessi della Libia, poiché Malta «in quel momento era un protettorato libico», e la Libia reagì con veemenza.
In risposta a una domanda del Presidente, Zamberletti ha dichiarato che, secondo la sua opinione, Israele e la Libia non furono particolarmente attivi nella vicenda del rapimento di Moro, pur essendone osservatori attenti.
L'onorevole Grassi ha chiesto all'audito se riteneva che il Governo e la DC avessero fatto qualcosa per salvare Moro. Zamberletti ha risposto che nella DC vi erano persone, come Fanfani, favorevoli alla trattativa, ma che la preoccupazione della DC e del PCI era che «una trattativa sul caso Moro avrebbe creato un precedente gravissimo per quanto riguarda il rapporto non solo con il terrorismo, ma anche per i rapporti interni tra i partiti»; prevalse quindi la linea della fermezza. Ha aggiunto che la volontà di liberare Moro si espresse cercando «trattative collaterali per strappare informazioni».
Menzionando la liberazione del generale Dozier, Zamberletti ha negato che in quella occasione per ottenere informazioni utili alla liberazione fosse stata usata la tortura, mentre il senatore Gotor ha riaffermato che essa venne usata.
Riguardo all'affiliazione del generale Grassini alla loggia P2, l'audito, rispondendo all'onorevole Grassi, ha dichiarato di aver appreso tale circostanza solo in seguito e ha specificato che, se avesse saputo dell'iscrizione alla loggia massonica, non avrebbe proposto la nomina di Grassini a capo del SISDE.
Circa l'omicidio del colonnello Varisco, Zamberletti ha affermato che, a suo giudizio, si trattò di una vendetta delle BR verso «un uomo che aveva lavorato veramente al servizio dello Stato», aggiungendo che il colonnello «era il più grande conoscitore dei misteri delle carceri romane».
Il 15 febbraio 2017 la Commissione ha svolto l'audizione di Luigi Ferlicchia, che all'epoca del sequestro Moro era segretario provinciale della Democrazia cristiana di Bari.
L'audito ha esordito ricordando che l'impostazione della DC fu subito di assoluta rigidità, mentre la DC pugliese era in favore di iniziative per salvare Aldo Moro e fece pressioni in tal senso.
Ha rievocato una visita alla sede nazionale della DC, in piazza del Gesù a Roma, da lui compiuta il 4 aprile 1978, in occasione della quale incontrò Giuseppe Pisanu e Umberto Cavina, che gli raccontarono che poco prima era stato lì Romano Prodi e aveva comunicato che in una seduta spiritica era emerso il nome «Gradoli» (secondo il ricordo dell'audito l'indicazione fornita da Prodi era «Gradoli 96 11»). Cavina gli disse di aver appena inviato il biglietto, tramite corriere motociclista, a Luigi Zanda, addetto stampa del Ministro dell'interno Cossiga. Ferlicchia ha affermato che Cavina e Pisanu erano esterrefatti, turbati e contrariati e che, in particolare, Pisanu disse: «Ci vengono a raccontare le storie degli spiriti e non ci danno elementi per poter agire».
Luigi Ferlicchia ha dichiarato che, in riferimento alle iniziative che la DC pugliese cercava di prendere, Pisanu disse: «Fate tutto quello che ritenete», aggiungendo che gli esponenti della DC pugliese erano considerati dai vertici del partito quasi come se fossero i parenti di Moro: «Eravamo come i parenti stretti e, quindi, in parenti stretti nel dolore erano autorizzati a fare qualunque cosa».
Ha fatto riferimento a un appello promosso dai democratici cristiani pugliesi, che venne pubblicato verso la metà di aprile sul quotidiano del partito, «Il Popolo», sebbene dopo due giorni nei quali era stato bloccato, e ha aggiunto che tale iniziativa creò preoccupazione, ricordando che il console americano a Napoli si recò due volte a Bari per chiedere ai vertici della DC pugliese informazioni sulle loro iniziative e sui loro contatti.
Ferlicchia ha anche riferito di essere stato presente a un colloquio, avvenuto anch'esso verso la metà di aprile, tra il Sottosegretario alla giustizia Renato Dell'Andro, parlamentare pugliese molto legato a Moro, e l'onorevole Franco Salvi, collaboratore di Zaccagnini, nella sede di piazza del Gesù. Nel colloquio - ha riferito l'audito - Salvi invitò fermamente Dell'Andro a non assumere alcuna iniziativa, gli ribadì che la linea della DC era "no alla trattativa" e aggiunse: «Se vuoi, ti dimetti da Sottosegretario e fai quello che credi». Dell'Andro e la DC barese continuarono però «sulla linea delle varie iniziative e dei vari contatti» e i rapporti tra Salvi e Dell'Andro cessarono per due anni, prima di una riconciliazione avvenuta nel 1980. Ha affermato che Salvi e Giovanni Galloni (che teneva i collegamenti tra la segreteria della DC e il Ministero dell'interno) erano tra i dirigenti della DC
più rigidi nella linea contraria alla trattativa. In un successivo passaggio dell'audizione, in risposta a una domanda del senatore Corsini, l'audito ha detto di ritenere che Salvi aveva al riguardo una sua ferma convinzione
L'audito ha poi rievocato la vicenda relativa alla possibile grazia per Paola Besuschio, detenuta che non era accusata di delitti di sangue e ha narrato di essere stato testimone di un colloquio telefonico, avvenuto nel pomeriggio del 5 maggio 1978, nel quale il Sottosegretario Dell'Andro disse a Eleonora Moro: «Signora, stia tranquilla. Domani mattina alle ore 9-9.15 io sarò al Ministero e il tutto sarà dirottato verso la Presidenza della Repubblica». Ha aggiunto che l'indomani, però, la situazione risultò cambiata: «Andreotti avrebbe consigliato al Ministro di grazia e giustizia di orientarsi per la grazia su Buonoconto anziché sulla Besuschio perché [...] alla Besuschio la grazia non poteva essere concessa perché aveva altre pendenze».
Luigi Ferlicchia ha poi voluto soffermarsi sulla vicenda dello studente sovietico Sokolov, che frequentò le lezioni universitarie di Moro, sottolineando che Dell'Andro ne rimase colpito, anche perché aveva talora sostituito Moro nella cattedra universitaria quando questi non poteva tenere lezione, e quindi, secondo l'audito, «Dell'Andro fa le sue affermazioni sullo studente sovietico [...] perché dall'interno, nell'università, ha percepito, ha visto, ha constatato, ha conosciuto, ha saputo».
Rispondendo a domande sulla sua reazione quando seppe della scoperta del covo di via Gradoli, dal momento che circa due settimane prima aveva saputo dell'indicazione «Gradoli» prevenuta tramite Prodi, Ferlicchia ha risposto che non gli venne in mente di rivolgersi allo stesso Prodi (che non conosceva personalmente) e che i dirigenti della DC pugliese reagirono polemicamente: «Questo è stato detto: "diamine, farsi sfuggire così le cose!"».
In risposta a domande dell'onorevole Grassi, l'audito ha ricordato che persone della Questura e della Prefettura avvicinarono i dirigenti della DC barese quando stavano organizzando una manifestazione (poi annullata) da tenersi a Roma, con i pullman che dovevano portare le persone dalla Puglia. Nella stessa occasione - ha detto Ferlicchia - Pisanu lo invitò «a tenere conto di tutti gli aspetti del problema».
Infine, Luigi Ferlicchia ha affermato che molti dirigenti della DC pugliese, dopo il sequestro e l'omicidio di Moro, subirono un'emarginazione: «Siamo stati praticamente presi, reietti, congelati»; ha inoltre ricordato che ancora durante il sequestro, il 31 marzo, fu presentata una mozione di sfiducia contro il sindaco moroteo di Bari, firmata anche da 10 consiglieri comunali della DC.
Una delegazione della Commissione si è recata il 20 marzo 2017 a Torino per procedere all'audizione di Guido Bodrato che, nel periodo del sequestro Moro, era membro della segreteria politica della Democrazia cristiana e faceva parte della delegazione che, insieme al segretario Zaccagnini, fungeva da punto di riferimento del partito in quel periodo.
Circa il dibattito interno alla DC, Bodrato ha affermato che nessuno si attendeva quello che accadde e né la politica né le istituzioni dello Stato erano preparati, sebbene il fenomeno terroristico fosse già presente da tempo. Ha ricordato che in quel periodo incontrava spesso il generale Siracusano, comandante regionale dei Carabinieri del Lazio, per avere informazioni dirette.
L'audito ha ricordato che la posizione emersa immediatamente, fin dal primo incontro che si svolse a Palazzo Chigi appena giunta la notizia del rapimento, fu «una risposta pressoché unanime di rifiuto di qualunque ricatto terroristico», nella convinzione che qualsiasi cedimento avrebbe causato un incremento del terrorismo. Sulle motivazioni per le quali dopo il rapimento non fu convocato il consiglio nazionale della DC, Bodrato ha ricordato anzitutto che la direzione si riunì più volte, e ha detto che la difficoltà a riunire il Consiglio nazionale nasceva dalla considerazione che poi ci sarebbe stato un inevitabile irrigidimento della posizione. Ha aggiunto che alcuni, come Dell'Andro e Misasi, avevano un atteggiamento diverso, ma ha sostenuto che Fanfani non era tra questi e ha affermato che «la difficoltà di passare da uno stato d'animo a una posizione politica è la difficoltà che ha
caratterizzato questa situazione». Rispondendo a una domanda del Presidente sulla grazia a Paola Besuschio, Bodrato ha affermato che un tale atto non avrebbe risolto nulla perché le Brigate rosse non chiedevano atti umanitari, bensì un riconoscimento politico.
Ha poi rammentato che il 3 maggio vi fu un incontro del gruppo che nella DC seguiva la vicenda, nelle cui conclusioni, in sostanza, era contenuto una sorta di messaggio ai terroristi: «Se voi assumerete una posizione rispettosa verso Moro, le forze politiche che sono oggi in contrasto con voi ne terranno conto»; tale posizione fu poi criticata da più parti, ad esempio da Almirante, come una forma di trattativa. L'audito ha sintetizzato la difficoltà della situazione dicendo: «La questione era: una atto attraverso il quale si esce da questa stagione o un atto attraverso il quale questa stagione viene legittimata a estendersi?».
Riguardo alle varie iniziative umanitarie, Bodrato ha affermato che a DC non le ostacolò - perché non erano un problema del partito, ma di chi era al Governo - ma neppure ritenne che avrebbero portato a superare la minaccia terroristica. Ha ricordato che in quei giorni gli attentati si susseguirono a Torino, Savona, Genova, Roma, Napoli e in Veneto.
Il senatore Fornaro ha osservato che tre anni più tardi, quando fu rapito Ciro Cirillo, la linea della fermezza non fu più seguita. Bodrato ha replicato che ciò avvenne perché in quel caso i rapitori accettarono il denaro. Ancora rispondendo a una domanda del senatore Fornaro l'audito ha detto che la DC non aveva canali particolari con la diplomazia americana o con i partiti americani: i rapporti erano tra Stati, anche se ha ricordato che in anni precedenti al sequestro Moro egli aveva scambi di opinioni ogni settimana con Vincent Cannistraro, collaboratore dell'ambasciatore degli Stati Uniti John Volpe.
Bodrato ha espresso l'opinione che un fenomeno fondato sulla clandestinità come quello del terrorismo fosse infiltrabile, ma che «aveva una sua radice e una sua originalità assolutamente nazionali». Ha quindi ricordato di aver posto a Franco Bonisoli, pochi mesi prima dell'audizione, una domanda sull'eventuale presenza in via Fani di una persona molto abile a sparare che aveva aiutato i brigatisti, e che Bonisoli aveva risposto: «Ero io. Io so sparare benissimo, io ho colpito Leonardi». Il senatore Fornaro ha subito rilevato che la notizia che l'uccisore di Leonardi fosse stato Bonisoli costituiva una cospicua novità rispetto alla ricostruzione dell'agguato contenuta nel "memoriale Morucci". Successivamente all'audizione, il 31 marzo 2017, Guido Bodrato ha inviato una precisazione: «Bonisoli [...] ha smentito quelle parole. Mi sono chiesto se ho capito bene ciò che mi ha detto o se [...] le ho
interpretate male. [...] In via Fani ha sparato anche Bonisoli. Tuttavia, di fronte alla smentita sull'uccisione di Leonardi, non posso, in coscienza, ripetere ciò che - su quel punto - è registrato nell'audizione».
L'audito ha poi voluto ricordare che un giurì d'onore stabilì l'infondatezza dell'accusa, mossa contro di lui nell'ottobre del 1978, di essere intervenuto in Vaticano durante il sequestro Moro per far cambiare la posizione di Paolo VI.
Riguardo ai rapporti e alla comunicazioni sul progresso delle indagini che avvenivano tra il Governo e la DC, l'audito ha risposto che la segreteria e i presidenti dei due gruppi parlamentari si riunivano quasi quotidianamente e che le informazioni giungevano, soprattutto attraverso i capigruppo, il segretario Benigno Zaccagnini e il vicesegretario Giovanni Galloni; quest'ultimo teneva anche i rapporti con il PCI.
Il senatore Buemi ha riferito l'impressione a lui comunicata in anni recenti da Valerio Zanone (che nel 1978 era segretario del Partito liberale), secondo cui «la liberazione di Aldo Moro non fosse l'obiettivo che interessava perseguire in quel momento alle istituzioni repubblicane». Bodrato ha replicato affermando che «il problema di quei giorni di come liberare Moro, più che come trattare per liberare Moro», riconoscendo che comunque c'erano anche persone che erano interessate alla fine di Moro e della sua politica.
Il Presidente ha quindi richiamato un episodio svoltosi il 26 aprile 1978, quando, dopo un incontro di Zaccagnini con Craxi presso la sede del PSI, i due capigruppo della DC (Flaminio Piccoli e Giuseppe Bartolomei) protestarono, dicendo che simili passi potevano aprire una crisi. Bodrato ha ricordato, al riguardo, che vari esponenti della DC, tra i quali i due capigruppo, consideravano Zaccagnini una bravissima persona, priva però della necessaria energia,
Circa i rapporti tra i vertici della DC e la Santa Sede, Bodrato ha affermato che Zaccagnini aveva rapporti diretti attraverso monsignor Achille Silvestrini e che, per quanto a lui noto, non c'erano rapporti con monsignor Cesare Curioni; l'incarico dei rapporti ordinari con il Vaticano (non solo durante il periodo del sequestro) era affidato a Maria Eletta Martini. In risposta a una specifica domanda, ha dichiarato di non sapere nulla di una visita dell'abbé Pierre alla sede della DC in Piazza del Gesù.
Bodrato ha poi rievocato, in risposta a una domanda, un episodio avvenuto il 22 aprile 1978, quando arrivò alla Caritas Internationalis una telefonata in cui un sedicente brigatista chiese di parlare con lui. Recatosi alla sede della Caritas Internationalis, arrivarono due chiamate, alle quali rispose una persona della Caritas stessa, nelle quali una voce maschile chiese se ci fosse l'onorevole Bodrato e indicò di aspettare; l'attesa fu tuttavia vana, perché non giunsero altre chiamate.
Guido Bodrato, verso la fine dell'audizione, ha ribadito la sua convinzione che il movimento terrorista fosse «un fenomeno nato nel contesto culturale, politico e sociale di questo Paese. Poteva essere infiltrato, ma era un'operazione diversa. Non è che avessero un punto di comando estraneo a loro e loro fossero i killer».
4.5.Le audizioni di periti
Il colonnello Luigi Ripani e il tenente colonnello Paolo Fratini, rispettivamente comandante del Reparto investigazioni scientifiche (RIS) di Roma e capo della Sezione balistica del RIS stesso, sono stati ascoltati una prima volta nell'audizione iniziata nella seduta del 23 febbraio 2017 e proseguita nella seduta del 2 marzo successivo e una seconda volta nell'audizione svoltasi il 10 maggio 2017.
I due ufficiali dei Carabinieri hanno riferito sugli accertamenti tecnici relativi alle modalità in cui fu realizzato l'assassinio dell'on. Aldo Moro.
Nel corso della seduta del 23 febbraio 2017, il colonnello Ripani e il tenente colonnello Fratini hanno illustrato gli esiti degli accertamenti svolti, con l'ausilio di una rappresentazione grafica proiettata nel corso della seduta (una versione cartacea è stata allegata al resoconto stenografico dell'audizione, ad eccezione di alcune immagini relative all'esame autoptico). Il colonnello Ripani ha ricordato che nel settembre del 2015 la Commissione richiese al RIS una nota tecnica che individuasse, fra i reperti a disposizione, quale materiale potesse essere utilizzato per nuove analisi rispetto a quelle svolte in passato e ha affermato che sono stati cercati elementi oggettivi desumibili: dal sopralluogo e dal repertamento sulla scena del crimine (la Renault 4) dagli atti a disposizione della Commissione (i verbali di sopralluogo della Polizia scientifica all'epoca dei fatti); dalle analisi scientifiche delle tracce e dei reperti disponibili; dagli
esami medico legali a suo tempo eseguiti sul cadavere.
Il colonnello ha affermato che «sicuramente la Renault è la scena del crimine, che in tutto o in parte si è svolto all'interno dell'autovettura»; in merito all'esame merceologico del bottone che era presente nell'auto, ha evidenziato che negli abiti dell'onorevole Moro non mancava alcun bottone, quindi il bottone a suo tempo ritrovato (peraltro non presente tra i reperti a disposizione del RIS) era irrilevante. Quanto all'attività balistica, il colonnello Ripani ha dichiarato che tutti i bossoli e i proiettili repertati all'interno della Renault 4 sono stati «confrontati con le armi utilizzate, in ipotesi, per uccidere l'onorevole Moro». Sull'analisi di fibre rossastre menzionate nella cosiddetta "perizia Lombardi", ha riferito che tali fibre non erano presenti nei reperti ottenuti dal RIS e ha aggiunto che non erano stati reperiti neanche i due bossoli calibro 32 che secondo il professor Ugolini recavano tracce
di vernice rossa. Ha ricordato poi che alcuni accertamenti di natura biologica sull'interno dell'auto erano stati affidati alla Polizia scientifica.
Nel descrivere il metodo utilizzato, il colonnello Ripani ha spiegato che si è cercato di desumere dai dati derivanti dal sopralluogo e dal repertamento, dagli esami di laboratorio e da quelli medico legali tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica del delitto.
Il tenente colonnello Paolo Fratini ha illustrato le metodologie di analisi balistica usate, iniziando dal proiettile e dal bossolo calibro 9 repertati, che sono stati confrontati con la pistola Walther sequestrata nel covo di via Silvani, a Roma, nel 1980. Il tenente colonnello ha spiegato che l'indagine balistica è stata di tipo comparativo, per cercare di capire se il bossolo fosse stato esploso da quell'arma, da armi simili oppure da armi completamente diverse, e che dagli accertamenti è risultata una identità balistica, quindi il bossolo calibro 9 è stato esploso proprio dalla pistola in esame.
Il tenente colonnello Fratini ha proseguito riferendo che con analoga procedura sono state effettuate le comparazioni balistiche tra i proiettili calibro 7.65mm repertati e quelli ottenuti dal test di sparo con la mitraglietta Skorpion e che, anche in questo caso, gli accertamenti hanno consentito di dimostrare che i dieci proiettili calibro 7.65 mm in reperto sono stati sparati dalla Skorpion, senza però poter indicare se con o senza silenziatore.
È quindi intervenuto nuovamente il colonnello Ripani, sottolineando che due fori presenti nella parte posteriore della giacca di Moro (prodotti quindi da due proiettili che ne hanno attraversato il corpo) sono correlati, in quanto posti alla stessa distanza tra loro, ad altrettanti fori presenti nella coperta in cui era avvolto, nella parte che era sotto il corpo.
Riguardo al campionamento con stub del tettuccio dell'autovettura per la ricerca di residui dello sparo, il colonnello ha riassunto i risultati delle analisi: nell'abitacolo della Renault 4 (sull'aletta parasole destra) è stata rinvenuta una particella che potrebbe essere la superstite di una più ampia quantità di particelle originariamente presenti, ovvero il risultato di un inquinamento accidentale; sul cappotto di Moro che era presente (non indossato) nella Renault 4 sono state trovate nove particelle, che indicano che l'indumento era vicino a un'attività di sparo; sulla giacca della vittima sono state rinvenute numerosissime particelle, il cui numero elevato indica un'estrema vicinanza dell'indumento a un'attività di sparo; sui pantaloni della vittima le particelle risultano in numero minore, ma comunque rilevante, rispetto alla giacca.
Il colonnello Ripani è passato poi a illustrare i risultati (per i quali, come per altri elementi di dettaglio, si rinvia al resoconto stenografico e alle allegate immagini) della Bloodstain Pattern Analysis (BPA), branca delle scienze forensi che studia i meccanismi di formazione delle tracce ematiche, eseguiti sugli indumenti di Moro e sul tappetino del portabagagli, sul finestrino posteriore sinistro e sul tettuccio della Renault 4.
Mostrando l'immagine di un foro d'ingresso di un proiettile sulla giacca e sul gilet della vittima, il colonnello ha indicato che è ragionevole supporre che il colpo sia stato «sparato con il silenziatore a contatto, in maniera ortogonale».
Il colonnello Ripani ha evidenziato che le osservazioni effettuate «supportano una fase della dinamica delittuosa con almeno due spari mentre la vittima era supina sul pianale del portabagagli, adagiata sulla coperta [...], più o meno nella posizione in cui è stato ritrovato». Ha proseguito asserendo che, mentre uno dei due proiettili i cui fori sono visibili sia sulla parte posteriore della giacca sia sulla coperta era il calibro 9 mm corto ritrovato sul pianale, sparato dalla pistola semiautomatica Walther, l'altro deve essere stato prodotto da un proiettile mai repertato. Pertanto, secondo i risultati degli accertamenti del RIS riferiti dal colonnello Ripani, «contrariamente a quanto riportato in atti», Moro è stato colpito da dodici proiettili e non undici: otto calibro 7,65mm estratti dal cadavere durante l'autopsia; due calibro 7.65 mm, ritrovati tra la maglia a carne e la camicia; due fuoriusciti dal
corpo, perforando la giacca e la coperta (dei quali uno solo repertato, sul pianale del portabagagli, calibro 9 mm).
Il tenente colonnello Fratini ha osservato che parte della coperta doveva trovarsi sotto il corpo, mentre l'altra non poteva ricoprirlo completamente, altrimenti sarebbe stata perforata dai proiettili.
Riguardo alla posizione del tiratore (o dei tiratori), il colonnello Ripani ha affermato che alcuni elementi (almeno tre colpi sparati ortogonalmente al torace, colature di sangue dall'alto verso il basso sulla maglia e proiezioni e colature di fluido biologico dall'alto al basso sui pantaloni) «supportano la fase della dinamica delittuosa in cui inizialmente la postura della vittima è con il busto eretto e, probabilmente, seduta, all'atto dei primi colpi esplosi con la Skorpion». Ha aggiunto: «Noi riteniamo che questi tre colpi ortogonali possano essere i primi dell'azione delittuosa. Durante l'esplosione di tali colpi, che non viene escluso che l'onorevole Moro abbia proteso in avanti la mano sinistra in un gesto istintivo di autodifesa e che il relativo pollice sia stato trafitto».
Il colonnello ha delineato quindi due ipotesi. Nella prima, meno probabile, la postura della vittima con il busto eretto e, probabilmente, seduta, al momento dei primi colpi esplosi con la Skorpion «supporterebbe una ricostruzione in cui la Skorpion ha esploso almeno cinque colpi nell'abitacolo della Renault 4 e Aldo Moro è stato attinto all'emitorace sinistro dall'avanti all'indietro mentre era seduto» (in tale ipotesi, secondo quanto ha dichiarato il colonnello, «è plausibile che la vittima fosse seduta sul sedile posteriore»),per essere poi spostato nel portabagagli dove sarebbe stato colpito da almeno altri due colpi (uno sparato dalla Skorpion e uno dalla pistola Walther).
Il colonnello Ripani ha esposto poi una seconda ricostruzione, ritenuta più probabile da lui e dai suoi collaboratori. Secondo tale ipotesi, Aldo Moro sarebbe stato seduto sul pianale, con il busto eretto e le spalle rivolte verso l'interno dell'abitacolo, e in questa posizione sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi sparati dalla Skorpion, con direzione pressoché ortogonale al torace; successivamente si sarebbe accasciato con il busto all'indietro e in questa posizione sarebbe stato raggiunto da almeno altri due colpi, uno sparato dalla Walther calibro 9 e uno sparato dalla Skorpion.
Il seguito dell'audizione, nella seduta del 2 marzo 2017, è stato caratterizzato dalle richieste di chiarimenti dei componenti della Commissione. Nelle risposte, il colonnello Ripani ha confermato che secondo gli accertamenti eseguiti, il RIS ritiene che Moro sia stato raggiunto dai primi colpi mentre era con il busto eretto, probabilmente seduto, sebbene non si possa del tutto escludere - «in maniera residuale» - che fosse in piedi. Successivamente, almeno due colpi raggiunsero Moro mentre era sul pianale del bagagliaio della Renault. Riguardo al silenziatore, il colonnello ha specificato l'unico presente nei reperti, quello (realizzato in modo artigianale) della Skorpion, non corrisponde al segno lasciato sugli indumenti di Moro da un colpo sparato a contatto con un silenziatore; di qui, due ipotesi: «O un altro silenziatore era montato sulla Walther [...] ovvero [...] la Skorpion ha sparato con un ulteriore silenziatore». Il
colonnello Ripani ha anche espresso l'opinione che i primi colpi abbiano raggiunto la vittima, seduta, probabilmente fuori dall'auto, premettendo comunque che si trattava di «ipotesi più o meno ragionevoli, però non vi è certezza».
Per i particolari delle altre risposte fornite dai due ufficiali del RIS, si rinvia al resoconto stenografico della seduta.
Nell'audizione del 10 maggio 2017 sono stati illustrati gli esiti preliminari (destinati ad essere approfonditi una volta acquisiti tutti i dati, come ha precisato il colonnello Ripani) degli ulteriori accertamenti effettuati dal RIS il 4 maggio 2017 in via Camillo Montalcini 8 con la partecipazione di alcuni componenti della Commissione; in particolare, prove di ingombro dell'autovettura all'interno del box e prove d'ascolto relative al rumore prodotto dai colpi d'arma da fuoco sparati all'interno del box Il colonnello Ripani ha presentato la metodologia seguita e ha specificato, rispondendo al senatore Fornaro, che nel 1978 il box non aveva una chiusura a serranda, come appare attualmente, bensì a porta basculante.
Per quanto attiene alla posizione della macchina all'interno del box, il colonnello ha informato che è stata utilizzata una vettura del tutto uguale a quella del tempo. Ha poi illustrato, anche in questo caso con l'ausilio di una rappresentazione grafica proiettata nel corso della seduta (una cui versione cartacea è stata allegata al resoconto stenografico dell'audizione), gli spazi disponibili nel box con l'auto all'interno e il portellone dell'auto aperto (posizione possibile solo con la porta basculante del box aperta). Sempre con l'aiuto della grafica, nonché di registrazioni sonore, il colonnello ha esposto metodologia e risultati della prova d'ascolto dei colpi esplosi con la mitraglietta Skorpion calibro 7,65 e con la pistola Walther calibro 9, spiegando che gli ascoltatori erano stati collocati nella tromba delle scale e nell'androne, ma non all'interno degli appartamenti. Ha affermato che «la sperimentazione che abbiamo
fatto, cioè i rumori che noi abbiamo prodotto con gli spari, per tutta una serie di motivi noi li consideriamo "per eccesso", cioè probabilmente abbiamo prodotto dei rumori a quelli all'epoca sentiti». Il colonnello Ripani ha così riassunto gli esiti della prova d'ascolto: «Più ascoltatori differentemente posizionati hanno percepito un numero minore di esplosioni rispetto a quello effettivo, quindi c'è una difficoltà di rilevare distintamente le esplosioni che si susseguono nella raffica. Come è lecito attendersi, i locali dove maggiormente sono avvertibili le esplosioni, quelli più vicini, sono quelli dell'androne [...] e lo spazio esterno [...]. Spostandosi verso i piani alti, i colpi si avvertono, di norma, sempre più debolmente». Ha aggiunto che il silenziatore della Skorpion «funziona male, non è efficiente, ma comunque è efficace» e che
«ipotizzando l'uso di un silenziatore adeguatamente efficace, o comunque più efficace, e il posizionamento dell'ascoltatore all'interno di un'abitazione, è plausibile attendersi a livello percettivo un segnale audio di debolissima intensità».
Anche per la seduta del 10 maggio 2017 si rinvia, per elementi più dettagliati, al resoconto stenografico della seduta e al relativo allegato.
4.6. Le audizioni di appartenenti a Servizi di sicurezza e a Reparti speciali
Per chiarire alcuni aspetti connessi all'inchiestasono stati ascoltati dalla Commissione Paolo Inzerilli, ex ufficiale dell'Esercito che all'epoca del sequestro Moro già a capo della struttura Stay-behind, e Oreste Tombolini, ex ufficiale della Marina, che allora era in servizio presso il Comando subacquei e incursori.
La Commissione ha ascoltato Paolo Inzerilli, che guidò l'organizzazione Gladio dal 1974 al 1986, in due distinte audizioni, svoltesi l'8 marzo e il 23 maggio 2017. Nel corso della seduta dell'8 marzo 2017, il generale Inzerilli ha riferito che durante il sequestro Moro la struttura da lui comandata non ebbe alcun compito operativo, né fu mai attivata; si svolse invece un'esercitazione già programmata, utile anche - a causa della presenza di numerosi posti di blocco durante quel periodo - a saggiare la resistenza allo stress del personale civile che stava terminando il corso di addestramento: «Dover passare [...] in mezzo a posti di blocco [...] nascondendo una persona dentro un furgone pieno di casse di materiale elettrico comportava una certa necessità di avere i nervi saldi». L'audito ha precisato che, comunque, dietro al furgone c'era un'auto con un capitano dei Carabinieri, che sarebbe intervenuto in
caso di necessità per chiarire la situazione.
Il generale Inzerilli ha specificato, con diversi esempi, la differenza esistente tra "sensibilizzazione" (che ebbe luogo) e "attivazione" (che invece non si verificò) della struttura, affermando: «Quello che io avevo disposto per tutte le reti esistenti era che [...] dessero un'occhiata in giro, nel senso che cose strane, movimenti strani, potevano significare qualcosa.»
Rispondendo a domande del Presidente, l'audito ha affermato di aver parlato di tre Gladio, quella «bianca», da lui diretta, quella «rossa», che era quella del Partito comunista (soprattutto negli anni '50), e quella «nera», cioè i Nuclei di difesa dello Stato (NDS), «molto infiltrato da parte della destra dell'epoca». Ha dichiarato che lungo gli anni fu distrutta molta documentazione di Gladio, «in quanto non considerata più necessaria», anche in obbedienza a una direttiva dell'Ufficio centrale sicurezza interna (UCSI) che prescriveva di distruggere tutta la documentazione non necessaria.
L'audito ha anche ricordato che fino al 1975 il Servizio non ha mai effettuato un briefing a nessuna autorità politica sulle attività dello stay-behind, ma solo al Capo di Stato maggiore della difesa; da quell'anno invece vennero informati i Ministri della difesa, che erano tenuti a non divulgare le informazioni e, pertanto, Moro «in teoria - ripeto, in teoria - non doveva saperne assolutamente nulla». Ha specificato che si trattava di un briefing nel quale non erano contenute indicazioni di carattere operativo tali da consentire di ricostruire quante erano le reti e dove erano dislocate, ad esempio.
Inzerilli ha osservato che Moro, nel suo "memoriale", ha parlato di controguerriglia, mentre lo Stay-behind, fino al 1977-78, era diretto a svolgere attività di guerriglia contro eventuali invasori, per rallentarne l'eventuale avanzata. Nell'audizione del 23 maggio ha poi spiegato più diffusamente che dal 1975-76 e fino agli anni '90, le attività più importanti (non solo in Italia, ma a livello NATO) divennero quella informativa e quella di evasione ed esfiltrazione (recupero di piloti di aerei abbattuti).
Il senatore Fornaro è intervenuto rilevando che nella sentenza del 2001 con la quale il generale Inzerilli fu assolto, si afferma che autorità politiche furono informate sull'attività di Stay-behind anche prima del 1975: Andreotti nel 1960, Cossiga nel 1967, Gui nel 1968.
Inzerilli ha proseguito ricordando che l'ammiraglio Fulvio Martini, quando assunse la direzione del SISMI, estese la comunicazione del briefing anche al Presidente del Consiglio dei ministri e ai capi di Stato maggiore delle tre Forze armate.
Riguardo alla conoscenza della struttura Stay-behind da parte di Moro, il Presidente ha richiamato una dichiarazione di Taviani, secondo cui Moro la designava con la denominazione «SID parallelo»; perciò Moro, anche se forse non ne aveva una conoscenza approfondita, doveva comunque sapere della sua esistenza.
Riguardo al colonnello Camillo Guglielmi, Inzerilli ha riferito di averlo conosciuto solo verso la fine del 1978 e poi durante la preparazione di alcuni corsi addestrativi denominati TED (tiro, esplosivi e difesa personale; l'addestramento relativo agli esplosivi, ha precisato l'audito, era in funzione antiterrorismo, per neutralizzare ordigni).
Sulle affermazioni di Antonino Arconte, l'audito ne ha affermato l'infondatezza, affermando che non è mai esistita una sigla composta da una lettera dell'alfabeto e un numero di sole due cifre come G71 e che Arconte risulta aver ricoperto il grado di "comune di seconda classe", non di capitano, grado peraltro non previsto in Marina se non con le specificazioni "capitano di corvetta", "capitano di fregata" e "capitano di vascello"; infine, secondo Inzerilli è inverosimile che un ordine operativo di quel genere venga messo per iscritto, che provenga dal capo ufficio del personale e che una lettera fosse controfirmata dall'ammiraglio Martini, il quale non controfirmava mai lettere scritte da altri. Inzerilli ha dichiarato anche che Arconte si imbarcò effettivamente alla Spezie sulla nave Jumbo M, rimanendovi però per sei mesi e rivestendo la qualifica di "ingrassatore di macchina".
In merito ai Nasco il generale Inzerilli ha affermato che erano nascondigli scavati nel terreno, quindi privi di serrature con chiavi, nei quali il materiale veniva collocato in contenitori in plastica antiroditori, oppure in cassette metalliche depressurizzate. Ha precisato che nel 1972 tutti i Nasco furono ritirati, ad eccezione dei dodici recuperati nel 1991 dal giudice Mastelloni.
Circa le liste distrutte nel 1973 dal colonnello Cismondi, l'audito ha dichiarato che non erano elenchi della Gladio, ma di personale della cosiddetta "organizzazione O", creata nel dopoguerra e durata fino al 1956.
Il generale Inzerilli ha affermato che all'interno del Servizio non venne mai stato fatto alcun accostamento tra Gladio e vicenda Moro e che, invece, l'accostamento del ritrovamento delle carte di via Monte Nevoso con la Gladio è riconducibile alla Procura di Roma.
In riferimento a una dichiarazione fatta da Alberto Franceschini nella sua audizione del 27 ottobre 2016, richiamata dal senatore Fornaro, Inzerilli ha precisato di non aver mai partecipato a nessun convegno insieme a Franceschini, specificando di averlo conosciuto per caso a casa di una terza persona, e ha affermato e che quanto raccontato da Franceschini non era vero. L'audito ha comunque ricordato che a metà degli anni '70 «il Servizio era convinto che Hypérion fosse un punto di contatto fra terroristi di varie nazionalità, in particolare Brigate rosse e RAF». Ha anche escluso qualsiasi contatto tra Gladio e i Comitati di resistenza democratica di Edgardo Sogno e ha detto di non ricordare lo svolgimento di esercitazioni di Gladio insieme a personale di altri Paesi durante il periodo del sequestro Moro.
In risposta a un quesito dell'onorevole Grassi, il generale Inzerilli ha affermato di aver appreso dell'esistenza dei Nuclei di difesa dello Stato solo in occasione di un interrogatorio subito da parte del giudice Salvini e di aver ribadito le proprie dichiarazioni in un'intervista al quotidiano «Il Tempo» del 27 febbraio 2017, secondo cui Andreotti potrebbe aver rivelato l'esistenza della Gladio per dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto alle indagini sui Nuclei di difesa dello Stato; al riguardo ha ricordato che Andreotti dichiarò erroneamente che la Gladio era stata sciolta nel 1972-73, mentre in realtà in quegli anni era stata sciolta la struttura NDS.
L'audizione di Paolo Inzerilli del 23 maggio 2017 è stata richiesta dall'onorevole Bolognesi, che ha posto una serie di domande.
Il generale Inzerilli ha risposto anzitutto sulla circostanza che in occasione del sequestro Moro la Gladio non fu attivata, mentre lo fu per il sequestro Dozier. Al riguardo, ha affermato che all'epoca della vicenda Moro la Gladio dipendeva dall'Ufficio "R" ed era una sezione a sé stante, mentre durante la vicenda Dozier dipendeva dalla VII Divisione, che aveva anche molti altri compiti. Ha specificato che per il sequestro Dozier fu impiegato il personale di tutta la VII Divisione, ma non il personale civile della Gladio.
Sul numero di «gladiatori» civili presenti a Roma nel 1978, Inzerilli ha risposto che erano pochissimi, non più di uno o due; la sensibilizzazione però riguardò tutta l'organizzazione. Circa le modalità gerarchiche dell'attivazione della struttura per effettuare operazioni o esercitazioni, nonché sull'eventuale presenza di documentazione, Inzerilli ha affermato: «Eravamo completamente autonomi [...]: comunicavamo noi allo Stato maggiore della difesa o al Ministro se era necessario che facessimo un certo tipo di esercitazioni [...]. Nessuno ci ha mai chiesto di fare nulla, a nessun livello»; ha aggiunto che esisteva la documentazione relativa a tutte le esercitazioni.
In riferimento all'approvvigionamento di Gladio, all'autonomia di scelte di spesa e quindi alla procedura per la fornitura di armi e di esplosivo, Inzerilli ha risposto che dal 1977 era sufficientemente autonomo dal punto di vista della spesa, nel senso che gestiva direttamente i fondi che gli venivano assegnati.
A specifiche domande circa gli elicotteri utilizzati da Gladio, Inzerilli ha risposto che gli elicotteri provenivano dalla Difesa e stavano ad Alghero e che almeno fino al 1980 non si disponeva di elicotteri; ha poi soggiunto: «Il Servizio aveva questi elicotteri basati lì, che non erano proprio elicotteri del Servizio, erano basati presso la compagnia aerea del Servizio». Alla domanda sulla presenza anche di elicotteri senza insegne, Inzerilli ha risposto: «Una cosa sono gli elicotteri che stavano ad Alghero ed erano delle Forze armate, in carico al Servizio [...]; poi c'erano degli elicotteri civili basati presso la Compagnia aerea italiana, la CAI, che gestiva i Falcon, ma non gestiva gli elicotteri, che erano soltanto basati». Quando gli è stato chiesto di chiarire se con la parola «civili» intendesse riferirsi ad elicotteri senza insegne militari, l'audito ha risposto: «Non lo so, non mi
interessava, non sono mai salito a bordo». Ha poi affermato che la Gladio usava solo elicotteri militari, con le insegne, mentre gli altri «venivano usati dalla Protezione civile o dall'antincendio».
Riguardo ai luoghi di addestramento dei "gladiatori" in Italia, e in particolare in Sicilia, Inzerilli ha risposto di non ricordare esercitazioni avvenute in Sicilia e ha affermato che in genere le esercitazioni venivano svolte in Friuli-Venezia Giulia e poi a Roma, perché c'era la base di Cerveteri.
L'audito ha poi detto che non esistevano appartamenti a disposizione dei "gladiatori" (cioè dei civili) e che le donne "gladiatrici" erano sette od otto, al massimo dieci-undici, comunque pochissime. Ha ricordato che il SISMI iniziò a reclutare donne nel 1980, a parte le segretarie che c'erano anche prima, e che quindi da quel periodo iniziarono ad esservi istruttrici per la struttura Stay-behind.
Il generale Inzerilli ha escluso che siano stati effettuati addestramenti di civili aventi un'estrazione opaca o contigui ad ambienti criminali. Circa l'esistenza di irregolari che godevano di fatto di un percorso formativo e addestrativo, pur non risultando ufficialmente «gladiatori», Inzerilli ha riferito che ciò era accaduto nei primissimi anni '50, in Friuli. Ha poi negato energicamente che personaggi legati al terrorismo neofascista facessero parte della Gladio.
L'onorevole Bolognesi ha chiesto all'audito una valutazione tecnica dell'agguato di via Fani. Inzerilli ha osservato che una simile azione richiedeva persone veramente addestrate e che la scorta dell'onorevole Moro non risultò pronta a reagire. Ha aggiunto che per uccidere cinque persone lasciando illeso l'ostaggio «bisogna essere bravi».
In risposta a ulteriori domande, Inzerilli ha detto che in via Stresa 117 non esisteva una base della Gladio; che furono redatti più elenchi, fra cui uno di circa 800 nomi, che comprendeva i 622 nomi contenuti nell'elenco noto, che però non è affidabile perché redatto dalla I Divisione del SISMI, la quale non era «in condizione di fare un elenco di coloro che facevano parte della Gladio; poteva al massimo ricostruire quali erano i nominativi sui quali erano state richieste le informazioni».
A specifiche domande del senatore Fornaro, l'audito ha risposto confermando l'appartenenza di Enzo Tiberti alla struttura Gladio di Milano e ha riferito che, al primo congresso degli ex appartenenti a Gladio, nel 1995, Sogno venne inserito come socio d'onore, quale partigiano. Infine, in risposta all'onorevole Bolognesi, Inzerilli ha dichiarato di essere stato il fondatore dell'Ufficio K e sul rapporto tra Ufficio K e Gladio ha detto: «Zero. Istruttori di Gladio - parliamo degli istruttori dei civili - istruttori militari presi e reclutati dal sottoscritto su input dell'ammiraglio Martini per avere della gente di élite più di quanto fossero già o personaggi che facevano parte della VIII Divisione».
L'11 aprile 2017 si è svolta l'audizione di Oreste Tombolini, il quale ha specificato che all'epoca del sequestro Moro aveva il grado di tenente di vascello e faceva parte degli incursori della Marina.
L'ammiraglio Tombolini ha ricordato che in quel periodo si facevano esercitazioni e che «di tanto si partiva, si arrivava in un posto, che molto spesso non si conosceva, e poi, se si trattava di un'esercitazione, si continuava con l'esercitazione, e se invece era un'operazione [...] si ritornava indietro». Successivamente ha specificato che talvolta non si sapeva se si stava partendo per un'esercitazione o per un'operazione.
Circa l'annotazione, in data 21 marzo 1978, contenuta in un brogliaccio - acquisito presso il Ministero della difesa dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi- in cui è menzionato il «comandante GOS dottor Tombolini» in relazione alla possibile presenza di un ostaggio in un casolare in zona Forte Boccea e Aurelia, l'audito ha detto di non aver scritto lui l'annotazione e di supporre che GOS volesse dire Gruppo operazioni speciali, ma di non ricordare di essere mai stato il comandante del GOS; ha anche precisato che nel 1978 non aveva ancora conseguito il titolo di dottore.
Alle domande sulla catena gerarchica dei suoi superiori dell'epoca, l'audito ha risposto evitando di fare i nomi dei suoi superiori, confermando solo che il Biasin menzionato nel brogliaccio era il comandante del Gruppo incursori; in un successivo momento dell'audizione, subito dopo ulteriori domande sui nomi dei suoi superiori, la seduta è proseguita in forma segreta; e in un terzo momento, di fronte a ulteriori domande sui nomi dei comandanti dei team del COMSUBIN all'epoca del sequestro Moro, l'ammiraglio Tombolini ha suggerito di chiederli allo Stato maggiore della Marina e solo dopo molta resistenza ha menzionato i nomi di tre tenenti di vascello.
Tombolini ha poi dichiarato che in quel periodo «erano state sconvolte tutte le linee gerarchiche e funzionali, per cui arrivavano gli ordini da Roma [...], si chiamava il tizio e si diceva: "Tu fa' questo", ma non c'entrava niente con l'organizzazione funzionale».
Il senatore Gotor ha chiesto all'audito se avesse conosciuto Decimo Garau, ufficiale medico. Tombolini ha risposto che al COMSUBIN c'era un sottufficiale di nome Garau, ma non era un medico.
L'audito, rispondendo a ulteriori domande, ha dichiarato che per gli spostamenti si usavano elicotteri della Marina, di base a Luni, che recavano la scritta identificativa della Marina militare e ha affermato di non aver mai visto, in quel periodo di servizio, elicotteri senza segni identificativi; ha anche risposto che non gli risultava che i Servizi avessero la possibilità di usare elicotteri privi di insegne. Ha asserito di non aver mai lavorato con agenti di Gladio e di non aver mai avuto la percezione di cooperazione o commistione tra COMSUBIN e Gladio. Ha ricordato che personale dei Carabinieri e forse anche della Polizia si addestrava presso il COMSUBIN, ma ha escluso che venissero effettuate operazioni congiunte.
In risposta a una domanda del Presidente, l'audito ha detto di aver avuto l'impressione, quando si effettuavano le esercitazioni, che non si facesse sul serio.
Rispondendo a un quesito dell'onorevole Bolognesi, Tombolini ha affermato che l'esistenza di piani di intervento standard consentiva al team di poter operare in qualunque teatro operativo evitando l'effettuazione di briefing.
In risposta ad altre domande, l'audito ha precisato che nessun operatore del suo team, a termine di un'operazione, rimaneva sul teatro e che tutti rientravano sempre alla base; potevano rimanere sul teatro operativo una o due persone preposte all'acquisizione di informazioni operative, compito non spettante agli appartenenti al suo team.
4.7. Le altre audizioni
La Commissione ha svolto alcune audizioni connesse a filoni di audizioni iniziati negli scorsi anni: quella di Marco Benadusi si inserisce nella serie di studiosi della vicenda Moro e, più in generale, del terrorismo, ascoltati in passato; quella di Enzo Mosino si situa nell'ambito delle audizioni di autorevoli personalità vicine a protagonisti dell'epoca (il prefetto Mosino è stato per molti anni uno stretto collaboratore di Francesco Cossiga); quella di Bassam Abu Sharif, ha consentito di acquisire alcuni importanti elementi relativi al filone di indagine sui rapporti tra Italia e movimenti palestinesi; quella di Gianni Gennari completa il ciclo di audizioni dedicata al tentativo di trattativa promosso dalla Santa Sede; quella di Aldo Bonomi è connessa al filone della trattativa tentata da esponenti socialisti; quella di Antonio Ianni, infine, conclude la serie di audizioni di persone presenti a via Fani la mattina del 16
marzo 1978.
Nella seduta del 4 aprile 2017 la Commissione ha svolto l'audizione di Marco Benadusi, autore del volume Terrorismo rosso.
L'audito ha esordito affermando che, a suo parere, dalla ricerca da lui compiuta è emersa la necessità di «trovare una via di mezzo [...] tra gli approcci più dietrologici e gli approcci che, all'opposto, potremmo dire negazionisti». Ha espresso l'opinione che non sia del tutto chiaro cosa accadde quando, a metà degli anni '70, si verificò il passaggio dal brigatismo non omicida al terrorismo - non solo brigatista - che pratica l'omicidio politico.
Su richiesta del Presidente, Benadusi si è soffermato anzitutto sulla pista Markevitch, osservando che il nome appare per la prima volta in un dossier presentato dal SISMI alla prima Commissione Moro; nel dossier si afferma che Markevitch era stato oggetto di attenzione perché si sospettava che fosse un importante elemento delle Brigate rosse, ma che non si erano trovati riscontri. L'audito ha ricordato che il nome di Markevitch riapparve nel 1999, dopo l'omicidio D'Antona, in una notizia dell'agenzia ANSA; emerse, poi, che Massimo Giraudo, un ufficiale dei Carabinieri che stava svolgendo indagini sulla strage di Brescia aveva indagato anche su Markevitch, in quanto il figlio di Markevitch aveva sposato la figlia di un agente dei servizi segreti bulgari coinvolto nelle indagini bresciane. Benadusi ha illustrato il contenuto di due appunti del dicembre 1978 del colonnello Cogliandro (del SISMI) e ha espresso l'opinione che Cogliandro stesse
seguendo una pista investigativa sulla quale aveva man mano compilato un dossier (inserendovi anche, per renderlo più solido, elementi provenienti dalle indagini relative alle dichiarazioni di Elfino Mortati), e che in quei mesi (novembre e dicembre 1978) alcune notizie fuoriuscirono e vennero pubblicate su «Il Tempo» (articolo di Longo), su «Panorama» (articolo di Sabelli Fioretti) e su «Penthouse» (testo di Di Donato). L'audito ha sostenuto che poté trattarsi di uno scoop predisposto per mettere in secondo piano le vicende relative alla scoperta del covo brigatista di via Monte Nevoso, a Milano, avvenuta il 1° ottobre 1978. Ha altresì ricordato che il 2 ottobre 1978 era stato rapito dalla 'ndrangheta Augusto Rancilio, fratello di Cesare Rancilio, socio di Corrado Simioni in una società costituita in Francia. Benadusi ha proseguito affermando che il nome di Markevitch riemerse nel 1998, quando una fonte
segnalò a Giraudo i sospetti che il SISMI aveva avuto nel 1978, e ha aggiunto che il giornalista Paolo Cucchiarelli ha detto di essere stato lui a segnalare - dopo un colloquio con Cossiga - quel collegamento con le indagini del SISMI del 1978. Benadusi ha riferito che, secondo quanto Sergio Flamigni disse a Giraudo, attraverso quelle notizie nel 1998 in realtà si voleva fare uno scoop per creare difficoltà al Governo Prodi, che poi cadde per altri motivi. Benadusi ha rilevato che nel 1998 la notizia non uscì, ma emerse il 29-30 maggio 1999, pochi giorni dopo l'elezione di Ciampi alla Presidenza della Repubblica e l'assassinio di Sergio D'Antona.
L'audito ha poi riferito che il 5 ottobre 1978 il Partito operaio europeo (POE), in una conferenza stampa, diffuse un corposo dossier sulla morte di Moro, nel quale veniva menzionato il principe Johannes Schwarzenberg (morto poche settimane prima), che abitava a Palazzo Caetani, e che il dossier del POE venne richiamato nel citato articolo di Sabelli Fioretti su «Panorama».
Rispondendo a una domanda del Presidente, l'audito ha richiamato le testimonianze relative al 9 maggio 1978, osservando che nelle varie ricostruzioni spesso si prende in considerazione una testimonianza e se ne esclude un'altra. In particolare, ha detto che Graziana Ciccotti, l'inquilina di via Montalcini, non indicò in quale giorno vide nel garage la macchia rossa; e che mentre Carla Antonini dichiarò di aver visto una macchina rossa (senza saperne precisare il modello) il 9 maggio alle 8.15 a via Caetani, altri testimoni affermarono di averla vista molto più tardi. Il senatore Corsini, a questo punto, è intervenuto per far presente che Graziana Ciccotti ha chiaramente affermato, almeno in sede extragiudiziaria, di aver incontrato Anna Laura Braghetti proprio il 9 maggio. Il senatore Gotor ha precisato che la signora Ciccotti però che nelle prime dichiarazioni all'autorità giudiziaria disse di aver visto l'auto
rossa non il 9 maggio, bensì qualche giorno prima.
Benadusi ha quindi risposto a una domanda sulle dichiarazioni di Elfino Mortati e ha ricordato che Mortati fece scoprire un covo in via dei Bresciani, mentre non si riuscì a individuare quali fossero i due covi nel Ghetto nei quali Mortati aveva affermato di aver visto Enrico Triaca e Valerio Morucci.
Benadusi, rispondendo al Presidente, ha poi detto che esistevano due anime ben distinte della lotta armata di sinistra: quella brigatista e quella non brigatista, che in gran parte si richiamava all'Autonomia, e che le due anime erano «inevitabilmente contigue, in relazione dialettica». A suo avviso, durante il sequestro Moro quella relazione dialettica si inasprì perché una parte delle BR (quella che faceva capo a Morucci) proveniva dalla lotta armata non brigatista, mentre la parte "ortodossa" facente capo a Moretti sospettava che Morucci fosse «manovrato dai suoi vecchi referenti che stavano fuori dalla Brigate rosse».
La Commissione ha svolto il 20 aprile 2017 l'audizione di Enzo Mosino, entrato nel 1958 nell'amministrazione del Ministero dell'interno e successivamente divenuto, dal 1985 al 1992, consigliere per gli affari interni del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Mosino ha ricordato che durante il sequestro Moro era direttore della divisione relazioni pubbliche, documentali e statistica della Direzione generale della pubblica sicurezza e che svolgeva le funzioni di addetto stampa del capo della Polizia. Ha affermato di non aver avuto, in quel periodo, né una diretta dipendenza dal Ministro Cossiga, né rapporti con gli organismi che hanno diretto le operazioni di ricerca dell'onorevole Moro. Perciò il prefetto Mosino ha riferito di non avere informazioni sulle strategie e sulle decisioni allora adottate.
Ha affermato che il Ministro Cossiga aveva rivoluzionato l'organizzazione dei servizi d'informazione, istituendo l'UCIGOS - che ereditava l'attività del Servizio di sicurezza di Emilio Santillo, e dell'Ufficio affari riservati di Federico Umberto D'Amato - i NOCS della Polizia e il GIS dei Carabinieri; aveva inoltre avviato la sindacalizzazione delle forze dell'ordine.
Il prefetto Mosino ha dichiarato che Cossiga «era molto presente, chiedeva continuamente notizie, informazioni» e ha ricordato di essere stato spesso inviato dal capo della Polizia a riferire direttamente al Ministro; iniziò così la sua conoscenza con Cossiga.
Riguardo ai rapporti con i giornalisti, l'audito ha affermato che aveva con loro contatti su incarico dell'ufficio stampa del Ministro. Circa i rapporti tra Cossiga e Fabio Isman, ha dichiarato di non sapere quante volte lo ricevesse, non essendo in servizio presso il gabinetto o la segreteria del Ministro, e ha spiegato: «Quando veniva mandato da me e chiedeva le notizie, gli davo le notizie che davo a tutti gli altri giornalisti». Ha anche aggiunto: «So che era molto vicino, questo sì [...] anche successivamente».
Mosino ha asserito di non aver mai saputo se Nemer Hammad avesse avuto contatti con il Ministro dell'interno o con i suoi collaborator e anche di non aver mai saputo, allora, di incontri tra Cossiga e l'onorevole Signorile.
Il Presidente ha ricordato che monsignor Mennini, recatosi da Cossiga insieme al professor Tritto, ne riportò l'impressione di un clima di grande confusione. L'audito ha replicato affermando che c'erano frenetica attività e intensa mobilitazione, non di agitazione e confusione; ha però precisato di non sapere cosa succedesse nell'ufficio del Ministro.
Sul "memoriale Morucci" - trasmesso da suor Teresilla Barillà al Presidente della Repubblica Cossiga il 13 marzo 1990 e poi dalla Presidenza della Repubblica, tramite il prefetto Mosino, al Ministro dell'interno il 26 aprile 1990, come ha ricordato il Presidente della Commissione - il prefetto Mosino ha asserito di avere ricordi vaghi ma di rammentare che oltre al Ministero dell'interno fu interessata anche l'autorità giudiziaria. Dei colloqui di Cossiga con Morucci e Faranda ha detto di non sapere nulla e di non avervi mai assistito, perché erano incontri che Cossiga faceva personalmente.
L'audito ha dichiarato di non aver mai commentato col Presidente Cossiga il caso Moro, né il ritrovamento delle carte di Moro in via Monte Nevoso nel 1990, perché Cossiga non ne parlava mai con lui né con altri collaboratori.
Il 26 giugno 2017 la Commissione ha svolto - con l'ausilio di interpreti - l'audizione di Bassam Abu Sharif, già autorevole membro del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), poi avvicinatosi a Fatah e divenuto consigliere di Yasser Arafat.
Abu Sharif ha esordito esprimendo ammirazione per Aldo Moro e per la sua «visione strategica riguardo all'Italia, all'Europa e al mondo». Secondo Abu Sharif, chi uccise Moro volle uccidere la sua visione, che «minacciava l'interesse di chi voleva egemonizzare l'Europa e l'Itlia fino al giorno d'oggi».
Secondo l'audito, dopo l'arresto dei capi delle Brigate rosse, la maggior parte delle BR erano infiltrate da «agenti americani o Gladio della NATO». A suo avviso, Moro non fu rapito dalle BR, anche perché il suo rapimento venne eseguito con elevatissimo livello professionale e con un addestramento molto raffinato. E in un successivo momento dell'audizione ha parlato di «professionisti di altissimo livello: o CIA o Gladio o uomini dell'intelligence o un team di forze speciali».
Abu Sharif, dopo aver affermato che gli Stati Uniti erano fortemente contrari all'accordo tra le forze politiche italiane promosso da Moro, che l'Unione sovieteca era contraria alla posizione del PCI, ha espresso la convinzione che gli Stati Uniti abbiano pianificato di rapire e uccidere Moro, se non avesse cambiato la sua posizione. Ha ricordato, quindi, l'invio in Italia da parte dell'Amministrazione americana, durante il periodo del sequestro, Steve Pieczenik, che non operò in favore della liberazione di Moro.
Secondo l'audito, una parte dei rapitori non erano veri appartenenti alle BR, bensì «professionisti e spie che lavoravano per Gladio o per gli Stati Uniti d'America, oltre ad alcune figure che erano vicine alle Brigate rosse».
A più riprese, nel corso dell'audizione, Abu Sharif ha espresso considerazioni - sempre fortemente negative - sul ruolo internazionale svolto dagli Stati Uniti d'America sia in passato sia oggi, in particolare con riferimento al Medio Oriente.
Riguardo ai rapporti tra l'Italia e i movimenti palestinesi, Bassam Abu Sharif ha dichiarato: «Tanti Paesi europei hanno il chiesto il nostro aiuto per risolvere alcuni problemi, attraverso informazioni e collaborazioni. Ad esempio, nell'ambito di tale collaborazione con un numero di Paesi europei, tra cui l'Italia, i Servizi erano riusciti congiuntamente a ottenere un messaggio firmato dal dottor George Habash, in cui si impegnava a non mettere a rischio la sicurezza dell'Italia, considerata dai palestinesi un Paese amico, né a partecipare a qualsiasi azione sul territorio italiano. Questo era già in atto dal 1974, se ricordo bene». Ha poi aggiunto che «il Fronte popolare per la liberazione della Palestina aveva rapporti molto particolari con l'Italia, politicamente e sul piano della sicurezza, sin dal 1972» e ha affermato che, attraverso il FPLP, l'Italia inviava aiuti (come ambulanze, medicinali e medici volontari
che rimanevano per sei mesi) ai campi profughi palestinesi, specificando che tali «attività congiunte si svolgevano sotto la guida di un ammiraglio italiano». In seguito, ha proseguito Abu Sharif, i rapporti si consolidarono anche con i partiti politici italiani e con i loro capi. Ha aggiunto: «Non è mio diritto rivelare segreti, ma abbiamo offerto aiuti enormi all'Italia».
L'audito ha ricordato di aver ricevuto a Beirut, nel periodo del sequestro Moro, due telefonate da un interlocutore a lui ignoto che gli disse: «Vogliamo liberare Aldo Moro, ma gli americani rifiutano. Ci puoi aiutare?»- Abu Sharif allora contattò Wadie Haddad, comandante delle operazioni speciali del Fronte popolare, che era in fin di vita (avvelenato dagli israeliani, secondo l'audito) e gli disse: «Non mi fido più delle BR, perché quelli veri ormai sono in galera e fra quelli che stanno fuori ci sono degli infiltrati; non tutti, ma una parte della loro leadership lavorava con gli americani».
In risposta a una domanda del Presidente sugli accertati trasferimenti di armi e sui rapporti intercorsi tra BR e le formazioni palestinesi, Abu Sharif ha detto che il Fronte popolare per la liberazione della Palestina - ha affermato - non ha sostenuto alcuna operazione realizzata in Europa dalle BR o da altre fazioni con cui aveva legami, «se non quelle operazioni che erano al servizio della lotta palestinese, cioè contro chi occupava la terra palestinese». Ha aggiunto che il FPLP accoglieva i combattenti che aderivano come volontari e che «migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze italiani sono venuti nei campi per contribuire alla lotta del popolo palestinese lavorando nelle unità sanitarie o negli ospedali oppure combattendo», e ha precisato che combattevano esclusivamente contro Israele. L'audito ha riconosciuto che il FPLP aveva rapporti con la RAF tedesca, l'Armata rossa giapponese e con le BR, ma solo per
sostenere la lotta in Palestina: «Nacque così un'alleanza internazionale il cui obiettivo era aiutare il popolo palestinese a combattere contro l'occupante israeliano».
Bassam Abu Sharif ha ricordato di aver incontrato e parlato più di una volta, a Beirut e a Roma, con il capo centro del SISMI in Libano, colonnello Stefano Giovannone - per il quale ha espresso grande rispetto -, assicurandogli l'impegno del FPLP di mettere l'Italia al sicuro da ogni azione. Ha precisato che a tali incontri erano presenti anche altre persone e che «alcuni giornalisti italiani progressisti hanno avuto un ruolo per "ammorbidire" questo processo di collaborazione tra l'Italia e le fazioni palestinesi, in particolare il FPLP. Ha aggiunto che Giovannone incontrò Habash una sola volta, a Beirut.
In merito alle notizie riferite nel messaggio inviato da Giovannone al SISMI il 17 febbraio 1978 riguardante un'operazione di terroristi europei che avrebbe potuto coinvolgere l'Italia, Abu Sharif ha affermato che l'interlocutore abituale di Giovannone era Taysir Qubaa. Ha proseguito ribadendo che Giovannone aveva ricevuto il messaggio firmato da Habash contenente l'impegno del FPLP di escludere l'Italia delle sue azioni (documento già menzionato nella parte iniziale dell'audizione) ha dichiarato che Habash circa un anno prima del rapimento di Moro aveva spiegato a Giovannone che il FPLP non aveva più rapporti con le BR e lo aveva avvisato - sebbene senza indicare nomi - che la "seconda generazione" dei capi delle BR era infiltrata da parte degli Stati Uniti.
Riguardo a Carlos, ha asserito che questi, una volta espulso dal FPLP, aveva cercato - senza riuscirvi - di fondare una sua organizzazione rivolgendosi a tedeschi, italiani e francesi che erano usciti dalle organizzazioni e «fazioni rivoluzionarie in Europa».
Il Presidente ha poi posto domande relative alle dichiarazioni rilasciate da Abu Anzeh Saleh a un giornale nel 2009, secondo cui nel periodo del sequestro Moro il colonnello Giovannone lo aveva voluto incontrare con urgenza a Roma per chiedergli di contattare i responsabili del FPLP al fine di sapere se avessero qualche notizia utile sul rapimento. L'audito ha anzitutto asserito che l'arresto di Saleh a Ortona nel 1979 poiché in possesso di due missili era stato un equivoco, poiché in quell'occasione non vi era stata violazione dell'accordo firmato da Habash, in quanto le armi che Saleh portava non erano destinate ad essere usate in Italia, ma erano solo in transito. Circa l'incontro tra Giovannone e Saleh, l'audito ha asserito che Giovannone doveva sicuramente aver informato precedentemente il FPLP di tale incontro; ha aggiunto che il numero telefonico di Saleh fu dato a Giovannone dal già citato Taysir Qubaa.
Riguardo all'appello per la liberazione di Moro lanciato il 4 maggio 1978 da Arafat, l'audito ha detto che fu un appello pubblico, politico, dietro il quale non c'era alcun altro tentativo, perché non c'erano rapporti con i rapitori di Moro. Ha aggiunto: «Se noi avessimo avuto la possibilità, se ci fosse stato chiesto di contribuire alla liberazione di Aldo Moro, non avremmo fatto nessun passo indietro, non avremmo esitato nemmeno per un minuto».
Il Presidente ha ricordato una dichiarazione del colonnello Giovannone al giudice Carlo Mastelloni secondo cui Arafat aveva riferito al generale Santovito che, in vista della liberazione di Aldo Moro, un contatto c'era stato ma le BR avevano chiesto all'OLP contropartite impossibili e poi avevano rotto il dialogo; inoltre ha richiamato un'intervista di Abu Sharif del 2008, nella quale l'audito aveva affermato che avrebbe potuto salvare Moro, e che aveva chiamato un numero e lasciato messaggi senza però ricevere risposta..
Abu Sharif ha risposto: «Il problema era che le utenze telefoniche che ci venivano date erano provvisorie, cioè si usavano una volta, due volte, o tre volte e poi non rispondevano più. Non ho ricevuto nessuna risposta. Io non sapevo chi ci fosse dall'altra parte del telefono. Era un numero telefonico usato in precedenza. Ho ricevuto [...] questa utenza da chi era responsabile di Saleh in Italia»..
Il Presidente ha posto una domanda in merito a un messaggio del 21 giugno 1978 da Beirut in cui Giovannone riferiva che le Brigate rosse avrebbero fatto pervenire a George Habash, come gesto distensivo per riannodare le fila di un rapporto interrotto, copia delle dichiarazioni rese da Moro durante la sua prigionia relative ad azioni del servizio segreto israeliano in Italia e all'assassinio di Wael Zwaiter. Bassam Abu Sharif ha dichiarato di non avere informazioni al riguardo e di pensare che non fosse vero, ribadendo che i rapporto con le BR erano stati interrotti prima del sequestro Moro ed erano rimasti interrotti.
Sollecitato ad esprimersi sulla notizia (contenuta in una nota del SISDE dell'agosto 1978) di una collaborazione tra BR e "Giugno nero" di Abu Nidal e su un campo di addestramento iracheno in cui erano presenti due italiani, Abu Sharif di non credere che tali informazioni fossero corrette, asserendo inoltre di non aver mai sentito parlare di "Giugno nero". Quanto ad Abu Nidal, l'audito ha detto che Abu Nidal, dopo aver fatto parte del Consiglio rivoluzionario di Fatah, era diventato estraneo alla «rivoluzione palestinese» e che «chiunque collaborasse con lui non aveva alcun legame con noi».
Il Presidente ha poi posto domande sul perché, visto che i rapporti con le BR erano ormai cessati da anni, si fosse deciso da parte palestinese di dare armi nel 1978 a esponenti dell'eversione di sinistra italiana e nel 1979 direttamente alle BR, come è stato accertato. Abu Sharif ha l'audito ha ribadito che i rapporti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina con le BR si interruppero nel 1976 e ha detto che "palestinesi" o "movimento palestinese" sono espressioni generiche: «C'è il palestinese spia, c'è il palestinese normale e c'è il palestinese ufficiale, che è l'OLP o quelle fazioni che hanno rapporti con l'Italia».
Dopo una parte segreta, l'audizione è proseguita in forma pubblica, con domande poste da alcuni componenti della Commissione.
Rispondendo al senatore Cervellini, l'audito ha dichiarato che anche dopo il 1976 c'erano volontari italiani che, per motivi umanitari, andavano nei campi palestinesi in Libano, in Giordania e in Siria, ma non appartenevano alle BR; ha ribadito che la fase della collaborazione operativa era finita.
Riguardo a contatti di Giovannone, tramite alcuni palestinesi, durante il sequestro Moro, ai fini di una possibile trattativa, Abu Sharif ha detto di non esserne al corrente, aggiungendo: «Se fosse stato chiesto a noi di partecipare alla liberazione di Aldo Moro, l'avremmo fatto sicuramente. Questo non voleva dire contattare le Brigate rosse, assolutamente no. [...] Noi avevamo modo di fare pressioni su quelli che avevano preso la decisione di liberarsi di Aldo Moro. Chi erano? Erano gli americani».
L'onorevole Carra ha chiesto all'audito se sapesse chi erano le persone infiltrate dagli americani nelle BR. Abu Sharif ha risposto di essere un politico e un «leader della rivoluzione palestinese», ma di non appartenere all'intelligence; tuttavia, si è detto sicuro delle proprie affermazioni.
Bassam Abu Sharif ha quindi ribadito che non ci fu una richiesta dall'Italia di un intervento per liberare Moro; e che, in caso di conoscenza di attività terroristiche contro l'Italia o di notizie utili alla liberazione di Aldo Moro, avrebbero avvertito i Servizi italiani.
L'onorevole Grassi ha chiesto all'audito cosa sapesse del cosiddetto "lodo Moro" e la seduta è proseguita in forma segreta.
L'audizione è ripresa, quindi, in forma pubblica e l'onorevole Grassi ha posto una domanda sulla scomparsa, avvenuta a Beirut nel 1980, dei due giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, i quali, secondo un'ipotesi, sarebbero stati uccisi poiché avevano scoperto un sito di addestramento delle BR con i palestinesi, in cui gli addestratori erano italiani.
Bassam Abu Sharif ha escludendo che ci fosse un campo di addestramento in cui si addestravano le BR. Ha quindi ribadito di non essere in possesso di nomi certi di infiltrati nelle BR ma di essere certo che era avvenuta un'infiltrazione. Ad una domanda su Mario Moretti ha risposto di sapere chi è e quali voci esistevano su di lui, per aver letto molte pagine sul tema.
Rispondendo all'onorevole Cominardi, l'audito ha detto di non aver mai conosciuto personalmente Aldo Moro. A una domanda del senatore Lucidi, Abu Sharif ha risposto ripetendo che, a suo avviso, coloro che uccisero gli uomini della scorta di Moro non erano brigatisti ma «professionisti», ed erano persone diverse da coloro - «brigatisti, ma anche infiltrati» - che poi tennero in prigionia Moro e lo uccisero.
Il 4 ottobre 2017 si è svolta l'audizione di Gianni Gennari, che all'epoca dei fatti era sacerdote e assistente spirituale del segretario della DC Benigno Zaccagnini, ma era anche in contatto con esponenti del PCI come Antonio Tatò, nonché amico di monsignor Cesare Curioni, ispettore generale dei cappellani carcerari.
Gennari ha ricordato di aver conosciuto Curioni - «uomo di poche parole, però di molti fatti» - verso la metà degli anni '70. Sul tentativo di trattativa di cui fu protagonista Curioni, ha riferito che era stato avviato attraverso qualcuno - la cui identità Curioni non gli rivelò mai - «una specie di patto preventivo» per la liberazione di Moro, con la raccolta di alcuni miliardi di lire e la liberazione di Paola Besuschio. Ha anche detto di aver saputo da padre Carlo Cremona che si attendeva l'annuncio della liberazione proprio nel giorno in cui invece giunse l'annuncio dell'assassinio di Moro.
Gennari ha poi voluto riferire che alcuni suoi amici vollero cercare la presenza di eventuali anagrammi in alcuni passaggi delle lettere di Moro dalla prigionia e individuarono in particolare due frasi. L'audito sottopose le due frasi a un enigmista, Ennio Peres, che, dopo un iniziale scetticismo, trovò che le lettere dagli anagrammi delle due frasi risultava la menzione di una casa tra la via Cassia e la via Flaminia, una specie di sotterraneo dalle cui finestre si vedevano pini e bimbi. Gennari ha proseguito raccontando che nel 1986 un giornalista di «Paese Sera», Enrico Fontana, incaricato di andare a vedere in quella zona, individuò un particolare edificio con un sotterraneo e scrisse un articolo al riguardo; l'articolo passò inosservato, ma pochi giorni dopo un uomo anziano, Viktor Aurel Spachtholz, si presentò alla sede del quotidiano affermando di sapere quale poteva essere la casa e raccontando di esservisi
recato per dare lezioni di pittura a Carmelo Spagnuolo, che era stato radiato dalla magistratura. In particolare, secondo Gennari, Spachtholz - che fu trovato morto pochi giorni più tardi - ricordò che una volta (alcuni anni prima del rapimento di Moro), scendendo nella cantina di quella casa, aveva osservato che sembrava una prigione, e Spagnuolo gli aveva risposto: «Da questa prigione cambieremo la vita dell'Italia».
Gennari ha anche raccontato che nel 1988, in occasione dell'uscita di una nuova rivista di enigmistica, «Giochi Magazine», Ennio Peres gli propose di tornare sulla vicenda degli anagrammi. L'audito scrisse, quindi, usando uno pseudonimo, un articolo sull'argomento, che venne pubblicato nel primo numero del nuovo periodico, che rimase tuttavia l'unico perché subito dopo la rivista cessò le pubblicazioni.
don Curioni era certo che «un vero e proprio canale con le BR attive non ci fu mai», Gennari ha dichiarato che ciò gli era stato detto direttamente dallo stesso Curioni, che aveva parlato in carcere anche con Renato Curcio e Alberto Franceschini, che però si dissero estranei alla vicenda. Il Presidente ha osservato che invece monsignor Fabio Fabbri, audito dalla Commissione, aveva valorizzato la serietà del canale della trattativa. L'audito ha detto di ritenere che monsignor Fabbri potesse aver semplicemente pensato che don Cesare aveva trovato qualche intermediario. Il Presidente ha ricordato che in diversi articoli si afferma che Curioni era con Paolo VI e con monsignor Pasquale Macchi nell'appartamento papale la sera del 21 aprile, partecipando materialmente alla stesura della lettera del Papa «agli uomini delle Brigate rosse», mentre secondo monsignor Fabbri quel giorno Curioni, trovandosi in Lombardia,
parlò solo per telefono con Paolo VI. Gennari ha risposto che Curioni gli disse che era stato presente e aveva scritto la brutta copia, poi ricopiata da Paolo VI, e che l'espressione «senza condizioni» era presente fin dalla prima dettatura. Successivamente all'audizione, l'11 ottobre, Gennari ha inviato una precisazione: «Don Cesare mi ha detto di sicuro che ha partecipato di persona alla stesura del messaggio di Paolo VI alle BR, ma non mi disse se lo aveva fatto via telefono o in presenza fisica in Vaticano. [...] Quello che mi risulta, e che ribadisco, è che le parole "senza condizioni" erano nel testo fin dalla prima stesura».
Riguardo alla convinzione di monsignor Curioni che sul cadavere di Moro ci fosse un solo colpo sparato a bruciapelo che aveva lasciato l'alone caratteristico di bruciatura, mentre tutti gli altri colpi fossero stati sparati a distanza maggiore e dopo parecchio tempo, forse più di un'ora, il presidente ha chiesto a Gennari se quella di Curioni era una convinzione soggettiva oppure si fondava su qualche confidenza relativa ai reperti autoptici. Gianni Gennari ha osservato che gli era difficile rispondere, ma che don Cesare non gli aveva detto mai «qualcosa che non corrispondesse a quello che aveva visto».
L'audito ha dichiarato di aver portato personalmente a Berlinguer, durante il sequestro Moro, un messaggio scritto di Zaccagnini e di aver poi portato allo stesso Zaccagnini la risposta, precisando di non aver letto i contenuti dei messaggi. Ha affermato di aver visto spesso, in quei giorni, sia Zaccagnini sia Tatò e di aver riferito oralmente a Berlinguer messaggi di Zaccagnini e viceversa. Ha precisato, inoltre, che Zaccagnini era al corrente dei tentativi di trattativa di monsignor Curioni.
Rispondendo a ulteriori domande, Gennari ha dichiarato che Zaccagnini non gli disse mai di una visita dell'abbé Pierre alla sede della DC in Piazza del Gesù, e ha detto che si sapeva dal giorno precedente che Amintore Fanfani avrebbe fatto dichiarazioni importanti nel corso della riunione della direzione della DC svoltasi la mattina del 9 maggio.
Il 18 ottobre 2017 si è svolta l'audizione di Aldo Bonomi, deliberata per approfondire la vicenda dei contatti con brigatisti in carcere che furono tentati da esponenti socialisti e sulla circolazione di lettere e scritti di Moro o di brigatisti nel corso del sequestro.
Bonomi ha ricordato la sua militanza in Lotta continua, a Trento, e ha precisato, in riferimento alla sua condanna a sei mesi di reclusione, che si era trattato di una reazione di massa davanti a una fabbrica dove alcuni operai erano stati feriti: «Accompagnammo gli accoltellatori a Trento e li consegnammo alle autorità». Riguardo all'aiuto fornito nel 1970 per l'espatrio dell'anarchico Gianfranco Bertoli (già informatore del servizio segreto militare e, nel 1973, autore dell'attentato alla Questura di Milano), ha affermato che «chiunque con le mie idee [...] avrebbe aiutato a sfuggire [...] il "clima di repressione" e di problematiche di quegli anni», precisando che non sapeva che Bertoli era stato informatore del SID. Ha ricordato di essersi avvicinato poi, a Milano, alla rivista «Controinformazione» - che era, secondo le sue parole «frutto di due componenti, una più vicina alle Brigate rosse
e una più vicina alla nebulosa Potere operaio» - e di essere stato condannato a due anni per partecipazione a banda armata.
Rispondendo a domande del Presidente, ha dichiarato di non aver mai conosciuto Corrado Simioni, Franco Troiano e Innocente Salvoni e ha escluso di aver mai avuto un ruolo nel tentativo di contatto con le BR effettuato dai servizi segreti israeliani. In riferimento a dichiarazioni su di lui del 1992 di Rolando Bevilacqua, secondo cui egli avrebbe frequentato contemporaneamente ambienti della sinistra extraparlamentare e forze dell'ordine, ha smentito categoricamente di aver avuto frequentazione con appartenenti a forze di polizia.
Bonomi ha detto di essere stato arrestato, insieme ad altri, perché l'archivio di «Controinformazione», che era gestito da Antonio Bellavita, fu trovato nel covo brigatista di Robbiano di Mediglia. Ha dichiarato di aver incontrato Alberto Franceschini una sola volta (prima che le BR iniziassero a uccidere), in casa di Luigi Bellavita, fratello di Antonio, che era anch'egli presente all'incontro, e ha smentito di essersi presentato a Umberto Giovine come l'autore del libro La strage di Stato, affermando che l'autore era invece Marco Ligini, del tutto estraneo al gruppo di «Controinformazione».
L'audito ha negato di aver avuto «rapporto di militanza» con le Brigate rosse, anche perché non ne condivideva la linea politica, e ha affermato di essersi invece avvicinato all'Autonomia operaia e a Primo Moroni, della libreria Calusca.
Circa i suoi rapporti con Umberto Giovine, Bonomi ha dichiarato che iniziarono quando sua moglie Bruna Pedrazzoli iniziò a collaborare a «Critica Sociale» con Giovine.
Il Presidente ha ricordato che a Bonomi, durante la sua detenzione, fu sequestrata una lettera scritta dal brigatista Valerio De Ponti (suo compagno di cella per alcuni giorni nel carcere di Torino), che era indirizzata ai figli di Francesco Marra. L'audito ha dichiarato di non ricordare De Ponti e di non sapere chi fosse Marra.
In merito ai tentativi di trattativa, Bonomi ha ricordato di aver portato l'avvocato Giannino Guiso da padre Camillo De Piaz.
Riguardo alle affermazioni di Umberto Giovine secondo cui Bonomi, durante il sequestro Moro, avrebbe segnalato l'arrivo presso la libreria Calusca di comunicati delle BR o di lettere di Moro, l'audito ha detto: «I testi, ovviamente non originali, giravano e si trovavano anche alla libreria Calusca; non originali», chiarendo che con le parole «non originali» intendeva «fotocopie» e che si riferiva al periodo in cui era in corso il sequestro Moro. Alla richiesta del senatore Gotor di precisare se si trattava di fotocopie di manoscritti o di dattiloscritti, ha detto di non avere un ricordo vago e non preciso e ha aggiunto di aver visto fotocopie delle lettere di Moro da Guiso, non alla Calusca.
Il Presidente ha quindi richiamato la vicenda di Volker Weingraber, agente tedesco occidentale che nel 1978 fu infiltrato in ambienti vicini alle Brigate rosse, ricordando che Bonomi contribuì a trovare un alloggio a Weingraber e che, in dichiarazioni rese a un collaboratore della Commissione, Bonomi stesso ha dichiarato, su Weingraber: «Con molta enfasi mi chiese se potevo aiutarlo a instaurare rapporti con le BR e io gli dissi che non ero la persona giusta. Non lo vidi più da allora». Il Presidente ha anche citato un'informativa del 6 novembre 1978, secondo cui Weingraber aveva avuto contatti «con Aldo Bonomi, il quale gli avrebbe confermato di essere in grado di procurare armi e documenti falsi per sviluppare attività eversive» e Bonomi sarebbe stato «un provocatore e un confidente della polizia». Bonomi ha dichiarato di essere sempre stato «sul margine» e di non aver mai condiviso
«il meccanismo di individuare i simboli, colpirli e ucciderli».
Nella seduta del 16 novembre 2017 si è svolta l'audizione di Antonio Ianni, che nel 1978 era fotoreporter dell'agenzia ANSA e si recò in via Fani appena apprese - tramite un apparecchio ricetrasmittente sintonizzato sulle frequenze delle forze di polizia - dell'attentato.
Le prime domande del Presidente hanno riguardato l'orario in cui l'audito giunse sul luogo dell'agguato. Ianni ha confermato le dichiarazioni rese a collaboratori della Commissione, affermando di aver impiegato al massimo un quarto d'ora per compiere il tragitto dal quartiere Talenti, dove abitava, e di aver visto partire da via Fani l'ambulanza che portava in ospedale l'agente ferito (Zizzi). Ha sostenuto che in via Fani, con sua sorpresa, c'erano pochissime persone (nessuna delle quali in divisa) e che la Polizia arrivò solo qualche minuto dopo di lui; ha aggiunto che, se fossero stati presenti degli agenti, gli sarebbe stato impossibile effettuare fotografie così da vicino come invece poté fare («Ho fotografato dentro la macchina, ho fotografato i cadaveri scoperti»). L'onorevole Lavagno ha osservato che in un libro (Castronuovo, Vuoto a perdere) è riportata una dichiarazione dell'audito, da cui invece
risulta che, al suo arrivo, notò che c'era qualche agente della Polizia; Ianni ha però smentito di aver mai fatto una tale affermazione. Non ha comunque escluso completamente la possibilità che qualche agente fosse già presente, ma lui non lo abbia visto. L'onorevole Lavagno ha poi rilevato che in alcune fotografie scattate da Ianni in via Fani si notano chiaramente un'auto della Polizia e un agente in divisa. Ianni ha sostenuto che, siccome il 16 marzo egli tornò in via Fani anche una seconda volta, quella foto doveva essere stata da lui fatta in tale seconda occasione, quando ormai era trascorso un certo tempo.
L'audito ha poi ricordato che dopo alcuni minuti dal suo arrivo in via Fani vide passare, senza però fotografarlo, un elicottero di dimensioni ridotte e di colore bianco, privo di insegne, che volava a circa 200 metri di quota.
Ianni ha anche fatto riferimento alla circostanza - richiamata dal Presidente all'inizio dell'audizione - che un ufficiale in servizio all'aeroporto militare di Pratica di Mare al quale egli il 16 marzo chiese notizie sull'elicottero da lui visto sorvolare via Fani, gli rispose che non risultava la presenza in volo su Roma di un simile elicottero, quella mattina.
Riguardo a un altro episodio da lui riferito ai collaboratori della Commissione nel corso della sua escussione, Ianni ha confermato le sue dichiarazioni, secondo cui circa un mese dopo il 16 marzo 1978 una sera trovò la sua abitazione completamente a soqquadro, anche se nulla era stato asportato (neanche la sua pistola con le munizioni); la serratura però appariva intatta, non forzata. Ha anche confermato di essersi recato l'indomani al Commissariato di Polizia di Monte Sacro per sporgere denuncia, ma di aver rinunciato a farla poiché un funzionario di Polizia da lui conosciuto, tale dottor Cauto, gli consigliò di lasciar perdere, dicendogli: «Può darsi che sia stato l'Ufficio politico». L'audito ha anche riferito che in un periodo successivo seppe che era stato commesso un furto presso l'archivio fotografico dell'ANSA.
Infine, è stato mostrato a Ianni un frammento del servizio giornalistico di Paolo Frajese, realizzato in via Fani alle 9.50 del 16 marzo 1978, nel quale si scorge un elicottero. L'audito ha dichiarato che le dimensioni di tale elicottero corrispondono a quello da lui visto, ma che il colore è diverso, in quanto appare scuro.
II. I principali filoni di indagine sviluppati e le risultanze
5. Premessa
Nelle pagine che seguono si dà succintamente conto dei principali filoni di inchiesta, approfonditi nel corso dell'ultimo anno.
Ragioni di sintesi e esigenze di riservatezza in relazione ad indagini i cui esiti sono stati trasmessi all'Autorità giudiziaria impediscono di dare conto puntualmente di tutti gli accertamenti condotti e dei relativi risultati; ci si soffermerà, pertanto, esclusivamente sulle questioni di maggior rilievo, nei limiti di ciò che, allo stato dell'inchiesta, può essere reso pubblico.
6. Il "memoriale Morucci"
Già nella precedente relazione si è dato conto di un complessivo riesame della vicenda di Valerio Morucci e Adriana Faranda che la Commissione ha compiuto, allo scopo di rivalutare nella sua interezza il profilo dei due brigatisti, che hanno svolto un ruolo importante sia nella vicenda del sequestro Moro sia nella costruzione dei giudicati penali sul caso Moro, attraverso un loro peculiare processo dissociativo.
In quella sede si erano in particolare riesaminate la vicenda della trattativa con esponenti socialisti che si svolse tramite Morucci e Faranda nel corso del sequestro Moro e la fuoriuscita dei due terroristi dalle Brigate rosse.
Si è poi ulteriormente approfondita la vicenda dell'arresto dei due brigatisti, il 29 maggio 1979, dopo una latitanza propiziata da Franco Piperno e Lanfranco Pace, in un appartamento di viale Giulio Cesare, di proprietà di Giuliana Conforto, il cui padre, Giorgio, era un agente dell'Unione sovietica, peraltro ben noto ai Servizi italiani. Ciò anche allo scopo di sottoporre a verifica la tesi, a suo tempo avallata da Francesco Cossiga e ripresa alla Commissione Mitrokhin, secondo cui l'arresto fu dovuto a Giorgio Conforto, e, più in generale, allo scopo di verificare se l'arresto fu in qualche modo "negoziato", anche con la partecipazione di soggetti terzi. Tale elemento non è infatti certo secondario ai fini di una ricostruzione della dimensione internazionale della vicenda Moro e dei caratteri del terrorismo brigatista in Italia.
Le indagini compiute, delle quali si è già dato conto, hanno consentito di accertare che l'individuazione della base fu resa possibile dalle confidenze rilasciate da uno dei soci gestori della concessionaria AutoCia srl a un sottufficiale della Squadra mobile di Polizia di Roma. Ciò tuttavia non esclude altre e diverse attivazioni, tanto più che rimangono elementi da accertare sui contatti mantenuti da Morucci e Faranda tra l'autunno del 1978 e il maggio del 1979 e sul ruolo di Giorgio Conforto.
In questa relazione si dà conto degli ulteriori approfondimenti compiuti dalla Commissione, che hanno avuto per oggetto due temi principali: gli aspetti ancora non chiariti dell'ultimo periodo di latitanza di Morucci e Faranda e dell'arresto dei due brigatisti; la costruzione del cosiddetto "memoriale Morucci" e la fondazione della ricostruzione della vicenda Moro accolta in sede processuale tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90.
Come si vedrà, dal complesso delle vicende emergono una serie di elementi che evidenziano tentativi di contatto con figure istituzionali e un particolare rapporto di Morucci con apparati dello Stato, con i quali si avviò nel corso degli anni '80 una forma di interlocuzione, in un sovrapporsi di piani tra la vicenda criminale e la vicenda politico-giudiziaria. Ciò favorì un processo di rielaborazione a posteriori della vicenda Moro che costituisce un grande problema politico-culturale aperto, perché per molti aspetti si tradusse in una sorta di negoziato di cui l'opinione pubblica fu tenuta sostanzialmente all'oscuro.
6.1. Ulteriori accertamenti sulla latitanza di Morucci e Faranda
La Commissione ha acquisito l'ingente documentazione processuale e di inchiesta relativa al rapporto tra Piperno e Pace da un lato e Morucci e Faranda dall'altro, nel periodo del progressivo sganciamento dei due brigatisti dalle Brigate rosse e della loro fuga. Di tale rapporto i brigatisti pentiti e gli interessati diedero varie spiegazioni, da quella che vedeva Morucci e Faranda come organici a Piperno e al progetto "Metropoli" a quella, che appare limitativa, che presentava il rapporto con Pace e Piperno nei termini di un supporto fornito a Morucci e Faranda per ragioni sostanzialmente personali.
La questione è stata riesaminata sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che Adriana Faranda e Valerio Morucci hanno reso nel corso delle loro audizioni presso la Commissione.
Si è in particolare rilevato che esiste una continuità non interrotta di rapporti tra Piperno e Pace, da un lato, e Morucci e Faranda, dall'altro, sin dal periodo della trattativa per salvare la vita di Moro. In tale rapporto Piperno e Pace costituiscono per i due brigatisti il tramite principale per interloquire con il mondo politico-istituzionale e con realtà partitiche anche extraparlamentari, ma comunque esterne all'ambito, strettamente inteso, della lotta armata.
Nel corso della seconda metà del '78, secondo plurime dichiarazioni di pentiti già valorizzate nei primi processi Moro, Morucci e Faranda si fanno portavoce all'interno delle BR delle posizioni del gruppo di "Metropoli", o quanto meno sono così percepiti dalla dirigenza delle Brigate rosse.
In questo quadro il supporto offerto, soprattutto da Pace, nei primi mesi del 1979, dopo l'abbandono delle Brigate rosse da parte di Morucci e Faranda, non appare un semplice supporto materiale ma può essere messo in relazione a una prospettiva di fuoriuscita di Morucci e Faranda dal brigatismo e al loro passaggio in una dimensione di estremismo, anche armato, ma non brigatista, o di espatrio.
Sulla base degli elementi già noti, la Commissione ha svolto diversi approfondimenti sul periodo in cui Morucci e Faranda furono ospitati in casa Conforto, sul ruolo di Giorgio Conforto, sulle modalità dell'arresto e su alcuni reperti ritrovati in viale Giulio Cesare.
Il rifugio dei due brigatisti in casa Conforto si prolungò, come già precedentemente accertato, per molte settimane, dal marzo al maggio 1979. In quel periodo Morucci e Faranda non rimasero semplicemente nascosti, ma ebbero una serie di incontri e contatti che non sono stati compiutamente ricostruiti in sede giudiziaria. Al di là infatti dei ben noti incontri con Lanfranco Pace, resta da chiarire, per questa fase, il rapporto con l'area di Metropoli di cui, nei mesi precedenti, Morucci e Faranda si erano fatti portavoce all'interno delle Brigate rosse, almeno prima che tale area fosse decapitata dagli arresti ordinati nell'ambito della inchiesta 7 aprile.
Relativamente a questo tema è stata acquisita la testimonianza di Alessandro Tessari, deputato che nel maggio 1979 passò dal gruppo parlamentare comunista a quello radicale. Nelle informazioni rese a collaboratori della Commissione, Tessari ha dichiarato che nel maggio 1979, due o tre giorni prima dell'arresto di Morucci e Faranda, un funzionario dell'Ufficio studi della Camera dei deputati gli segnalò la possibilità di affittare una stanza presso la sua conoscente Giuliana Conforto. Tessari ha dichiarato che visionò l'appartamento nella mattina del 29 maggio 1979. Sebbene invitato a prenderne possesso dalla sera stessa, non lo fece, per ragioni che non ricorda. Di qui la convinzione, espressa retrospettivamente da Tessari nel volume Raccontando Marco Pannella (Milano, 2012), che gli fosse stata tesa una sorta di trappola.
Le affermazioni di Tessari sono state riscontrate con l'escussione dell'ex funzionario della Camera chiamato in causa da Tessari e della di lui compagna dell'epoca. Il funzionario ha confermato l'episodio, attribuendolo all'amicizia tra sua moglie e Giuliana Conforto, ma ha escluso di essere mai stato nell'appartamento e di aver presenziato a incontri tra Tessari e la Conforto.
Nell'ambito di questo filone di indagine è stata escussa anche Giuliana Conforto che ha sostanzialmente ribadito quanto da lei dichiarato in passato, ovvero che la richiesta di ospitare Morucci e Faranda le venne da Piperno e che lei non conosceva l'identità dei due brigatisti. Ha inoltre dichiarato di non ricordare nei dettagli l'episodio narrato da Tessari, ma ha affermato di ricordare che le fu proposta una persona a cui affittare la stanza e ha confermato una buona conoscenza del funzionario e della sua compagna.
Allo stato non si può affermare che le considerazioni di Tessari siano prive di fondamento. Emerge in ogni caso che, nel periodo della loro latitanza a casa Conforto, Morucci e Faranda furono in varia maniera "incrociati" da diverse persone che poi non emersero nelle indagini. Alcune di esse, come lo stesso Tessari e il grafico Aurelio Candido, appartenevano all'area radicale. Escusso sul tema da collaboratori della Commissione, l'ex parlamentare radicale Gianfranco Spadaccia, che raccolse a suo tempo le confidenze di Aurelio Candido, ha sottolineato che Candido - come Tessari - poté entrare in contatto con Morucci e Faranda «perché richiestogli da ambienti diversi dal partito radicale», in ragione di altre loro appartenenze o relazioni. Ha inoltre dichiarato che la presenza dell'associazione anticlericale e massonica "Giordano Bruno" - di cui Giorgio Conforto fu membro attivo e poi Presidente - nella sede dei radicali
è una pura casualità oppure la conseguenza di «pregressi rapporti esistenti con la vecchia generazione del partito».
Il profilo ideologico della Conforto appare in effetti alquanto sfuggente e riconducibile a una generica area di sinistra extraparlamentare, caratterizzata da un ateismo militante - peraltro praticato anche dal padre - e vicina ai movimenti guerriglieri dell'America latina. Proprio questa attenzione all'America latina rende ragione del rapporto con il giornalista di "Repubblica" Saverio Tutino, già in rapporti con Giangiacomo Feltrinelli e attivo promotore in Italia della rivoluzione cubana e delle teorie rivoluzionarie dell'America del Sud. La presenza di Tutino in casa Conforto suscita ulteriori perplessità, che tuttavia non possono essere approfondite per via di escussione, essendo Tutino deceduto.
Nelle dichiarazioni a suo tempo rese il 30 maggio 1979 all'Autorità giudiziaria, alla quale si presentò spontaneamente, Tutino affermò di aver conosciuto Giuliana Conforto circa tre mesi prima dell'arresto, di esserne diventato amico e di aver incontrato un paio di sere Morucci e Faranda. In particolare, Tutino affermò che «i due espressero tendenze politiche anticomuniste e con una tendenza - limitata al problema del voto - per la linea radicale». Riascoltato il 23 giugno 1979, Tutino aggiunse di essere andato al cinema con Morucci e Faranda, insieme alla Conforto e a una delle figlie.
Questa versione "minimalista" appare poco credibile, alla luce della grande esperienza che Tutino aveva nel mondo dei movimenti extraparlamentari. La stessa Adriana Faranda, nell'audizione presso la Commissione dell'11 luglio 2017, ha affermato, a proposito di un possibile ruolo di Tutino nel suo arresto, che «avevo pensato che fosse stato lui che avesse a un certo punto riconosciuto o avuto qualche sospetto» e ha descritto come assai più frequenti le visite di Tutino, che veniva «abbastanza spesso» e «lo vedevamo due volte a settimana». Più rare sarebbero state le visite di Giorgio Conforto, che la Faranda ricorda di aver visto alcune volte.
Anche il giudice Priore, audito dalla Commissione Stragi il 10 novembre 1999, aveva affermato, a questo proposito: «Non vorrei qui richiamare - infatti non ha alcuna responsabilità penale - la persona che spesso frequentava la Conforto, una figura di alto livello del giornalismo italiano, Saverio Tutino, che conosceva a fondo i problemi del Sud America e che si recava spessissimo a Cuba. Questi, come la Conforto, ha sostenuto di non conoscere Morucci e Faranda, che vivono nel mondo dell'eversione dagli anni di Potere Operaio, sono conosciuti da tutti e sfuggivano soltanto a questi personaggi». Sospetti su Tutino furono, a suo tempo, avanzati anche da terroristi del "nucleo storico" in un documento del "Fronte delle carceri" di Palmi del dicembre 1982, diretto contro Alfredo Bonavita, che aveva fornito al primo processo Moro notizie sui contatti tra BR e agenti israeliani e sulla vicenda Pisetta. Nel documento si prendeva spunto dal fatto
che Tutino avrebbe propiziato un incontro tra la compagna di Bonavita, Teresa Duò (Katia) e il senatore comunista Gerardo Chiaromonte per affermare che Tutino, «uomo di fiducia del PCI per le relazioni con l'America latina» sarebbe stato un agente del blocco sovietico, richiamando la sua attività nella vicenda di Silvano Girotto, infiltratosi nelle Brigate rosse, e il suo rapporto con Morucci e Faranda. L'indicazione fu presa sul serio dal SISMI (Nota del Direttore ai Centri, Prot. 36358/1/4 del 21 dicembre 1982), che ritenne plausibile questo ruolo di Tutino, non in relazione dissociazione di Bonavita, e evidenziò la sua collaborazione a "Le Monde", un giornale che veniva descritto come particolarmente infiltrato. Certo è che i rapporti tra Tutino e Potere operaio sono documentati e ciò rende assai poco credibile una non conoscenza di Morucci, che in quel movimento aveva avuto un ruolo importante e pubblicamente ben
noto.
6.2. L'arresto di Morucci e Faranda
Nella precedente relazione si è dato estesamente conto delle acquisizioni compiute in relazione all'arresto di Morucci e Faranda, avvenuto il 29 maggio 1979.
In particolare, le indagini hanno consentito di identificare una fonte che rivelò a un sottufficiale di Polizia, il maresciallo Nicola Mainardi, il rifugio di Morucci e Faranda. Tale fonte si identifica con i gestori di un autosalone della zona portuense (AutoCia srl), presso la quale Adriana Faranda acquistò due auto: una Citroën Mehari il 21 maggio 1976 e una A112 il 19 aprile 1977.
Gli ulteriori approfondimenti compiuti hanno confermato la frequentazione di Morucci con i titolari della Società AutoCia srl, che è stata del resto ammessa anche da Morucci e Faranda nelle loro audizioni presso la Commissione. Uno dei gestori, Olindo Andreini, era infatti una vecchia conoscenza di Morucci, mentre un altro, Dario Bozzetti, stando a quanto riferito dal maresciallo Mainardi, fornì l'informazione sul rifugio di Morucci e Faranda.
Si è inoltre verificato un coinvolgimento dei gestori della società AutoCia in attività di contraffazione documentale nel settore delle autovetture, che potrebbero essere state svolte anche a beneficio di Morucci e Faranda. Infatti, è stata rilevata, tra la documentazione sequestrata nel covo di viale Giulio Cesare, la presenza di documenti di circolazione di automobili e di contrassegni assicurativi in bianco che rimandano alle attività della società AutoCia. Ulteriori accertamenti hanno poi evidenziato attività di falsificazione di documenti e valuta da parte di due dei gestori dell'AutoCia, che appaiono pienamente inseriti in attività illegali, anche di fornitura di mezzi a veri e propri sodalizi criminali.
Se dunque appare indubbio che elementi informativi transitarono alla Polizia dalla AutoCia e portarono all'attivazione della Squadra mobile della Questura, che il 29 maggio 1979 fece irruzione nel rifugio di Morucci e Faranda, ulteriori evidenze indicano l'esistenza di una parallela attivazione della DIGOS.
In proposito, è da tempo nota, e già acquisita dalla Commissione Stragi, un'informativa della DIGOS per la Procura di Roma, datata 30 maggio 1979 e firmata da Ansoino Andreassi, che fa riferimento a «notizie riservatissime» che avrebbero consentito di scoprire il covo di viale Giulio Cesare.
La stessa informativa sottolineava che sin dal sequestro Moro era maturata negli investigatori la convinzione che esistesse un covo brigatista in zona Prati e che «su tali basi, venivano pertanto attivate le fonti informative e, contestualmente, si procedeva ad un accurato vaglio di quelle persone, abitanti, in quella zona, che, per essere già note a questa DIGOS come appartenenti a formazioni dell'ultrasinistra, potevano fornire appoggio e ospitalità ai brigatisti rossi».
Anche il sottufficiale della Polizia che acquisì dai gestori della AutoCia le informazioni sull'appartamento di viale Giulio Cesare ha fornito, in audizione presso la Commissione, alcuni dettagli di interesse. Ha in particolare dichiarato, in relazione all'identificazione dell'abitazione e alla successiva irruzione, che «una volta entrati i pedinati al civico 47, sono tornato al commissariato di via Ruffini, e così si è deciso col dottor De Sena - c'era il dottor Andreassi, non so se c'era anche il dottor Spinella, allora dirigente - di fare irruzione appunto al civico 47. Il personale della DIGOS all'epoca conosceva molto meglio di noi gli altri personaggi, e ricordo che quando hanno visto sul citofono il nominativo della professoressa di matematica, sono andati direttamente al piano del suo appartamento, perché pare che avessero fatto già in precedenza delle perquisizioni».
Anche l'ispettrice Maria Vozzi, escussa da collaboratori della Commissione il 5 luglio 2016, ha ricordato di aver partecipato, insieme al dottor De Sena a un servizio di appostamento intorno a viale Giulio Cesare alcuni giorni prima dell'irruzione. Nel corso dell'audizione dell'11 luglio 2017 la stessa Adriana Faranda ha ricordato che, al momento dell'arresto, ci fu un qualche contrasto tra un operante e un altro «che non voleva portarmi in Questura».
Nel complesso, le indicazioni raccolte sembrano rimandare a una fonte di conoscenza del covo di viale Giulio Cesare autonoma e indipendente dalla fonte confidenziale attivata dal maresciallo Mainardi. Tale fonte di conoscenza potrebbe collocarsi nell'ambiente che favorì la latitanza di Morucci e Faranda nel corso del 1979 e potrebbe aver svolto la funzione di tramite con ambienti, investigativi o politici.
La stessa Conforto, pur nella relativa confusione ideologica che la caratterizzava, non era personaggio ignoto alle forze di polizia. Le informative che riguardano lei e il marito Massimo Corbò - da cui si era separata - datano almeno al novembre 1968, quando una informativa del Questore di Roma al Ministero dell'interno (Prot.:224/1152 del 13 novembre 1968) rilevava che «al pari del Corbò professa idee filo-castriste». Anche in periodo più vicino alla scoperta di Morucci e Faranda si rileva una nota analitica del 3 febbraio 1978 nella quale si rievocano il suo rapporto con l'editore francese Georges Mattei, altro promotore di movimenti di guerriglia nei Paesi del Terzo mondo, e il lungo soggiorno della Conforto e del Corbò in Venezuela, dove entrò in rapporto con movimenti guerriglieri e insegnò all'università di Merida, venendo licenziata dal CNEN a cui inviava certificati di
malattia.
Né erano ignoti gli esponenti di quell'ambiente, erede del Collettivo di fisica, che si erano legati al gruppo di "Metropoli" e che in alcuni casi operarono come testi a discarico della Conforto, analogamente a quanto era accaduto in altri procedimenti contro estremisti. Un'informativa di polizia del 19 luglio 1979 acquisita agli atti della Commissione, ricordava appunto, tra i molti testi sui quali «sono stati avanzati seri dubbi e sospetti di falsa testimonianza» Anna Maria Conforto, la zia di Giuliana, a proposito della quale si ricordava che «il fratello Giorgio è agente "A" a favore dell'Unione sovietica». Come è noto, Anna Maria Conforto era proprietaria e utilizzava un appartamento sito in via di Porta Tiburtina n. 36 che era sullo stesso piano di un locale nel quale, il 28 aprile 1977, era stato scoperto un covo eversivo dei NAP, utilizzato, tra gli altri, da Luigi Rosati, ex marito di Adriana
Faranda.
Si colloca in questo ambito la vicenda di Giorgio Conforto, il padre di Giuliana, assurto alle cronache come agente del KGB dopo la pubblicazione del dossier Mitrokhin,
Come è noto, nel corso di un'audizione presso Commissione Mitrokhin del 1 marzo 2004, Cossiga affermò: «Fu lui [Conforto] (questo lo so per certo) che, per difendere il Partito comunista italiano da accuse di collusione con le Brigate rosse, denunziò, all'allora capo della squadra mobile Masone, Faranda e Morucci, che abitavano nella casa della figlia. L'uomo che fece arrestare Faranda e Morucci è quello che qui è considerato il più grande agente sovietico, Conforto. Fece ciò perché la figlia non sapeva nulla. Sapeva soltanto che questi erano elementi di sinistra. La figlia era un'extraparlamentare non comunista. Quando lui capì chi erano le persone che erano in casa della figlia contattò Masone».
Le affermazioni di Cossiga non hanno potuto essere riscontrate. A quella data tanto Conforto che Masone erano infatti ormai deceduti.
L'indicazione che l'arresto sia stato in qualche modo "negoziato" da o per il tramite di Conforto può tuttavia trovare qualche riscontro nella vicenda processuale di Giuliana Conforto, che fu assolta in tempi rapidi dalle gravi imputazioni che le furono contestate e di cui appare difficile ipotizzare una completa inconsapevolezza della natura dell'ospitalità concessa a Morucci e Faranda.
Ancora più rilevante appare è il fatto che, al momento dell'arresto di Morucci e Faranda, gli apparati dello Stato avevano piena consapevolezza del ruolo di Giorgio Conforto. Questi era noto all'OVRA sin dal 1933 e nel 1941, quando lavorava all'ufficio informazioni segrete del Ministero degli affari esteri, comunicò a Guido Leto, capo della polizia politica, di aver preso riservati contatti con esuli russi.
Inoltre, già nel 1946, uno dei responsabili dell'intelligence americana in Italia, James Jesus Angleton, era a conoscenza del nome e del presunto ruolo di spia sovietica di Giorgio Conforto e le stesse informazioni furono veicolate a Federico Umberto D'Amato, divenuto negli anni successivi il responsabile dell'Ufficio Affari Riservati, senza che Conforto subisse alcun tipo di conseguenza.
Inoltre, lo stesso Giorgio Conforto non risulta, secondo quanto già accertato dalla Commissione Stragi, intestatario di un fascicolo al Casellario politico centrale, utilizzato, fino al 1968, quale strumento di monitoraggio dei soggetti considerati eversivi. Il fatto testimonia di una assoluta particolarità del personaggio e induce a ritenere che il ruolo spionistico di Conforto in favore dell'URSS fosse quanto meno bilanciato da una sua funzione di confidente o fonte delle strutture di polizia italiane. Tale natura "doppia" è stata peraltro affermata - in termini generici - dal generale Antonio Federico Cornacchia nell'audizione presso la Commissione del 3 novembre 2016. In quell'occasione Cornacchia ha fatto riferimento, oltre ad antichi rapporti di Conforto con l'OVRA, a suoi rapporti tanto con la CIA che con il KGB.
Nei primi anni '70 la figura di Conforto era ben inquadrata nelle informative dei Servizi. Già in una informativa del 14 gennaio 1972 che il Raggruppamento Centri trasmetteva al Reparto D del SID, si ipotizzava che Conforto, "bruciato" quale agente del Servizio informativo sovietico, potesse essere impiegato in compiti di infiltrazione negli ambienti diplomatici dei Paesi satelliti, nonché di penetrazione nei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra, per la raccolta di "umori, commenti e propensioni" o, ancora, in un'attività di influenza e penetrazione nell'ambito del partito socialista in cui militava e del sindacato in cui agiva, verso posizioni filocomuniste.
Al momento dell'arresto della figlia, Conforto era dunque persona nota agli apparati di polizia. Eppure non si ritenne di compiere alcun accertamento su un possibile rapporto tra le sue attività e la presenza di Morucci e Faranda, fatto ancor più sconcertante perché, dopo la scoperta della base di viale Giulio Cesare, furono condotte molteplici e analitiche indagini sui reperti del covo e sulle persone che erano entrate, a vario titolo, in contatto con i due brigatisti.
Nulla infatti risulta né da atti di polizia né da atti giudiziari, se non una testimonianza resa da Giorgio Conforto al giudice Francesco Amato il 5 luglio 1979, nella quale Conforto si limitò a rievocare un saltuario incontro con Morucci e Faranda a casa di Giuliana.
Eppure circa un mese dopo l'arresto si trova una nota(1) su Conforto, tempestivamente inviata dal SISMI al SISDE (e poi da questo ai Centri 1 e 2), «Capo della Polizia e Segretario generale del CESIS informati» l'8 giugno 1979, nella quale si fornivano elementi su Giuliana e Giorgio Conforto, ipotizzando che quest'ultimo «bruciato come agente informatore sovietico, sia rimasto, nel dopoguerra, fiduciario del KGB il quale potrebbe averlo manovrato non più nel campo spionistico tradizionale, ma [potrebbe] avvalersene come "agente d'influenza" nel settore politico con compiti di: infiltrazione negli ambienti diplomatici dei Paesi satelliti ed allineati; penetrazione nei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra, per la raccolta di umori, commenti e propensioni; influenza e penetrazione nell'ambito del partito in cui milita».
Come si vede, la nota riprendeva, nella chiusa, le considerazioni già formulate nella nota che il Raggruppamento Centri Cs aveva fatto pervenire al reparto D nel 1972(2). Pur non essendo particolarmente aggiornata, essa formulava delle ipotesi abbastanza precise e realistiche, che avrebbero ben potuto guidare l'azione dell'Autorità giudiziaria.
Audito dalla Commissione Stragi il 1 dicembre 1999, il dottor Ansoino Andreassi, uno dei funzionari di polizia che più seguirono quella vicenda, rispose a una serie di quesiti sul tema. In particolare il deputato Fragalà gli chiese se ricordava « se, in qualità di numero due della DIGOS capitolina ebbe modo di leggere le due note del SISMI, pervenute alla questura di Roma l'8 e l'11 giugno 1979, cioè due settimane dopo la scoperta del covo di Morucci e Faranda, note SISMI relative a Giorgio Conforto, che oggi sappiamo - attraverso l'archivio Mitrokhin - essere il capo della rete spionistica sovietica in Italia e padre della donna che aveva dato ospitalità ai latitanti Valerio Morucci e Adriana Faranda».
In risposta Andreassi precisò di ricordare le note del SISMI e «che pervennero informalmente alla DIGOS», come «appunti senza alcuna intestazione, diciamo in bianco, trasmessi al questore di Roma dal direttore del Servizio dell'epoca», nei quali «si elencavano i precedenti del Conforto e cioè si diceva che costui era stato un membro del KGB». Ciò portò a una contestazione. Sempre il deputato Fragalà chiese infatti «come è stato possibile che questa nota del SISMI, soprattutto quello che voi avete poi saputo, come DIGOS romana, non sia stato mai comunicato al dottor Imposimato, al dottor Priore o alla procura di Roma» e il dottor Andreassi precisò di ricordare che quegli appunti del SISMI «non furono trasmessi ufficialmente all'autorità giudiziaria, ma l'autorità giudiziaria fu portata a conoscenza del contenuto degli
appunti».
Le audizioni dei giudici Imposimato e Priore portarono ulteriori precisazioni sul tema. Nell'audizione del 24 novembre 1999 il giudice Imposimato affermò testualmente, a proposito degli appunti: «Noi non ne siamo mai stati informati; io ne ho conosciuto soltanto alcune sintesi dai giornali. Ovviamente è molto grave il fatto che noi non siamo stati informati dei precedenti di Giorgio Conforto. Tra l'altro, io avevo il pallino di cercare di capire se c'era stata una partecipazione di servizi segreti stranieri e su questi avevo già concentrato, questo risulta dalla sentenza del 1982, la mia attenzione, perché ero certo che c'era stata una partecipazione di questi Servizi. Considero gravissimo che non ci siano stati dati elementi che mettessero in evidenza la figura di Giorgio Conforto, il quale appare come un vecchio di 79-80 anni che era andato a prendere i nipotini e che era capitato lì per caso, non come uno che
abitava nella casa di Giuliana Conforto. Tra l'altro, di questa vicenda, per la verità, non perché voglia sottrarmi a delle risposte, si è occupato Francesco Amato; non so se lo ha interrogato lui oppure se ha interrogato Giuliana Conforto».
Da parte sua, il giudice Priore, nell'audizione del 1 dicembre 1999, rispose a una domanda del Presidente Pellegrino, che gli chiese se «nel momento in cui emerse che la Conforto era un'ospite attiva di Morucci e Faranda, i servizi vi informarono del copioso fascicolo che avevano sul padre». Il magistrato affermò che nessuna informazione pervenne e che Conforto era «un personaggio, quindi, di notevole statura della quale però all'epoca della perquisizione a casa della figlia nulla era emerso».
Imposimato ha successivamente fornito ulteriori precisazioni in un libro-intervista.(3) In quella sede, trattando delle informative dei Servizi, ha affermato che «so con certezza che il SISMI portò quella nota informativa a conoscenza di molte persone. So anche che il generale Santovito lo fece di persona, ma senza lasciare alcunché di scritto. A voce illustrò il contenuto di quel dossier a esponenti di governo, ai vertici di polizia e carabinieri e anche al capo dei giudici istruttori di Roma, Achille Gallucci. Ma a Priore e me, che indagavamo sul caso Moro, non disse nulla». Allo stato non si rinvengono però tracce documentali di questa così diffusa circolazione.
In conclusione appare certo che nel 1979 la DIGOS disponeva degli appunti del SISMI che qualificavano Giorgio Conforto come agente del KGB e che si rinunciò a approfondire questa cruciale notizia in una sede giudiziaria, garantendo a Giuliana Conforto un trattamento di favore. Il SISMI appare estraneo a una possibile filiera informativa Conforto/Ufficio Affari riservati e, correttamente, trasmise agli inquirenti informazioni che questi avrebbero dovuto, stando a una normale e lineare valutazione operativa, considerata la rilevanza delle notizie apprese, quantomeno approfondire con incisività, di iniziativa o su un impulso - che non venne - da parte dell'autorità giudiziaria.
Va a questo proposito segnalato che, secondo quanto riferito da una nota della Questura di Roma del 12 giugno 1979, il giorno precedente si era svolta una ulteriore perquisizione in casa di Giuliana Conforto, alla quale presenziarono i giudici Imposimato e Priore, gli avvocati di Giuliana Conforto, Cascone e Ventre, e anche i genitori della stessa, Giorgio Conforto e Elda Giuliani. A questa data esistevano tutte le condizioni perché i due magistrati avessero consapevolezza della figura di Conforto, ma nulla risulta in merito.
Anche su questo punto la Commissione ha compiuto ricerche, che hanno fatto emergere riscontri documentali. È stata infatti reperita e acquisita agli atti della Commissione una nota del SISMI al Capo della Polizia, Coronas, dell'8 giugno 1979 (Prot. 04/11855/R/1), con la quale il Servizio tracciava un rapido e esauriente profilo di Giuliana e Giorgio Conforto, definendo quest'ultimo «agente accertato dei Servizi informativi sovietici». L'appunto fu consegnato con una "riservata personale" al Questore di Roma, Emanuele De Francesco. Secondo una manoscrittura scritta da un funzionario di Polizia e datata 14 giugno 1979 apposta agli appunti SISMI su Conforto, «il contenuto di questo appunto è stato portato riservatamente a conoscenza del Cons. Gallucci». Se ne deve dunque concludere che, alla metà di giugno 1979, oltre al SISMI, l'UCIGOS e il giudice Gallucci erano pienamente consapevolmente del ruolo di Conforto, ma
non ritennero utile approfondire minimamente il suo ruolo.
Il nesso tra i Conforto e Morucci/Faranda riemerse dunque inopinatamente solo quando, per una casualità storica, fu diffuso il cosiddetto Dossier Mitrokhin. Allo stato non è possibile affermare in maniera certa se dietro a questa omissione ci fu trascuratezza o un preciso ragionamento politico-giudiziario. Alla luce delle tarde affermazioni di Cossiga si può tuttavia ipotizzare un ruolo di Conforto nell'individuazione di Morucci e Faranda. Se questo vi fu, esso non dovette però svolgersi a vantaggio del PCI e dell'URSS ma piuttosto nell'ambito di una filiera interna agli apparati italiani, data la natura assai ambigua dell'agente Giorgio Conforto, ampiamente noto e, per ciò stesso, manipolabile.
Vi è da aggiungere che, per tutelare la figlia dall'accusa di essere complice dei brigatisti, Giorgio Conforto scelse l'avvocato Alfonso Cascone, già difensore di Enrico Triaca, titolare della tipografia brigatista di via Foà. Cascone, militante a lungo in formazioni della sinistra extraparlamentare, e per questo più volte segnalato presso gli organismi informativi e di polizia, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, era indicato come fonte confidenziale dell'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno, diretto da Federico Umberto D'Amato. Cascone dunque apparterrebbe alla stessa filiera informativa di Conforto e ne condivide molti tratti caratteristici, primo fra tutti l'appartenenza a un'area extraparlamentare di sinistra non comunista che si rivelò - sin dai tempi di "Controinformazione" - particolarmente permeabile a influenze esterne.
Conclusivamente la latitanza di Morucci e Faranda in casa Conforto e l'arresto del 29 maggio evidenziano numerosi elementi che sembrano ricondurre all'azione di persone, indipendenti dalla Squadra mobile, che erano a conoscenza del rifugio e cercarono di gestire l'operazione, venendo in qualche modo superati dall'attivazione della fonte AutoCia. È possibile che proprio questi elementi- che si trattasse di Conforto o di altri - abbiano posto le basi di una trattativa che in quella fase non poté realizzarsi, finalizzata a ottenere la consegna di Morucci e Faranda e a sfruttarne le posizioni fortemente critiche nei confronti delle Brigate rosse.
Va a questo proposito sottolineato che né Morucci né la Faranda hanno mai chiarito che tipo di prospettiva intendevano seguire dopo essersi rifugiati in casa Conforto e dopo il sostanziale fallimento del loro tentativo di creare un movimento armato alternativo alle Brigate rosse. Nell'audizione presso la Commissione dell'11 luglio 2017 Adriana Faranda ha dichiarato che «essendo già a casa di Giuliana, pensavamo di resistere il più possibile in questo appartamento, che a noi sembrava il più sicuro che avessimo trovato, e difficilmente avremmo trovato una soluzione diversa.Dopo la batosta dell'inchiesta sull'Autonomia, noi... Intanto, nell'atto fondativo del nuovo gruppo c'era esplicitamente il rifiuto dell'omicidio politico, quindi già questa era una grande discriminante. Erano previste azioni molto legate ai bisogni del proletariato e delle borgate, ma erano previste al massimo delle gogne come progetto
politico; neanche ferimenti, erano previste semplicemente delle gogne».
Morucci, che ha rifiutato di rispondere a un'analoga domanda, dichiarò in udienza dibattimentale al Processo Metropoli il 10 marzo 1987 di aver portato a casa Conforto le armi il giorno prima dell'arresto, fatto che non ha riscontri ulteriori. Le armi sarebbero servite per una azione dimostrativa alquanto inverosimile che avrebbe dovuto svolgersi il giorno dell'arresto, ovvero l'occupazione di una palazzina sfitta in via delle Medaglie d'Oro in cui «bisognava entrare dentro e mettere degli striscioni dal balcone». In quella sede Morucci non fu però in grado di dare altre precisazioni in merito.
6.3.L'elenco dei 94 nomi
Allo scopo di chiarire fino in fondo la complessa vicenda dell'arresto di viale Giulio Cesare, la Commissione ha delegato alla Polizia di Stato una serie di accertamenti sui corpi di reato reperiti in viale Giulio Cesare. In questo ambito è emersa la presenza, nel covo, di due copie identiche di un elenco comprendente 94 nominativi di terroristi o estremisti di sinistra.
La singolarità della presenza in una base brigatista di tale elenco non sfuggì agli operanti di Polizia dell'epoca. Gli elenchi furono infatti trasmessi con una informativa non firmata dalla Questura di Roma all'Autorità giudiziaria datata 31 maggio 1979, due giorni dopo la scoperta del covo. Più precisamente, la minuta della nota di trasmissione, era indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ma fu modificata con una manoscrittura che rettificò il destinatario in "Procura generale". Un biglietto allegato, di mano del dottor Spinella, chiariva che la trasmissione era avvenuta brevi manu.
L'elenco in questione non fu oggetto di utilizzazione in una sede processuale ed ebbe un esito giudiziario assai singolare.
Accurati accertamenti condotti con la collaborazione della Procura generale presso la Corte di Appello di Roma hanno consentito di reperire l'originale dell'elenco e di accertare che esso pervenne il 5 giugno 1979 e rimase presso gli uffici della Procura generale (protocollato con Prot. riservato - Ufficio del Dirigente della Segreteria) e non fu ricongiunto ai corpi di reato.
Nel fascicolo presente alla Procura generale non risultano ulteriori accertamenti o atti direttamente riconducibili all'elenco. Tuttavia, una nota manoscritta del sostituto procuratore Guido Guasco, presente agli atti e datata 20 ottobre 1979, riportava «V.[isto] agli atti d'archivio trattandosi di un mero elenco di persone imputate, ovvero indiziate a fini di perquisizione, o semplicemente reperite nelle indagini relative al sequestro e all'omicidio dell'on. Moro».
In sostanza, dunque, la Procura generale si limitò a verificare nell'abnorme tempo di quattro mesi che i nominativi erano in qualche modo già noti in atti, ma non ritenne - per quanto emerge dalla documentazione - di svolgere accertamenti sull'origine dell'elenco e sulle ragioni della sua presenza in una base brigatista. Anche successivamente non furono svolte indagini in merito, poiché l'elenco fu conservato negli archivi della Procura e non entrò a far parte di alcun fascicolo processuale. Non a caso, esso non si ritrova tra gli atti del processo Moro e Moro-bis - che furono successivamente pubblicati presso la prima Commissione Moro - né presso l'Ufficio corpi di reato.
La Commissione ha ritenuto necessario approfondire la natura del documento, le ragioni della sua presenza a viale Giulio Cesare e la sua possibile origine.
Innanzi tutto si è accertato che l'elenco era presente all'interno di una busta (reperto 210), sequestrata nella stanza utilizzata da Morucci e Faranda. Tale busta conteneva, oltre all'elenco, alcune manoscritture che, sottoposte a perizia depositata il 5 novembre 1979, furono riconosciute come di mano di Adriana Faranda. Si è verificato, presso l'Ufficio corpi di reato, che il reperto 210 manca appunto dell'elenco che fu estrapolato e consegnato alla Procura generale di Roma.
Per quanto riguarda le ragioni della presenza dell'elenco in una congerie di materiali sicuramente riconducibile a Morucci e Faranda, Valerio Morucci, nell'audizione del 17 gennaio 2017, ha affermato che l'elenco non poteva essere tra i materiali a lui sequestrati, che non era in grado di fornire alcuna spiegazione e che questa avrebbe eventualmente dovuto essere chiesta a chi stilò il verbale di sequestro. Ha inoltre aggiunto di non essere mai stato interrogato sul punto.
Nell'audizione dell'11 luglio 2017 Adriana Faranda ha invece affermato che l'elenco era nella sua disponibilità, che non era conosciuto da Morucci e che proveniva dal Fronte della Contro. In particolare ha dichiarato che «nella confusione di quando siamo scappati da dove abitavamo prima per andar via dall'organizzazione, io ho acchiappato tutto, anche questo, che a noi non serviva in realtà. Era arrivato dal "fronte della contro", se non mi sbaglio mi avevano detto che era stato sottratto in un commissariato ed era un elenco che non avevamo stilato noi, ma che aveva stilato qualcuno delle forze dell'ordine o del Ministero (adesso non so, poteva anche essere un ufficio del Ministero, ma mi riecheggia nella memoria questo fatto del commissariato, che era stato sottratto in un commissariato)».
L'esame dei contenuti del documento rivela che, alla data 31 maggio 1979, dei 94 nominativi dell'elenco (comprensivi di 11 alias o nomi di copertura) 20 erano detenuti, 11 latitanti, 14 erano stati già oggetto di provvedimenti restrittivi, 23 erano emersi a vario titolo in indagini sull'eversione, 11 non erano noti alla Direzione centrale della Polizia ma erano spesso collegati, anche per ragioni familiari, a estremisti noti.
L'elenco presenta inoltre diverse singolarità, che mette conto sottolineare.
In primo luogo l'elenco non comprende esclusivamente nomi di brigatisti, ma anche altri esponenti di un generico estremismo di sinistra e un personaggio entrato nelle indagini nella prima fase della vicenda Moro, Franco Moreno. Ritenuto vicino a ambienti dell'estremismo, Moreno era stato imputato per spionaggio politico nel 1973 per aver pedinato una segretaria dell'ambasciata del Libano in Italia. Nel febbraio 1978 era stato più volte segnalato come presente nei paraggi dello studio di Moro in via Savoia, indagato e sottoposto a fermo giudiziario dopo la strage di via Fani. A suo tempo, il Procuratore Infelisi dichiarò alla prima Commissione Moro di avere approfondito con sicurezza la posizione di Moreno prima di disporne il rilascio.
In secondo luogo l'elenco comprende numerose, evidenti sviste ed errori ortografici che sembrano indicare che chi lo dattiloscrisse non aveva precisa cognizione dei nomi che stava trascrivendo. Se ne deve concludere che l'elenco fu il frutto di una battitura o ribattitura affrettata o basata su un preesistente elenco, verosimilmente manoscritto e scritto rapidamente o in maniera poco chiara, o su una raccolta di documentazione.
Tali elementi rendono dunque verosimile che la persona che redasse l'elenco reperito agli atti della Procura non aveva titolo ad accedere alla documentazione giudiziaria e che ottenne l'elenco di nomi o agendo copertamente o perché gli fu "passato".
Il riferimento di Adriana Faranda ad un elaborato in possesso del Fronte della Contro non è, di per sé, implausibile. È però sicuramente da escludere che un elenco siffatto derivi da un commissariato, mentre appare assai più probabile che sia stato originato a un livello giudiziario o investigativo "alto". Esso avrebbe dunque dovuto essere stato fornito alla Faranda da persona in grado di acquisire in tali ambienti o l'elenco stesso o le notizie che ne erano alla base.
Ciò può spiegare anche l'atteggiamento tenuto dalla Procura generale nel 1979. La consapevolezza di un'origine interna agli uffici giudiziari può aver indotto a non approfondire l'origine dell'elenco, come sarebbe stato invece doveroso, e a limitarsi a verificare che i nominativi in esso contenuti erano, in tutto o in parte, noti in atti.
L'individuazione dell'intermediario che procurò l'elenco, allo stato, dipende dalla volontà di Morucci e Faranda di fare chiarezza su una vicenda che suscita numerosi dubbi e interrogativi sulle complicità di cui poterono giovarsi i due brigatisti e sulla possibilità che l'elenco sia stato consegnato da una delle persone che si poterono incaricare di intavolare una trattativa con i due latitanti.
6.4.Il "memoriale Morucci" e la sua genesi
Il percorso dissociativo di Morucci e Faranda, e in particolare del primo, presenta evidenti particolarità, sia rispetto al pentitismo che rispetto a posizioni rivendicative della giustezza della lotta armata, particolarità che del resto l'interessato ha sempre rivendicato.
Come ha ricordato Adriana Faranda nella sua audizione presso la Commissione del 19 luglio 2017, tale posizione si definisce nel corso del primo processo Moro «con una lettera che parlava di necessità di superare la lotta armata» e si realizzò con un percorso collettivo, «senza essere assimilati né da una parte ai pentiti, né dall'altra anche alla dissociazione politica che veniva da altre esperienze che non avevano fatto parte di organizzazioni armate, come i compagni arrestati il 7 aprile, il gruppo di Toni Negri».
A caratterizzare la posizione di Morucci e Faranda non è però solo il tentativo di seguire un percorso autonomo rispetto alla lotta armata, ma la capacità di distillare progressivamente una serie di informazioni sulla vicenda Moro, frutto sia della loro esperienza diretta sia di informazioni apprese o dedotte, ricercando una pluralità di interlocutori, dal mondo politico e giornalistico, alla magistratura ad apparati dello Stato. In tal modo venne a definirsi, attraverso un processo complesso che si sviluppò almeno lungo tutti gli anni '80, un "perimetro" della verità accertabile sul caso Moro, che ne ha espunto numerosi punti problematici su cui si è sviluppato il lavoro della Commissione.
Le dichiarazioni rese tra il 1984 e il 1988 furono del resto in gran parte recepite nel processo Moro-ter e fondarono in parte significativa la conoscenza, giudiziariamente convalidata, della vicenda Moro, spingendo in molti casi a mettere in secondo piano le dichiarazioni di alcuni pentiti dei primi anni '80.
Naturalmente, proprio il rilascio progressivo di informazioni non ha mancato di produrre dei corto-circuiti interpretativi, con la necessità di correzioni e revisioni progressive.
Il percorso ricostruttivo che muove dalle dichiarazioni di Morucci, in primo luogo, e della Faranda, secondariamente, integra dunque diversi elementi di una "negoziazione" che appare necessario chiarire nei suoi passaggi specifici e documentalmente analizzabili. In questo ambito, numerosi elementi di novità sono emersi nella documentazione che la Commissione ha acquisito presso l'AISI e che viene di seguito illustrata.
Come è noto, in una prima fase, Morucci e Faranda presero le distanze dalle Brigate rosse, pur rifiutando di fornire dichiarazioni alla Magistratura.
Un appunto SISDE del 9 agosto 1979 (Prot. 1818/12) riferiva a tale proposito che Morucci «ritiene superata la fase di egemonia politico-organizzativa di una "linea" sulle altre e spera in un immediato chiarimento interno alle organizzazioni rivoluzionarie». Un successivo appunto della fine di ottobre (Prot. 1818/32) che esaminava la situazione di alcuni detenuti a Rebibbia riportava invece che «Valerio Morucci mantiene un comportamento "strano". Pur sapendo di rischiare l'ergastolo è continuamente allegro ed entusiasta».
I primi segni di un cambiamento di posizione potrebbero essersi determinati già nel 1980. In quell'anno, da quanto risulta da una biografia, suor Teresilla Barillà cominciò a frequentarli.(4)
Inoltre, il 5 maggio 1980 un appunto del Centro SISDE Roma 1 alla Direzione del Servizio (Prot.:1818/70) riferiva che «in un rapporto epistolare tra i noti Valerio Morucci e Adriana Faranda, il Morucci ha fatto presente di aver ricevuto una "strana" visita da parte del Giudice Imposimato che gli ha fatto dei discorsi sulla fine della lotta armata gongolando come il gatto che ha mangiato il topo». Questa considerazione, in sé non del tutto comprensibile, potrebbe riferirsi a un primo tentativo di definire un percorso dissociativo. Si era del resto nella fase in cui Patrizio Peci aveva cominciato a rilasciare dichiarazioni, che divennero pubbliche proprio nel maggio 1980, dopo una fuga di notizie (caso Isman-Russomanno).
Un'altra possibile spiegazione di questa visita potrebbe ritrovarsi in uno scritto che Morucci redasse per "Controinformazione" nell'aprile 1980 e che fu acquisito dal SISDE «da fonte fiduciaria» nell'ottobre dello stesso anno (Prot.:1254/5). In quel testo Morucci prospettava, in polemica con le Brigate rosse, un superamento della lotta armata in favore di altre più articolate forme di conflittualità, pur prendendo nettamente le distanza dalla «spregevole e interessata loquacità di Peci».
La posizione di Morucci mutò decisamente a partire dall'inizio del 1983. In questa fase, in cui erano ormai acquisite le dichiarazioni di molti pentiti, Morucci avviò un personale percorso dissociativo, cui si associò anche la Faranda. In tale percorso sembrano aver giocato un ruolo particolarmente importante, in diversa forma, il giudice Imposimato e la citata suor Teresilla, al secolo Chiara Barillà, una religiosa che collaborava con monsignor Di Liegro e con la Caritas e che era da tempo impegnata in attività di assistenza ai carcerati, con la finalità di entrare in rapporto con esponenti del terrorismo politico e creare una sorta di pacificazione con le vittime.
L'approccio era religioso e assistenziale, ma acquisiva forti venature politiche, corrispondendo peraltro a una visione alquanto idealizzata della realtà dell'estremismo politico. Anche le testimonianze raccolte nel citato volume biografico hanno del resto ricordato gli sforzi della religiosa per creare un ponte tra i terroristi e la Democrazia cristiana, quasi ipotizzando una forma di pacificazione che prescindeva dagli aspetti strettamente giudiziari. Questi risultavano anzi condizionati e talora manipolati da una pluralità di rapporti intessuti tra i detenuti ed esponenti politici.
Non casualmente, nell'ordinanza del giudice Alemi di rinvio a giudizio per il processo relativo al sequestro Cirillo, il magistrato denunciò un non chiaro rapporto di uno dei principali pentiti, il brigatista Giovanni Planzio, con la religiosa, rilevando che «a quanto sembra, l'intervento della suddetta suora non era volto - come dichiarato nella richiesta di autorizzazione a incontrare i detenuti di Paliano - a instaurare con gli stessi un discorso etico-religioso e di riavvicinamento alla società civile, ma a discutere problemi di specifico interesse ed a concordare l'atteggiamento da assumere nei confronti della DC in ordine a specifici argomenti, in primis il sequestro Cirillo».
Si citava in particolare uno scritto, inviato a suor Teresilla e «indirizzato alle varie articolazioni della Democrazia cristiana», nella quale il Planzio e altri detenuti chiarivano la loro posizione «rispetto agli attacchi subiti dalla DC sulla vicenda Cirillo» e auspicavano «che la DC voglia difendere la nostra posizione attuale, così da non trovarci completamente scoperti di fronte a tutti. Tu sai a cosa vogliamo riferirci». Di qui una successiva lettera nella quale Planzio, modificando precedenti dichiarazioni, riduceva la questione del riscatto estorto dai brigatisti nel sequestro a un mero contatto con i familiari, sottolineando che «nessun approccio né compromesso è stato compiuto dalla DC».
Anche il Presidente dell'Associazione vittime del terrorismo, Maurizio Puddu, avanzò perplessità sulle attività della religiosa, anche se è doveroso ricordare che queste erano parte di una più ampia azione delle organizzazioni cattoliche rispetto al problema carcerario. In una intervista del 2007 ricordò che suor Teresilla «secondo me aveva tutte le stimmate tranne quelle della religiosa. Volle incontrarmi in un caffè di Roma, zona piazza Venezia. Mi faceva strane domande sull'associazione, insisteva perché intervenissi in favore dei terroristi detenuti. Ebbi l'impressione che lavorasse per i servizi segreti».(5)
Il 17 gennaio 1983, in udienza dibattimentale al Processo Moro, Morucci lesse una dichiarazione nella quale espresse la posizione sua e della Faranda. Mentre si assumeva la responsabilità della lotta armata, Morucci affermava che era «inutile ribattere ora, nella dichiarazione finale, alla specificità delle accuse che ci vengono mosse», in quanto «ci sembrano tanto superficiali, quanto meschini i tentativi di ridurre a pene dei singoli le responsabilità collettive della scelta di lotta armata di una generazione di militanti». Posta così su un terreno "politico" la questione, Morucci rivendicava la «battaglia» contro l'uccisione di Moro come una precisa scelta politica e affermava di aver maturato «non tanto e non solo una formale critica della lotta armata, ma soprattutto una critica del suo retroterra politico, ideologico e culturale». Di qui il discorso si allargava a proporre
una sorta di pacificazione politica, perché, secondo Morucci «è necessario e possibile far avanzare una cultura che contrasti la logica dell'emergenza permanente, l'insipienza politica che riproduce il blocco contro il blocco, il circolo vizioso della vendetta che risponde alla vendetta».
Il 3 febbraio 1983 Morucci fu audito in Commissione Moro. L'audizione fu sostanzialmente reticente su particolari concreti della vicenda Moro. Del resto Morucci chiarì sin dall'inizio del suo intervento che «se ritenevo quella sede [quella processuale] non opportuna per un qualsiasi sviluppo di argomentazioni politiche, non ritengo questa sede opportuna per qualsiasi sviluppo di argomentazioni che abbiano rilevanza penale».
Qualche particolare è tuttavia meritevole di nota. Rispondendo a una domanda dell'onorevole Violante, che - richiamandosi alla affermazioni svolte in una precedente audizione di Alfredo Buonavita - aveva chiesto se nella strage di via Fani erano stati impegnati più di dodici brigatisti, Morucci affermò «secondo me sì, ma non eccessivamente di più». Considerazione criptica, che potrebbe essere stata formulata in senso ironico oppure contenere elementi di verità mai successivamente emersi.
Le due dichiarazioni del 1983 hanno una grande importanza per comprendere le successive evoluzioni di Morucci e le sue progressive rivelazioni, spesso presentate come mere deduzioni e riflessioni. Attestatosi su una posizione politica fortemente autonoma, che rifiutava la prospettiva della lotta armata, ma rivendicava la necessità di un incontro politico tra lo Stato e i militanti del partito armato, Morucci poté presentarsi come portavoce di una più ampia platea di reclusi e acquisire una centralità che non aveva avuto nel corso del sequestro Moro, quando era stato confinato in una funzione principalmente esecutiva. Morucci poteva del resto portare in dote una conoscenza della vicenda Moro maggiore di quella dei principali pentiti, cosa che gli consentì di aprire un confronto con più interlocutori: l'Autorità giudiziaria, esponenti politici, religiosi impegnati in attività assistenziali,
apparati dello Stato. Non si tratta ovviamente di sindacare la legittimità di un simile percorso, ma è doveroso sottolineare in questa sede l'opacità di una situazione in cui lo stesso soggetto si presentava, spesso a distanza di pochi giorni, nella veste di imputato/testimone, consulente di apparati dello Stato, soggetto in dialogo con esponenti delle istituzioni, senza che ciò trasparisse chiaramente all'opinione pubblica.
Già nell'aprile 1984 appare evidente che Morucci si poneva, nei riguardi dell'Amministrazione penitenziaria, come il garante di una transizione dei brigatisti a forme di dissociazione. Il 12 maggio il Direttore del SISDE, Vincenzo Parisi, trasmetteva al CESIS (Prot. 3/19651) «per l'eventualità che non sia già nota» copia di una lettera inviata il 12 aprile 1984 da Morucci a «tale Di Blasio, non meglio identificato» [identificabile in Crescenzo Di Blasio, funzionario dell'Amministrazione penitenziaria]. Nel testo Morucci esponeva il suo personale programma di politica carceraria, finalizzato a un uso del carcere in funzione «controemergenziale» e alla ricerca di «soluzione politica».
La tesi era che la costruzione di aree omogenee nelle carceri - istituite a Torino, Roma, Bergamo e Firenze alla fine del 1983 - costituiva la più forte alternativa alla lotta armata e che, ove le sue proposte non fossero state accolte, si sarebbe determinato un rifluire dei detenuti dissociati in una dimensione privata, diminuendone l'utilità "politica".
Dopo aver lamentato che «il mantenimento dell'impropria ingerenza della magistratura nei problemi del carcere (a fronte del blocco di attività legislativa, preventiva, depenalizzazione, nuovo codice di procedura), o la sudditanza allo stallo del quadro generale, in questo punto nevralgico del rapporto tra istituzioni e devianza sociale, non può che portare a enormi pericoli», Morucci rilevava che «la rimozione della natura politica del fenomeno e la sua forzata e interessata riduzione nei parametri penali di criminalizzazione, ha bloccato ogni possibilità di battaglia politica all'interno dell'area della sovversione sociale che è a tutt'oggi il serbatoio cui attinge l'iniziativa minoritaria del terrorismo».
Pur con un linguaggio involuto, Morucci avanzava una precisa proposta e richiesta. Occorreva che i dirigenti terroristi che avevano rinunciato alla lotta armata fossero messi in condizione di esercitare un'influenza - positiva per lo Stato - sul "movimento rivoluzionario". Si lamentava in particolare che «aver lasciato come unica strada quella della "lealizzazione istituzionale" ha drasticamente ridotto le nostre potenzialità di intervento ed ha favorito quanti, per non fare i conti con le posizioni di chi la lotta armata l'aveva già fatta, hanno potuto tacciarle come "estranee" al movimento rivoluzionario, scelte opportuniste di "sconfitti"».
Morucci si intestava quindi un ruolo importante e rivendicava quello sin allora svolto: «con l'attuale limitazione del nostro intervento alla semplice "verbalizzazione" della critica alla lotta armata, tutto il lavoro compiuto risulterà vano, la macchina si fermerà, o andrà indietro, e la violenza riesploderà all'interno del carcere». La chiave era dunque quella delle cosiddette "aree omogenee", «perché è con questa iniziativa che dovrebbero fare i conti quanti ancora predicano la scelta della lotta armata». Secondo Morucci, «l'Italia si trova nella condizione particolare di avere nelle sue carceri l'assoluta maggioranza dei dirigenti politici della lotta armata disponibili a proporre e praticare dinamiche conflittuali non terroristiche» e «questo fa sì che il carcere non sia centrale solo nella politica segregativa o risocializzante, ma centrale nelle dinamiche
di ripresa o di sconfitta della lotta armata».
In concreto ciò implicava, secondo Morucci, la «necessità immediata di raggruppamenti di detenuti politici "critici". [...] Raggruppamenti omogenei e senza il bilancino della "furbizia"». Secondariamente, le aree dovevano essere costituite «in carceri il più vicino possibile alle città in cui i detenuti hanno sviluppato la propria esperienza politica, e dove questa è perciò riconosciuta» e garantire «promozione di incontri con giornalisti, associazioni che si occupano di carcere, intellettuali, forze della cultura...» nonché «allargamento di possibilità di colloqui interni (cosa si sarebbe dovuto dire ad Amato, quando si è chiesto come mai non riuscivamo a far ragionare concretamente quelli del G7 [i bracci speciali per terroristi]?».
Ancora più netta era la conclusione. Morucci lamentava la «impasse» dell'area, «impasse che coincideva con la fine del suo "monopolio" nel confronto con le istituzioni e con la fine della sua possibile utilizzazione puramente strumentale in funzione dei processi e delle chances di liberazione dei singoli» e rilevava che «la fine del processo 7 aprile (quindi dell'utilità dell'area in funzione di quel processo) segnerà sicuramente l'inizio della diaspora, l'avvio dei più incontrollati comportamenti individuali». Era dunque necessario rilanciare l'area - alle condizioni indicate dallo stesso Morucci - in modo da sostenere l'azione antiterroristica dello Stato in funzione di un contrasto al terrorismo da affidare agli stessi dissociati.
Gli ampi stralci del documento evidenziano come - a non più di cinque anni dal suo arresto - Morucci stesse ormai raccogliendo i frutti di un confronto ormai avanzato con le istituzioni, proponendosi come il garante di un riassorbimento del terrorismo in una forma di dibattito politico antagonista, che avrebbe dovuto incrinare la posizione di fermezza sin lì praticata dalle istituzioni. La sua posizione, consonante con quella espressa anche da altri gruppi di dissociati che in quel periodo cercarono di valorizzare la loro posizione "politica" in contrapposizione ai "pentiti", diede a Morucci ulteriori possibilità di proseguire il suo percorso politico iniziato durante il sequestro Moro, venendo riconosciuto come interlocutore affidabile.
Vanno però rilevate le evidenti criticità di una posizione nella quale la stessa persona si avviava a giocare il ruolo di testimone chiave nel Processo Moro-ter e di garante della gestione dei detenuti brigatisti nel carcere di Paliano nonché di produttore di informative e di ipotesi di politica carceraria. Si tratta del resto di una posizione assolutamente senza riscontri, di cui non poterono godere né i pentiti né, tanto meno, gli irriducibili, e che si venne costruendo su un terreno prettamente politico, realizzando nei fatti quella "soluzione politica" che veniva negata a parole.
Il 13 settembre 1984 Morucci e Faranda indirizzarono una lettera al giudice Niccolò Amato, allora Direttore del DAP, nella quale manifestavano la decisione di «fornire dichiarazioni spontanee al GI su tutto ciò che è a nostra conoscenza della vicenda originaria e seguita al sequestro dell'On. Aldo Moro». Ciò per le «mutate condizioni sociali e politiche», legate anche alla sensibilizzazione al tema della dissociazione e alla costituzione delle aree omogenee.
Alla lettera era allegata una lunga "Premessa", indirizzata al giudice Imposimato e datata "Carcere di Rebibbia, luglio 1984", nella quale i due brigatisti ribadivano che il loro contributo alla verità escludeva di nominare militanti delle BR e riaffermavano la loro volontà di mettere ordine rispetto alle dichiarazioni dei pentiti, che avevano «favorito il fiorire delle supposizioni di quanti preferirebbero attribuire ogni male occorso al paese alle "oscure e impenetrabili manovre" di turno».
I due testi in questione sono noti in quanto furono acquisiti «in via informale» dal SISDE e trasmessi, il 3 ottobre 1984, al Segretario generale del CESIS. Poco dopo, il 12 ottobre 1984, una informativa riferiva di una riunione di autonomi nella sede di Radio Onda Rossa, che valutò criticamente la decisione di Morucci e Faranda di collaborare con la Magistratura.
La "Premessa" per Amato e Imposimato era in realtà già stata data al giudice istruttore Imposimato nell'ambito del procedimento 17/84 (cosiddetto "Metropoli"). Il verbale reso il 10 luglio recita infatti: «ho chiesto di essere interrogato da Lei sulla vicenda Moro e sui 55 giorni, per le ragioni che sono specificamente indicate nel documento che ho redatto insieme a Faranda, che produco». Il documento prodotto era, per l'appunto, la "Premessa".
Il procedimento seguito appare in effetti estremamente tortuoso e lascia molti interrogativi aperti. In particolare non si comprende perché Morucci e Faranda abbiano ritenuto necessario trasmettere al giudice Amato un testo che già da due mesi era agli atti del processo Metropoli. Ancor più irrituale appare la considerazione che il testo sarebbe stato reso pubblico «non appena il G.I Imposimato avrà disposto un atto giuridico di ispezione dei luoghi».
Va pure rilevato che nel periodo compreso tra il 10 luglio (deposito della "Premessa") e il 23 settembre (lettera a Amato) Morucci e Faranda avevano cominciato a rendere al giudice istruttore Imposimato dichiarazioni nel processo Metropoli, depositando agli atti capitoli del "memoriale" in cui ricostruivano la vicenda Moro indicando i brigatisti implicati con un numero.
La "Premessa" si ritroverà poi nel testo complessivo del cosiddetto "memoriale Morucci", datato 1986 e trasmesso alla Presidenza della Repubblica, unitamente ad altra documentazione, nel marzo 1990. Ciò potrebbe indurre a ritenere che la redazione del "memoriale" sia iniziata prima dell'estate 1984, anche se non è dato sapere se, a quella data, era stata redatta la sola "Premessa" o anche una parte, più o meno consistente, del testo.
Tra l'estate e l'autunno del 1984 Morucci, seguito dalla Faranda, sembra aver posto, operando su più tavoli, le basi di una lettura complessiva della vicenda Moro che introduceva significative correzioni alle dichiarazioni dei "pentiti storici" (Peci, Savasta).
In questa complessa dinamica fu decisivo il ruolo di Imposimato sia in quanto giudice istruttore del processo Metropoli e del Moro-ter sia in quanto snodo dei rapporti tra Morucci e ambienti istituzionali e dei Servizi. Lo stesso Imposimato ha rievocato gli inizi della collaborazione nel citato libro - intervista(6), sottolineando che già da alcuni mesi prima delle verbalizzazioni gli avvocati Tommaso Mancini e Edoardo Di Giovanni avevano manifestato la volontà di Morucci e Faranda di «parlare con lei, ma attenzione solo con lei». Non ha tuttavia fatto riferimento al ruolo di Nicolò Amato né a una circolazione di testi. Tornando sul tema il 25 marzo 2015 in sede di audizione della Commissione, Imposimato ha ribadito che «nel 1984 Morucci ha deciso di parlare e di chiamarmi, attraverso l'avvocato Tommaso Mancini, assieme alla Faranda, per descrivere
la dinamica dell'agguato di via Fani. Io sono andato a Rebibbia. Purtroppo, ero vincolato alle richieste fatte da Morucci, nel senso che voleva parlare con me perché Mancini gli aveva detto di parlare con me».
La versione di Morucci presentava, del resto, diversi elementi di appetibilità. Essa proveniva infatti da un personaggio che era stato assai più "interno" al sequestro Moro degli altri pentiti e anche le sue valutazioni induttive - come ad esempio quelle sulla prigione di via Montalcini - si prestavano a un facile uso, quasi sostituendo le mancate dichiarazioni di Moretti e Gallinari.
Non a caso, alle dichiarazioni rese in sede processuale faceva riscontro una certa presenza di Morucci sui giornali. Particolarmente interessante è, sotto questo punto di vista, una intervista rilasciata al "Tempo" il 4 dicembre 1984, nella quale Morucci, dopo aver negato di aver - per allora - dato risposta positiva alla proposta di partecipare alla stesura di una sceneggiatura sulla vicenda Moro, dichiarava che la sua aspettativa rispetto al processo in corso era «che vengano chiariti alcuni punti oscuri. Comunque non esistono misteri, perché tanti particolari erano di una banalità sconcertante. Solo che hanno avuto una rilevante risonanza perché hanno colto tutti impreparati».
Rientra in questo quadro anche il rapporto che si venne a creare, proprio in questo periodo, tra Morucci e Faranda e Maria Fida Moro, che compì una prima visita a Rebibbia il 18 ottobre 1984. Maria Fida Moro precisò in seguito, il 31 ottobre 1990, ai sostituti procuratori Ionta e Palma che «quando mi incontrai con Morucci e Faranda, ciò feci su intermediazione e iniziativa del giudice Imposimato, il quale, nel corso dei tanti atti istruttori, mi disse che Morucci e Faranda avevano manifestato il desiderio di incontrarsi con me, ovvero con uno dei familiari». La stessa dichiarò di «aver letto con sorpresa e raccapriccio una dichiarazione di Imposimato al quotidiano "Il Tempo" nella quale Imposimato, in modo per me del tutto sorprendente, dichiara che l'incontro fu una sua iniziativa e che in particolare per facilitarlo, aveva detto a me che erano i brigatisti a volere l'incontro ed ai brigatisti che ero stata
io o uno dei miei familiari a volere l'incontro stesso». Anche Morucci depose nello stesso senso di fronte a Ionta e Palma il 10 dicembre 1990. Affermò testualmente: «Non fummo noi a chiedere l'incontro con Maria Fida Moro. Fu il giudice Imposimato a dirci che la Moro desiderava incontrarci. Noi non avremmo mai osato avanzare tale richiesta. Quando il giudice Imposimato ci manifestò il desiderio della Moro noi fummo disposti all'incontro e vi acconsentimmo. Meglio vi acconsentii».
Sentito dai Procuratori Ionta e Palma il 5 novembre 1990, Imposimato dichiarò che «a seguito di un interrogatorio del Morucci e della Faranda nell'ambito del proc. "Moro bis" si rappresentò l'esigenza istruttoria di convocare la sen. Moro per il compimento di attività istruttoria. È probabile che in tale occasione dissi alla sen. Moro che Morucci e Faranda avevano manifestato il desiderio di incontrare un membro della famiglia Moro. Inutile dire che tutto ciò che concerneva l'incontro e la sua attuabilità non mi riguardava e non mi riguarda».
Il tema della mancanza di "misteri" nel caso Moro tornò anche alcuni mesi dopo, quando, il 5 marzo 1985, Morucci e Faranda stesero una ampia "memoria difensiva", che contiene una estesa polemica contro gli avvocati di parte civile, accusati di voler denigrare le istituzioni alimentando misteri.
Quattro giorni dopo Morucci tornò a scrivere al direttore del DAP, Nicolò Amato. Nella lettera, che fu acquisita dal SISDE con indicazione «fonte da cautelare in assoluto» (Prot 644/46), Morucci fece un'analisi completa della politica carceraria. Sottolineò come un grande successo il fatto che, dopo la fine dell'esperienza del partito-guerriglia, «il carcere e la detenzione politica sono oggi marginalizzati nell'analisi e nel programma di intervento delle nuove BR "militariste"». Secondo Morucci questo successo dipendeva in larga misura dalla oculata gestione delle carceri speciali, con la «creazione di punti focali di dissociazione dal terrorismo nelle "aree omogenee"». Era però - secondo Morucci - necessario procedere oltre con l'«ulteriore isolamento degli ultimi irriducibili» e stabilire una differenziazione reclusiva tra coloro che avevano manifestato pubblicamente la
dissociazione e coloro che l'avevano praticata solo in una dimensione privata.
Questo programma di "politica carceraria" che Morucci proponeva non andò disgiunto da altri passi compiuti verso il mondo politico.
Solo pochi mesi dopo, l'11 luglio 1985, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Antonio Maccanico, trasmise, su incarico di Cossiga, eletto il 24 giugno dello stesso anno, al Ministro dell'interno Scalfaro «la copia di un pro-memoria, che è stato consegnato di persona dal Presidente al magistrato Ferdinando Imposimato» (lettera del Segretario generale della Presidenza della Repubblica al Ministro dell'interno, 11 luglio 1985, e allegato promemoria, acquisito dalla Commissione Stragi).
Il promemoria segnalava che «attraverso una fonte riservata, una certa suor Teresilla, che afferma assistere i detenuti Morucci e Faranda» aveva trasmesso un messaggio dei due al Presidente Cossiga. Morucci e Faranda «affermano di voler dire la verità sul rapimento a condizione che le notizie non vengano pubblicate».
Il promemoria rilevava che «in passato una richiesta simile fu rivolta - tramite lo stesso Imposimato - » sia a Cossiga, allora Presidente del Senato, sia a Ugo Pecchioli. Cossiga aveva dato la disponibilità a svolgere l'incontro «in una caserma periferica dell'Arma dei Carabinieri o in altra località che l'Autorità Giudiziaria ritenesse idonea», purché l'Autorità giudiziaria lo ritenesse utile e se ne assumesse la responsabilità. Secondo il promemoria, in questa prima occasione la richiesta era stata poi lasciata cadere «valutati i rischi politici in ordine ai procedimenti in corso».
Da questo documento, si evidenzia dunque che già prima del 1985 Morucci e Faranda si erano in qualche modo proposti di fornire all'autorità politica e giudiziaria informazioni di tipo riservato e verosimilmente ancora non emerse in sede processuale, quasi rivendicando una funzione di regia rispetto agli accertamenti sul sequestro Moro. Nulla risulta in atti di ulteriori seguiti di questa prima offerta di Morucci. Il riferimento al fatto che Cossiga fosse Presidente del Senato indurrebbe a collocare il primo contatto dopo l'11 luglio 1983 e prima dell'elezione alla Presidenza della Repubblica del 24 giugno 1985. Il documento fu protocollato solo in entrata, da parte del Ministero dell'interno, al quale la Commissione ha richiesto il 27 ottobre 2017 di trasmettere eventuali seguiti. Allo stato non sono pervenute risposte.
Del promemoria sono state inoltre reperite ulteriori cinque copie non protocollate nell'archivio Cossiga, depositato presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, di cui una con correzioni autografe di Cossiga.
Il promemoria trasmesso al Ministro dell'interno l'11 luglio 1985 nulla dice in ordine all'esito di questo secondo tentativo di Morucci e Faranda di ricercare, per il tramite di suor Teresilla, una interlocuzione diretta col Presidente della Repubblica. Va tuttavia sottolineato che la prima pagina del cosiddetto "memoriale Morucci" trasmesso nel 1990 alla Magistratura reca la scritta «Solo per Lei Signor Presidente...», che è di mano di suor Teresilla Barillà.
La formulazione utilizzata evidenzia un rapporto di fiducia tra la religiosa e il Presidente Cossiga e fa ritenere che la stessa sia stata l'intermediaria principale di un dialogo tra Morucci e Faranda e Cossiga avviatosi non più tardi dell'estate 1985. In questo ambito può anche ritenersi che tra l'estate 1985 (data del promemoria) e il 1986 (data apposta sul "memoriale"), il testo del "memoriale Morucci" sia stato redatto, almeno, nella parte che riguarda la dinamica degli eventi e l'indicazione dei correi.
Il rapporto assai stretto di Cossiga con la suora è ampiamente attestato per un periodo più tardo. Nell'archivio Cossiga sono presenti numerose lettere del periodo 1992-1998, molte delle quali legate alla vicenda del tentativo di concedere la grazia a Curcio, che evidenziano un comune sentire della religiosa e di Cossiga relativamente a una archiviazione del problema del terrorismo, quanto meno di quello di sinistra.
Conclusivamente, dalla lettura del complesso percorso compiuto dalle dichiarazioni di Morucci tra il 1984 e il 1986 si possono formulare le seguenti conclusioni.
Tra il luglio 1983 e l'estate 1985 Morucci tentò, attraverso Imposimato, una prima interlocuzione con l'autorità politica, che apparentemente non si realizzò. Dall'estate del 1984 Morucci e Faranda cominciarono a rendere dichiarazioni al Giudice istruttore Imposimato che, in parte consistente, corrispondono al testo del cosiddetto "memoriale" con la significativa differenza dell'apposizione di numeri al posto dei nomi dei brigatisti. Abbastanza inspiegabilmente, nell'audizione presso la Commissione del 25 marzo 2015, Imposimato, rispondendo a domande sul "memoriale" e sulla collaborazione di Morucci, ha taciuto questi episodi, ma ha osservato che «secondo me, Morucci questa cosa [il "memoriale"] l'ha fatta per dare un segnale al Ministro dell'interno, che poi è diventato Presidente della Repubblica, facendogli credere una cosa diversa da quella che era. Questa è la mia supposizione. Che Morucci fosse bugiardo e da
ritenere poco attendibile è fuori discussione. Io l'ho preso a verbale com'era mio dovere. Dopodiché, non ho potuto fare quelle verifiche che, invece, sarebbe stato giusto fare, poiché me ne sono andato».
Nell'estate 1985, per il tramite di suor Teresilla, fu compiuto un nuovo tentativo di interlocuzione diretta con il solo Cossiga, ormai divenuto Presidente della Repubblica, di cui non si conosce l'esito. Si era ora in una situazione processuale del tutto diversa in cui i «rischi politici in ordine ai procedimenti in corso» non sussistevano più, avendo Morucci e Faranda cominciato da tempo a rendere dichiarazioni. Le stesse dichiarazioni rese al giudice Imposimato e presto diffuse anche sulla stampa, anche tramite interviste, potrebbero aver avuto la funzione di rendere possibile nel 1985 quell'interlocuzione con Cossiga che precedentemente non aveva avuto luogo, eventualmente in una forma scritta e non attraverso un incontro diretto.
Si può conclusivamente ritenere che in questa fase sia stato redatto il cosiddetto "memoriale" comprensivo dei nomi brigatisti e non indirizzato a una sede processuale, ma a una sede politica. Ciò, peraltro, darebbe ragione della nota manoscritta datata 1986 e presente nel testo che divenne noto nel 1990 e - come si vedrà - è in linea con le dichiarazioni rese da suor Teresilla al Pubblico ministero Ionta nel dicembre 1990.
Sembra che proprio in questa fase si sia creato un rapporto di Morucci e - in parte - Faranda col SISDE. Il primo documento reperito è un testo manoscritto, privo di intestazione, che il Centro SISDE di Torino trasmise alla Direzione il 26 aprile 1985, e che potrebbe essere stato carpito in abito carcerario.
Un Promemoria riservato del 3 marzo 1986 per il direttore del SISDE, privo di protocollo, riferiva di un incontro - autorizzato dal giudice Priore - avuto con Morucci e Faranda circa l'interpretazione del "Manifesto e tesi di fondazione" e del volantino dell'Unione comunisti combattenti sull'agguato ad Antonio da Empoli. In quell'occasione i due stilarono «una relazione di loro pugno», nella quale ipotizzarono - sulla base di comparazione con altri scritti - che i documenti fossero stati redatti da «un avvocato che ha avuto fitte esperienze di militanza politica» e espressero l'opinione che l'avvocato in questione si identificasse con Sergio Spazzali. Si evidenziavano inoltre le differenze tra le Brigate rosse e l'UCC, affermando che «la nuova organizzazione, essenzialmente politica e movimentista, è finalizzata ad aprirsi al massimo all'esterno nella continua ricerca di nuovi consensi ed aggregazioni» e che proprio
in ciò «va individuato il punto di maggior debolezza». Una manoscrittura del funzionario Mario Fabbri rivela che il documento fu inviato alla prima divisione «per approfondita analisi d'intesa con la III div».
La documentazione acquisita non consente di capire in quale forma si sia creata questa collaborazione col SISDE. La questione è stata posta a Adriana Faranda nel corso della sua audizione presso la Commissione del 20 settembre 2017. In quell'occasione la Faranda ha osservato che «ci fu un periodo in cui fummo contattati da parecchie persone, poliziotti, carabinieri, Servizi tramite Imposimato, che ci fece incontrare, ma io rifiutai di proseguire il rapporto, per cui non ne so nulla». Rispondendo a una domanda del Presidente ha precisato che Imposimato la mise in contatto «con due... Uno mi disse che aveva fatto la perquisizione a casa mia, quando io ero ricercata. Erano due funzionari del SISDE. Io, però, poi interruppi qualsiasi rapporto». La Faranda ha dato, come si vede, una notizia specifica, che tuttavia pone una serie di ulteriori questioni e suscita molto dubbi rispetto al ruolo di Imposimato e alla natura di
quell'iniziativa.
Dopo questa prima traccia documentale del rapporto con il SISDE, le riflessioni di Morucci sul contrasto al terrorismo, del resto, proseguivano in più direzioni. Il 15 giugno 1986 Morucci indirizzò, dal carcere di Paliano, una lunga lettera a suor Teresilla, che, come si chiarirà, è emersa agli atti solo nel 1990.
Nella lettera Morucci polemizzava con alcune interrogazioni del senatore Flamigni e lamentava un accanimento delle parti civili a mettere in dubbio la sua versione e, in generale, una tendenza cercare misteri, collegando le BR ad altri fenomeni criminali ed espungendole dalla storia della sinistra internazionale. Secondo Morucci, dietro a tali atteggiamenti c'era la volontà di una «sparuta pattuglia di stalinisti nostalgici» di dimostrare che il terrorismo non aveva nulla a che fare con il patrimonio ideologico della sinistra internazionale e di difendere la giustezza della linea della fermezza. Allo stesso modo, Morucci affermava che «tutto ciò non può ovviamente escludere che sul luogo della strage si possano essere recati, per loro conto e per i loro interessi i personaggi più disparati: agenti della CIA, del KGB, del Mossad, ladri, rapinatori, prostitute, lenoni, e financo qualche elemento della
'ndrangheta (e perché non della mafia e della camorra?) che si trovava nei paraggi o ci si è appositamente portato».
L'8 luglio 1986 compare un ulteriore memorandum di Morucci, sempre trasmesso dal Centro SISDE Roma 2 (prot. 644/65), relativo a un elaborato della giornalista Tebi Biondi(7) sulla vicenda Moro, mentre l'11 luglio 1987 Morucci ebbe un «colloquio-intervista» con il vicedirettore del "Popolo", Remigio Cavedon.
Il 24 giugno 1987 il Centro SISDE Roma 2 trasmetteva alla Direzione un nuovo appunto (Prot.:644/85), con allegata «copia di un documento stilato per questo ufficio da Morucci e Faranda di analisi del recente documento a firma di Cassetta e Gallinari ed altri detenuti del G/7 di Rebibbia relativo alla problematica della "liberazione dei detenuti"». Il testo era in effetti un'analisi molto puntuale della posizione di Gallinari, vista in relazione alle posizioni espresse in un documento rinvenuto nel 1984 sul treno Parigi-Venezia. Le riflessioni miravano a tagliare la strada alle UCC (Unioni comuniste combattenti), evidenziando il loro tentativo di «storicizzare la lotta armata per fornirle una copertura a sinistra», con l'obiettivo di «proposizione di sé come soggetto politico e possibile interlocutore, nel caso che l'ennesimo tentativo di ricostruzione di una banda armata fallisca».
Tra il 1986 e il 1987 il rapporto Morucci/SISDE appare dunque continuativo e presenta diversi aspetti di tipo consulenziale, anche in una fase in cui Morucci rendeva dichiarazioni nei processi Metropoli e Moro-ter che apportavano diversi elementi di novità rispetto ai precedenti giudicati penali. Non risulta in atti se di tale rapporto furono in qualche modo informate l'Autorità giudiziaria e l'Autorità politica.
Certo è che nel luglio 1988 una copia del "memoriale" identica a quella che sarà resa nota nel 1990 era già stata acquisita dal SISDE. La nota di trasmissione precisava si trattava di un «elaborato inedito "Abbozzo di una storia: le BR"» di Fenzi e Savasta e del «compendio dei verbali di interrogatorio resi all'A.G. da Valerio Morucci ed Adriana Faranda relativi alla costituzione della colonna romana delle B.R. ed all'attuazione del sequestro Moro con una parte esplicativa postuma [sic!] appositamente redatta dal Morucci che fornisce una lettura più completa e particolareggiata delle suddette vicende. Tali note sono contraddistinte da caratteri stampa in corsivo, e da nomi e circostanze menzionate tra le parentesi».
Anche dal punto di vista grafico e dell'impaginazione non si rilevano differenze rispetto al "memoriale" che circolò nel 1990. Ciò pone, peraltro, la questione di chi materialmente redasse un testo che presenta le caratteristiche esterne di un elaborato dossier, ricco di riferimenti incrociati e dotato di indici e tavole.
Molto significativa è la nota del SISDE: «entrambi i documenti sono inediti e ad esclusivo uso per il Servizio; nell'ipotesi di voler tramitare ad altri organi si prega di voler cautelare al massimo la fonte». Nello specifico non risulta che altri organi siano stati informati dell'esistenza di questi testi. Quello di Fenzi e Savasta, peraltro, era stato pubblicato, con minime varianti e senza indicazione degli autori, nella rivista "Contro le regole di questo assurdo gioco. Bollettino del carcere di Alessandria" (autunno 1983), pp. 15-23. Nella versione a stampa il testo era presentato come una "riflessione comune", redatta però da "uno solo" in una condizione di isolamento.
processuali del Moro-ter. Il processo "Moro-ter" si basava sull'istruttoria condotta dal giudice Priore, completata il 3 agosto 1984, che riguardava tutta la storia della colonna romana delle Brigate rosse. L'istruttoria considerava come già acquisiti gli sviluppi più importanti sul caso Moro e affermava «con ragionevole grado di certezza» che il luogo dove era stato tenuto prigioniero Moro fosse un appartamento di via Montalcini a Roma.
Il dibattimento e l'escussione dei testi cominciò nell'autunno del 1986. Nel frattempo, nell'aprile 1987, Curcio e Moretti, insieme a Jannelli e Bertolazzi, produssero un documento in cui dichiararono conclusa l'esperienza della lotta armata, pur senza per questo sottoscrivere «alcuna abiura o forma di rinnegamento».
Nel maggio 1987 Morucci, che nel processo era imputato solo per banda armata - accertata in Genova in epoca anteriore e successiva al 12 gennaio 1977 -, rese le più significative tra le sue dichiarazioni nelle udienze dibattimentali del 7 maggio e seguenti. La prospettiva era quella consueta. Come Morucci ricordò nell'udienza del 7 maggio, «la mia posizione processuale è la solita assunta nel secondo processo Moro, cioè, sono disponibile a fornire il mio contributo alla Corte per chiarire tutti gli aspetti che può ritenere utili nei limiti dell'ammissione della mia responsabilità e nei limiti del non passato in giudicato per le persone che, eventualmente, dovrei nominare». Fu in questa fase processuale che Morucci rese dichiarazioni importanti, tra cui quelle relative a Lojacono e Casimirri.
Dopo una pausa estiva, il processo riprese il 22 settembre 1987, mentre infuriavano le polemiche sollevate da Flaminio Piccoli a proposito di un possibile filmato delle Brigate rosse sulla prigionia di Moro. Il 12 ottobre 1988 furono depositate le motivazioni della sentenza. Questa segnava alcune importanti novità nella vicenda Moro (Capo XXIV), delle quali almeno due meritano di essere ricordate.
La sentenza affermava in primo luogo che «il nucleo operativo di via Fani è indicato nella sentenza di primo grado in undici persone. Nella sentenza di appello si prospettano dubbi sul numero e sulla composizione del nucleo, sulla base delle dichiarazioni di Morucci e Faranda. Invero, il dubbio va risolto proprio in forza delle accuse o meglio delle chiamate in correità sostanziali elevate da Morucci, nel corso di questo dibattimento, chiamate che sono pienamente attendibili proprio perché tortuose e reticenti. In queste dichiarazioni, si staglia con certezza la partecipazione all'operazione di via Fani di due brigatisti, conosciuti come tali ma non componenti di quel nucleo operativo, e cioè di "Otello" Lojacono e di "Camillo" Casimirri».
La sentenza riconosceva poi che «è una verità processuale quella che lo statista sia stato tenuto in cattività nell'appartamento di via Montalcini n. 8». Anche in questo caso si operava soprattutto su un piano logico-deduttivo. Si trattava, come riportava la sentenza, di «una ricostruzione ex post, sia pure sillogistica, ed è in fondo la ricostruzione che fanno Savasta, Libera, Morucci e Faranda anche attraverso notizie indirette e fatti oggetto di rivelazioni da parte della stessa Braghetti e di altri. Il sillogismo è il seguente: Gallinari e Braghetti convivono dal 1977. Gallinari ed una donna gestiscono la "prigione del popolo"
dove è custodito Moro ed il primo esegue anche la condanna a morte dello statista. Ergo, la casa dove è tenuto in cattività Moro è l'appartamento di via Montalcini, preso in locazione per l'Organizzazione dalla Braghetti, estremamente compartimentato a tutti gli altri brigatisti che ne vengono a conoscenza soltanto dopo la scoperta».
Tale verità processuale rimarrà sostanzialmente invariata, arricchendosi solo di alcuni particolari ulteriori sul "quarto uomo".
Morucci e Faranda si avviavano nel fratttempo a godere dei benefici della legge carceraria. Una nota SISDE del 30 maggio 1988 riferiva che il Ministero di Grazia e giustizia aveva per il momento deciso di non concedere i benefici a causa di possibili rischi per la vita dei due. Si rilevava che «a conferma di ciò sembra che il noto Moretti Mario abbia affermato che ci sarebbero persone interessate a "far fuori i due" che sarebbero depositari di notizie non ancora rivelate alla Magistratura». Si precisava inoltre che «tale ultima possibilità sarebbe stata riferita al Morucci e alla Faranda dalla nota suor Teresa Barillà, la quale, in occasione di una sua recente visita, li avrebbe consigliati, anche dietro esortazione di Piperno, a pazientare».
Anche in assenza di ulteriori riscontri documentali e testimoniali, che gli interessati hanno sempre omesso o rifiutato di dare, si può dunque concludere che il "memoriale", redatto versomilmente tra il 1984 e il 1985, e comunque concluso nel 1986 fu oggetto di circolazione ben prima di quando il Presidente Cossiga lo trasmise al Ministero dell'interno nel 1990. Come si è visto, il SISDE era in possesso di una copia già nel luglio 1988, ma è una copia ulteriore rispetto a quella su cui suor Teresilla appose la nota scritta «Solo per Lei Signor Presidente...» e la data 1986.
Poiché la redazione può essere fissata anteriormente al 1986, chiunque detenne il testo, si assunse una grave responsabilità perché in esso erano contenuti dati e nomi (in particolare quelli di Casimirri e Lojacono) che emersero in sede giudiziaria solo successivamente.
Al di là di questo è la stessa modalità di circolazione del "memoriale" che fa nascere riserve e perplessità. Come si è visto, tra il 1984 e il 1985 furono la stessa suor Teresilla e il giudice Imposimato a far giungere a Cossiga - e nel 1984 anche a Pecchioli - la proposta di una interlocuzione di tipo politico con Morucci su temi che nello stesso periodo erano oggetto dell'istruttoria del Moro-ter.
Ove l'Autorità giudiziaria nel suo complesso non fosse stata informata, ciò sarebbe stato oltremodo grave. Come pure sarebbe grave se l'impianto del processo fosse stato costruito sulla base di un "memoriale" di cui non si palesava l'esistenza, salvo cercarne poi i riscontri.
Molte perplessità suscita anche il rapporto diretto e esclusivo del SISDE - e soprattutto del Centro Roma 2 - con Morucci, tanto più che non risulta che le notizie e i pareri via via acquisiti siano stati trasmessi né alla Polizia né ai Carabinieri né all'Autorità giudiziaria. L'uso, insomma, di Morucci come fonte riservata del Servizio appare in strutturale contrasto con il suo ruolo di imputato-testimone in sede processuale.
Infine anche il ruolo assunto da Morucci nella gestione dell'area omogenea del carcere di Paliano appare particolarmente marcato e suscettibile di creare interferenze, per la concomitanza tra la costruzione giudiziaria del Moro-ter, che vide molti brigatisti variamente dissociati essere chiamati a testimoniare, e la funzione politica di traghettamento verso l'area della dissociazione che Morucci e altri furono incaricati di compiere.
A ben vedere, la pluralità di terreni su cui si giocò il rapporto tra le istituzioni e Morucci costituisce un problema aperto rispetto a tutta la vicenda giudiziaria del caso Moro. Le dichiarazioni processuali di Morucci furono, per quanto possibile, oggetto di riscontri, ma questi risultavano indeboliti dall'esistenza di una complessiva versione, costruita nel dialogo con apparati dello Stato e forse con altri pentiti e dissociati, nel contesto, tutto particolare, del carcere di Paliano. Con la riduzione dell'operazione Moro a un'azione compiuta da una decina di persone, rimasero aperti una serie di interrogativi in relazione alle incongruenze della narrazione, in particolare per quanto riguarda la fuga di via Fani, la presenza di ulteriori brigatisti - analogamente a quanto si accertò per Algranati, Etro e Maccari -, il rapporto tra le Brigate rosse e altri movimenti armati dell'area dell'Autonomia operaia romana, sia in corso di
sequestro Moro che successivamente, l'ampiezza dell'area di contiguità. Ne è derivata una ricostruzione parziale, anche rispetto alle posizioni processuali di singoli che, come Valerio Morucci o Germano Maccari, svolsero una consistente attività criminale nell'ambito di Potere operaio che è rimasta sostanzialmente oscura, nonostante le indicazioni fornite da pentiti come Di Cera o Savasta.
6.5. La diffusione del "memoriale"
Il compendio delle dichiarazioni di Morucci - non è dato sapere quanto condiviso dalla Faranda - si manifestò nella sua forma, per così dire, pubblica e definitiva, solo nella primavera del 1990.
Secondo quanto attestato dagli Uffici del Quirinale, il "memoriale Morucci" fu trasmesso al Presidente Cossiga in data 13 marzo 1990 da suor Teresilla per il tramite di Remigio Cavedon. La Presidenza della Repubblica, circa un mese dopo, trasmise - il 26 aprile 1990 - il testo al Ministero dell'interno.
In realtà, l'appunto predisposto per il Ministro dell'interno il 2 giugno 1990 riferiva più precisamente che «il Segretario generale della Presidenza della Repubblica ha di recente inviato 6 documenti relativi a fatti concernenti il sequestro e l'omicidio dell'On. Moro». I 6 documenti evidentemente non erano tra loro coevi. Si trattava infatti di: «"memoria difensiva di Morucci e Faranda" (1985); corrispondenza riservata Morucci Faranda - Sig. Ricci Leonardi - Azzolini - Franceschini. Relazione Convegno volontariato di Lucca; lettera Morucci al dr. Cavedon - riflessione di Morucci; risposta interrogazione On.le Flamigni - Morucci. Commento del prof. Fenzi al film "Il caso Moro" già pubblicato sul Popolo; On.le Flaminio Piccoli - domande e risposte di Morucci e Faranda; dichiarazioni di Morucci e Faranda». Solo l'ultimo è il cosiddetto "Memoriale".
Nel complesso, si trattava dunque di una raccolta alquanto eterogenea di materiali unificati dal fatto di avere a che fare con l'operazione realizzata dalla da alcuni brigatisti - in primo luogo Morucci - alla metà degli anni '80. Erano dunque testi alquanto "datati" rispetto alle più recenti acquisizioni giudiziarie, ma che in qualche modo le prefiguravano.
Il contesto in cui sarebbe avvenuta questa trasmissione (marzo - aprile 1990) era caratterizzato dall'emergere di nuovi elementi e polemiche sulla vicenda Moro. In agosto, il Presidente del Consiglio Andreotti rese nota l'esistenza di Gladio al Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Successivamente, il 9 ottobre 1990, avvenne la seconda scoperta di documentazione di Moro del covo di via Monte Nevoso.
Al di là del contesto politico generale, nel quale si avvertivano crescenti attenzioni attorno figura del Presidente della Repubblica, si era in una avanzata fase istruttoria del processo Moro-quater. Il 29 marzo, ovvero circa quindici giorni dopo l'asserito invio a Cossiga del "memoriale", il SISDE acquisiva una lettera di Morucci e Savasta al direttore degli istituti di prevenzione e pena, Amato, nella quale lamentavano che non erano stati loro concessi i benefici del lavoro esterno e della semilibertà. Nel perdurare di questa situazione i due dichiaravano che avrebbero preso una serie di iniziative, tra le quali «quella di non rispondere ulteriormente alle domande che qualsiasi magistrato vorrà porci, in sede dibattimentale e non». La scelta era anche «giustificata dalla constatazione che le nostre testimonianze, cioè la nostra collaborazione processuale, possono essere utilizzate - come nella
recente trasmissione "La notte della Repubblica" - quale elemento spettacolare in accompagnamento a immagini cinematografiche ad effetto». Alla richiesta seguì un incontro con il dottor Amato che - secondo un appunto SISDE del 7 giugno 1990 - avrebbe dichiarato la sua intenzione di «costituire una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per territorio, dall'Ispettore e dal Direttore del carcere per stabilire criteri obiettivi ed univoci per quanto riguarda la concessione della semilibertà e più in generale di altri benefici di legge». Con lettera del 21 giugno 1990 l'Opera Don Calabria comunicò la disponibilità a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con Morucci e Faranda che, il 30 settembre, ottennero la semilibertà.
Il 20 agosto il giudice Priore aveva depositato la sentenza istruttoria del processo Moro-quater, che valorizzava particolarmente il contributo ricostruttivo di Morucci. Si sottolineava infatti, già nell'esordio, che «con la documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno pervenuta agli atti il 7 giugno u.s. - documentazione di sicura mano dei noti Morucci Valerio e Faranda Adriana - si ricostruisce con completezza ed organicità l'intera vicenda del sequestro e dell'assassinio dell'onorevole Moro. Completezza ed organicità perché i due diretti protagonisti degli eventi, ne ripercorrono con rigore cronologico e logico la sequenza e riempiono quei vuoti che ancora rimanevano nei loro interrogatori resi a questo Giudice Istruttore nel processo contro Piperno e Pace cd Metropoli, e alle Corti nei dibattimenti del cd. Moro-ter e dello stesso processo Metropoli».
Anche questa ulteriore fase di circolazione del "memoriale" si intrecciò con le vicende giudiziarie (processo Moro-quater) e con l'attività di Morucci per i Servizi.
Il 27 giugno 1989 il Centro SISDE Roma 2 trasmetteva (Prot.234/137) una nuova «schematica analisi del documento "Per il Partito - Cellula per la costituzione del P.C.C" redatta da Valerio Morucci e Adriana Faranda», documento nel quale si formulavano una serie di ipotesi sui possibili redattori e sulle caratteristiche della "Cellula".
Risale invece al 4 settembre 1990 una lunga e analitica nota sulla "Cellula per la costituzione del Partito comunista combattente" che Morucci redasse per il Centro SISDE Roma 2 (Prot. 243/169), nella quale lo stesso Morucci avanzava l'ipotesi che la Cellula potesse aver creato le condizioni per una prossima operatività armata.
Ancora più importante è un successivo memorandum che Morucci stese per il SISDE il 3 novembre 1990, relativo al secondo ritrovamento delle carte di Moro in via Monte Nevoso, avvenuto il 9 ottobre 1990. In questo testo molto articolato, Morucci affermò tra l'altro che le lettere di Moro date a Morucci e Faranda erano circa 36 e che le altre non spedite furono trattenute senza che Morucci e Faranda ne fossero a conoscenza. Precisò inoltre che era il solo Moretti a decidere quali lettere recapitare. Infatti, poiché le riunioni del Comitato esecutivo avvenivano settimanalmente, era improbabile che fosse in quella sede che si decidesse quali lettere recapitare.
Morucci scrisse inoltre di non essere sicuro che Gallinari avesse distrutto gli originali delle lettere e che solo Moretti, Azzolini, Bonisoli e Micaletto potevano avere una simile notizia.
Morucci affermava infine di non vedere ragioni per distruggere gli originali del memoriale Moro. Ipotizzava che gli originali stessi fossero nella disponibilità di Moretti o, più probabilmente, di Micaletto, che "governava" sia la colonna genovese che quella torinese. Ciò anche perché la Liguria costituiva per le BR un retroterra sicuro.
Va segnalato che il SISDE compì analoghi sondaggi con Patrizio Peci, come segnalato da una comunicazione del Centro SISDE di Torino del 13 novembre 1990 (Prot.:3. D. 48/3203). Peci non redasse però un elaborato, ma si limitò a sottolineare che il materiale documentario di via Monte Nevoso avrebbe dovuto servire a una pubblicazione, a cui dovevano partecipare anche Toni Negri, Oreste Scalzone e Pancrazio Epifani, e che l'occultamento di materiali e armi nel pannello era una pratica consueta e ragionevole.
L'importanza delle osservazioni di Morucci, sia pur presentate come mere riflessioni, è notevole ed esse avrebbero potuto essere oggetto di approfondimenti di indagine, che non sembra siano stati svolti. Esse appaiono peraltro coerenti con le indagini che la Commissione ha condotto sulla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia e della possibile presenza di documentazione riconducibile a Moro.
Una reale attività accertativa sul "memoriale Morucci" non avvenne nell'ambito dei processi Moro, ma in un procedimento che si sviluppò a latere di questi, a seguito di una serie di esposti presentati all'Autorità giudiziaria da Teresa Pasquali Carlizzi, un'assistente volontaria e animatrice di un'associazione che, nel corso dell'autunno 1990, denunciò - su basi estremamente fragili di cui fu dimostrata l'inconsistenza - una serie di attività depistatorie che avrebbero coinvolto, insieme a Morucci, una serie di esponenti socialisti e democristiani, nonché sur Teresilla Barillà..
Proprio sulla base di tali esposti, il 17 novembre 1990 la DIGOS perquisì l'alloggio di suor Teresilla. In quell'occasione, come riportato dalla relazione della dottoressa Cavallo, la suora consegnò «in un atto di spontanea liberalità e per motivi di studio» copia del Memoriale. La relazione precisa inoltre che la suora «conserva, dello stesso volume, altre due copie, di cui una in corso di elaborazione critica da parte della stessa religiosa».
All'esito della perquisizione la DIGOS segnalò che «il volume di cui sopra è copia di quello indirizzato dal Sig. Presidente della Repubblica al Sig. Ministro dell'Interno» e che «nell'elaborato sono comprese le copie di 23 lettere dell'On.le Moro: di queste, 20 erano già note, 3, indirizzate alla famiglia, non risultavano in precedenza acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ma sono state ritrovate in via Monte Nevoso nell'ottobre scorso». L'appunto proseguiva sottolineando che «l'utilizzazione delle medesime [lettere] per la compilazione del volume (avvenuta verosimilmente tra il 1984 ed il 1986)» induceva a ipotizzare o che Morucci avesse avuto accesso a materiali nascosti in corso di sequestro Moro o che copia delle lettere gli fosse stata data da suor Teresilla, da Maria Fida Moro o da Remigio Cavedon.
Si tornava inoltre sulla datazione "1986" osservando che, a quella data, i nomi di Casimirri e Lojacono non erano emersi e si segnalava infine che «il G.I. Rosario Priore, durante un colloquio informale, è apparso consapevole dei diversi aspetti della vicenda appena descritta».
Il 5 dicembre 1990 un ulteriore appunto al Ministro dell'interno (Prot.90/1594/04/3039) sottolineava che ulteriori accertamenti avevano evidenziato che gli scritti di Moro erano già noti e che «in particolare le lettere in argomento sarebbero effettivamente pervenute ai familiari dell'On. Moro, i quali non le avrebbero rese pubbliche, d'intesa con la magistratura».
Suor Teresilla fu sentita in proposito dai Pubblici ministeri Ionta e Palma il 10 dicembre 1990. Le sue dichiarazioni sono molto brevi: «confermo che l'elaborato da me consegnato spontaneamente alla Digos in corso di perquisizione venne redatto da Morucci Valerio e da questi a me trasmesso in tre copie per mia conoscenza personale. Devo dire che una di queste tre copie è stata da me inviata al Presidente della Repubblica qualche mese fa, comunque in quest'anno. Riconosco come mia la grafia di cui all'appunto allegato alla nota del P.M. Ionta in data 7-6-1990 e preciso che la data 1986 fa riferimento alla data di redazione dell'elaborato e non di trasmissione dello stesso al Presidente della Repubblica. Aggiungo che la terza copia dell'elaborato è in mio possesso. L'iniziativa di trasmettere l'elaborato al Presidente della Repubblica, cosa che è avvenuta tramite Remigio Cavedon, è stata esclusivamente mia». Non
risulta che i Pubblici ministeri abbiano domandato alla Barillà se tra il 1986 e il 1990 il testo circolò, come lo ebbe, e per quale motivo decise di inviarlo al Presidente Cossiga.
Morucci fu pure sentito dai Pubblici ministeri Ionta e Palma il 13 ottobre e il 10 dicembre 1990. In questa seconda occasione, Morucci dichiarò «Prendo visione dell'elaborato consegnato da Barillà Chiara [...] in data 13 dicembre 1990 ed al riguardo posso dire che alcune parti possono essere state redatte da me, ma non ricordo di aver steso l'intero elaborato. In ciò insisto, salva lettura integrale, anche dopo aver appreso che la Barillà ha dichiarato che il detto elaborato è stato da me redatto».
Per quanto attiene alle lettere Morucci disse che «tali lettere sono state probabilmente tratte dal libro curato dal figlio di Moro (ed. Longanesi) e che comunque tutte le lettere riportate o sono tratte dal libro del figlio di Moro ovvero dal libro del figlio [sic!] di Bocca. Quando redassi l'elaborato non feci fare alcuna ricerca di archivio degli atti processuali ed utilizzai atti giudiziari in mio possesso ovvero libri editi ovvero articoli di stampa». Il riferimento di Morucci non appare in effetti molto perspicuo. Si può ritenere che egli facesse riferimento al volume, edito dalla Fondazione Moro, L'intelligenza e gli avvenimenti: testi 1959-1978 (Milano, 1980).
In quell'occasione Morucci chiarì anche che l'incontro con Maria Fida Moro gli fu proposto da Imposimato, e non fu da lui richiesto. Svolse anche una serie di ragionamenti sulle carte di Moro, che solo in parte si sovrappongono all'appunto del SISDE. Ipotizzò in particolare che «gli originali al momento del sequestro in via Monte Nevoso nel 1978 fossero nella disponibilità degli altri membri dell'Esecutivo cioè Micaletto e/o Moretti e/o Gallinari».
Secondo una nota del dottor De Cristofaro al dirigente della DIGOS del 13 ottobre 1990 Morucci avrebbe inoltre espresso al personale di Polizia incaricato di portarlo dal magistrato perplessità sul ritrovamento di via Monte Nevoso di documenti dietro a un pannello. Infatti «a suo dire l'organizzazione ricorreva a tale mezzo [il pannello] solo per gli "irregolari" che, vivendo in famiglia o nelle proprie case dovevano tutelarsi. In via Monte Nevoso, la più importante "base" della organizzazione BR e sede di "clandestini" dello spessore di Bonisoli ed Azzolini, non vi era motivo di ricorrere a tale "precauzione"».
Gli accertamenti condotti sugli esposti della Pasquali Carlizzi indussero il Procuratore Giudiceandrea a disporre la formazione di un autonomo fascicolo processuale, stralciato dal procedimento 3349/90, «ritenuto che gli accertamenti relativi a tali dichiarazioni, pur attinenti la vicenda in esame, possono essere trattati separatamente anche per motivi di speditezza processuale». In questo modo, l'accertamento della natura, finalità e circolazione del "memoriale Morucci" uscì, definitivamente, dai Processi Moro per divenire oggetto di un procedimento "minore" che si concluse l'8 giugno 1992, con l'assoluzione della Pasquali Carlizzi per il reato di calunnia in danno di Chiara Barillà e di Bettino Craxi.
Nell'ambito del procedimento le vicende del "memoriale" furono nuovamente approfondite, senza pervenire a conclusioni certe. Nell'udienza dibattimentale del 2 ottobre 1991 suor Teresilla fornì una serie di ulteriori indicazioni sul Memoriale, che non offrono tuttavia risposte puntuali.
Per quanto attiene alla datazione della redazione e della consegna, la religiosa modificò la sua versione, precisando che il testo le era stato dato «verso la fine dell'88» e che «la data d'inizio [è] tra l'86 e l'87». La Barillà precisò inoltre che nessuno era a conoscenza del fatto che lei possedeva il testo e che lei stessa scrisse la manoscrittura «Solo per lei, Signor Presidente» e «la data ho messo '86 perché praticamente...era l'inizio del lavoro». Dalle dichiarazioni emerge che la suora aveva un'idea molto vaga dei contenuti. Prima affermò che «a mio avviso devono essere gli atti del processo, del Moro, Moro-bis, dove Morucci è stato già processato», poi, dopo una contestazione, dichiarò che non sapeva se realmente si trattasse solo di atti processuali.
Anche la circolazione del testo appare a dir poco confusa. La Barillà dichiarò che una copia era stata inviata a Cossiga, una era stata presa dalla DIGOS, la terza «praticamente è in mio possesso». A fronte di una contestazione del Presidente, la suora fu poi indotta a precisare che la copia era stata inviata al giudice Spataro e si impegnò a recuperarla.
In effetti, con una comunicazione al Presidente del Tribunale dell'11 ottobre 1991, acquisita agli atti del processo, Spataro confermò di aver ricevuto il testo. Questo gli fu consegnato in quanto Morucci desiderava pubblicare il volume con una introduzione del magistrato, in quanto esperto di terrorismo, ma non titolare di indagini sul caso Moro. Spataro precisò anche che - secondo quanto da lui appreso - Cavedon si stava occupando dei contatti con le case editrici. Spataro riferì di aver manifestato perplessità, legate soprattutto alla mancanza di tempo e al non aver avuto tempo di leggere il testo.
Nonostante l'impegno del Presidente del Collegio giudicante, la testimonianza rimaneva vaga, specialmente sul tema della circolazione del testo. La Barillà, nell'evocare i suoi rapporti con Piccoli e Scalfaro, si preoccupò di chiarire - non richiesta - che «non faccio da tramite tra la Democrazia cristiana e i detenuti», ma poi evocò una serie di sue iniziative a favore di detenuti basate sulla ricerca di appoggi o comprensione nel mondo politico.
Il successivo interrogatorio di Morucci, avvenuto lo stesso 2 ottobre 1991, non portò maggiore chiarezza, se non sulla questione delle lettere e dei rapporti con la Pasquali Carlizzi. Morucci affermò che «l'idea, o meglio l'urgenza di raccogliere questo materiale sia della fine dell'86», ma che la redazione «credo che slitti nell'87». L'ultimo file del testo sarebbe - secondo Morucci - del gennaio 1988, ma, anche dopo questa data, Morucci sarebbe tornato a intervenire sulle tavole e l'indice. Secondo Morucci il testo sarebbe stato redatto per una finalità essenzialmente privata, per rispondere alle ricorrenti polemiche sul sequestro Moro. Quanto alla questione di una precoce indicazione di Casimirri e Lojacono, Morucci puntualizzò che «poi questa indicazione fu fatta da me al giudice Ionta nella primavera dell'88, quindi in epoca immediatamente successiva, se non addirittura coincidente
con la stampa definitiva della raccolta» e che «in quanto dissociato non ero tenuto per legge ad indicare i nomi dei correi. Questo non mi impediva di scrivere questi nomi da qualsiasi parte». Morucci dichiarò poi di non ricordare quante copie ne avesse stampate e di averne date dalla Barillà nella consapevolezza che si trattava di materiale non particolarmente interessante e comunque ignorando eventuali conoscenze della suora.
Nel complesso le dichiarazioni dibattimentali, alle quali poco aggiunsero quelle dei funzionari della DIGOS, di Cianfanelli e della Pasquali Carlizzi, confermano l'opacità del testo e, soprattutto, delle interlocuzioni ad esso sottostanti. Elemento del resto difficile da cogliere in una sede giudiziaria peraltro assai tardiva rispetto alla elaborazione e circolazione del testo.
Il nodo, in effetti, era politico, in senso lato. Quali che fossero state le finalità originarie della redazione - e su questo tanto Morucci che la Barillà offrirono indicazioni vaghe - esso si collocava in un contesto che gli interessati si guardarono bene dal richiamare: quello dei tentativi di interloquire col Presidente Cossiga, con parti del mondo politico e col SISDE, sin dal 1984/1985, e di costruire, nelle dichiarazioni a Imposimato, un preciso perimetro politico-giudiziario entro il quale si sarebbe dovuta muovere la ricostruzione della vicenda Moro. Il tutto nel quadro dell'elaborazione della legge sulla dissociazione che avrebbe in qualche modo "canonizzato" una posizione garantita, nella quale Morucci e gli altri dissociati potevano rilasciare, nei modi e tempi da loro ritenuti congrui, elementi testimoniali.
Anche in seguito Morucci mantenne un atteggiamento omissivo rispetto al "memoriale". Il tema della paternità tornò infatti in discussione nel processo Moro-quater. In quell'occasione Morucci fu sentito anche in dibattimento come imputato di reato connesso e già giudicato. Il 10 aprile 1992 iniziò la sua testimonianza con un lungo discorso nel quale lamentò una presunta ostilità dell'opinione pubblica nei suoi confronti e affermò la necessità di passare a una valutazione storico-politica delle vicende del terrorismo. Conseguentemente, si dichiarò «disponibile ad un discorso di ricostruzione generale, sebbene sarebbe l'ennesimo, dal punto di vista dello sviluppo storico e politico degli avvenimenti», ma affermò di volersi avvalere della facoltà di non rispondere «a qualsiasi domanda relativa a fatti specifici o a persone specifiche». Per
maggior chiarimento il Presidente rilevò che «se noi le domandassimo notizie relative al cosiddetto memoriale, che è agli atti del processo, lei non risponderebbe», ottenendo conferma in questo senso da Morucci.
Il tema tornò poi nel corso del dibattimento, dopo una serie di affermazioni di Morucci sul carattere "nazionale" delle Brigate rosse. Il 14 aprile 1992 il Pubblico ministero tornò sul tema, domandando: «questa raccolta, di dati giudiziari, di cui lei già ha fatto cenno. Quando è iniziata e quando è terminata? E che scopo si prefiggeva?». Anche in questo caso Morucci scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Il tema tornò ancora nell'udienza del 25 ottobre 1993. In quest'occasione il Pubblico Ministero evidenziò tutte le incongruenze di quel modo di procedere. Rilevò che «le dichiarazioni, come Lei ricorderà, rese davanti al G.I. sono del 1988; mentre noi abbiamo acquisito a questo processo un memoriale che porta la data 1986 e fino a quando qualcuno non mi avrà spiegato che cosa significa quella data, fino a quando qualcuno non mi avrà spiegato cosa significa quell'intestazione scritta, a mano "solo per Lei, signor Presidente, soltanto che qui ci sono i nomi... Roma... 1986, io sono autorizzato a pensare che quel memoriale è stato scritto nel 1986". [...] Ebbene io credevo e credo ancora di avere il diritto di sapere da Morucci innanzitutto se conferma quel memoriale e poi credo ancora di aver il diritto di sapere come si è arrivati a quel memoriale». Anche in questo caso Morucci non
rispose, dichiarando di essere disponibile solo a confrontarsi sulle perizie relative alla strage di via Fani. Dopo una lunga ricostruzione di Morucci, priva peraltro di elementi di novità, il Pubblico Ministero prese atto dell'indisponibilità, rilevando di nuovo la stranezza di dichiarazioni rese al Giudice istruttore o condensate nel "memoriale", ma non confermate in dibattimento.
Anche in seguito Morucci non ha mai deviato da questa linea di opacità. Nell'audizione alla Commissione Stragi del 18 giugno 1997 la questione gli fu posta dal senatore Guido Calvi, che gli chiese se riconosceva la paternità del "memoriale" e se altri parteciparono alla stesura. In quell'occasione Morucci, dopo aver riconosciuto di aver scritto alcune parti, indicò la Faranda come coautrice e affermò: «Nel carcere di Paliano non vedo chi altri poteva collaborare».
Naturalmente, la questione della paternità e della datazione del "memoriale" è rilevante, oltre che per una ricostruzione di una duratura interlocuzione di Morucci con soggetti istituzionali, anche per alcuni specifici elementi emersi in sede processuale.
Come segnalò già nel 1990 un appunto della Polizia, il riconoscimento della responsabilità di Casimirri e Lojacono nel sequestro Moro emerse solo nel 1988. Di conseguenza, se la partecipazione dei due brigatisti al sequestro Moro era stata palesata nel "memoriale" redatto nel 1986, i soggetti che conservarono il testo si assunsero una grave responsabilità anche su un piano penale. In questo ambito, lascia molti dubbi l'assunzione, sostanzialmente data per implicita nei due ultimi processi Moro, che il "memoriale" sia stato redatto successivamente alle dichiarazioni di Morucci nel Moro-ter. Alla luce delle dichiarazioni degli interessati e, soprattutto, dei contatti con Cossiga del 1984/1985 e del reperimento di una copia del 1988 negli atti del SISDE, tale assunto non appare affatto pacifico.
Va inoltre segnalato che il disconoscimento, da parte di Morucci, di una sua paternità del "memoriale" appare verosimile alla luce della caratteristiche formali e di contenuto del "memoriale". Questo presenta tutte le caratteristiche formali e compositive di un elaborato interno agli apparati di sicurezza, che dunque non possono essere a priori ritenuti estranei alla composizione del testo. Anche l'uso del temine "riservato" apposto in calce alla frase "Solo per Lei Signor Presidente..." sembra rimandare più a un'elaborazione collettiva a cui parteciparono apparati che non alla stesura di un singolo.
6.6. Conclusione
La costruzione della verità giudiziaria sulla vicenda Moro appare dunque legata all'azione di una pluralità di soggetti, che operarono attorno al percorso dissociativo di Morucci: i giudici istruttori Imposimato e Priore, il SISDE, alcune figure di rilievo della politica e delle istituzioni, suor Teresilla Barillà.
L'esito giudiziario realizzatosi nel Moro-ter, che ebbe importanza decisiva ai fini della ricostruzione della vicenda Moro, appare fortemente condizionato dalle vicende del "memoriale" e dall'aprirsi di uno spazio di dialogo tra Morucci e le istituzioni.
L'esistenza di tale spazio, di per sé, non implica che le dichiarazioni processuali di Morucci siano viziate. È però innegabile che, con il concorso di forze diverse, si venne a creare una posizione processuale particolarmente garantita, nella quale il ruolo testimoniale scoloriva in una più ampia e opaca funzione consulenziale del Morucci, quasi realizzando concretamente una trattativa che veniva pubblicamente negata.
In tale contesto diversi particolari e incongruenze della ricostruzione di Morucci e Faranda furono tralasciate, privilegiando la coerenza complessiva di una ricostruzione che isolava il terrorismo delle Brigate rosse dai più ampi fenomeni di estremismo politico armato, in controtendenza con le ipotesi ricostruttive che erano state affermate dal generale Dalla Chiesa e dai magistrati nella prima fase processuale, dal 1979 al 1984. Non a caso l'ampia memorialistica dei brigatisti non pentiti che si diffuse a partire dal noto libro - intervista di Moretti del 1994 poté appoggiarsi agevolmente sulla ricostruzione di Morucci, senza nemmeno porsi il problema di confermarne i contenuti in sede giudiziaria.
Le acquisizioni di indagine che dimostrano le incongruenze della ricostruzione di Morucci su punti non secondari, come l'abbandono delle macchine dopo la strage di via Fani, i contatti con forze politiche e familiari di Moro, la circolazione di scritti di Moro e la loro scomparsa, nonché il progressivo emergere di persone, come Germano Maccari, Raimondo Etro e Rita Algranati, di cui solo molto tardivamente si poté dimostrare una partecipazione alla vicenda Moro, evidenziano che in questa sorta di negoziato politico-giudiziario molti elementi furono espunti dalla ricostruzione della vicenda Moro, pagando un prezzo evidentemente eccessivo.
Nel corso dei lavori della Commissione e nelle precedenti relazioni si è fatto riferimento al concetto di "verità dicibile", a proposito del "memoriale Morucci" e più in generale del quadro emerso in sede giudiziaria nel corso degli anni '80. L'analisi, su base documentale, delle vicende del "memoriale" e dei percorsi dissociativi qui richiamati consente di individuare con più precisione gli attori politici e giudiziari che, nel corso degli anni '80, realizzarono questo processo di stabilizzazione di una "verità parziale" sul caso Moro, funzionale a una operazione di chiusura della stagione del terrorismo che ne espungesse gli aspetti più controversi, dalle responsabilità di singoli appartenenti a partiti e movimenti, al ruolo di quell'ampio partito armato, ben radicato nell'estremismo politico, di cui le Brigate rosse costituirono una delle espressioni più significative, ma non certo
l'unica.
7. Il sequestro Moro, le Brigate rosse, i palestinesi
Già nella precedente relazione si è dato estesamente conto delle interlocuzioni tra gli apparati di sicurezza italiani e alcune organizzazioni palestinesi, principalmente OLP e FPLP, finalizzati a individuare una possibilità di salvare la vita di Moro. Si è, allo stesso tempo, illustrata la documentazione che evidenzia rapporti dei movimenti palestinesi con aree del partito armato italiano vicine alle Brigate rosse o con le stesse Brigate rosse.
Già in quella sede, le iniziative assunte nel corso del sequestro Moro sono state analizzate nel quadro degli accordi politici e di intelligence che l'Italia aveva stabilito con le principali formazioni palestinesi sin dal 1973, e che sono emersi in più inchieste giudiziarie e parlamentari.
Si è infatti valutato che le segnalazioni pervenute nel febbraio 1978 e la trattativa che si cercò di intavolare per il tramite dei movimenti palestinesi risultarono fortemente condizionate da questa dimensione di rapporti internazionali, delicata al punto che fu spesso pubblicamente negata o ridimensionata.
Gli ulteriori approfondimenti compiuti si sono indirizzati soprattutto in due direzioni. Si è in primo luogo indagato, anche con l'acquisizione presso l'AISE di una cospicua documentazione classificata, il tema degli accordi italo-palestinesi, con relazione alla vicenda Moro. Secondariamente, si è approfondita la documentazione di intelligence utile a precisare le scansioni temporali dei rapporti tra formazioni palestinesi e Brigate rosse.
La documentazione acquisita evidenzia una costante interlocuzione tra i Servizi italiani e i Servizi dell'OLP e, in parte, del FPLP, sia in relazione alla vigilanza su arabi e palestinesi ritenuti attivi in formazioni terroristiche, sia anche in relazione all'acquisizione di informazioni e notizie.
Ciò, peraltro, è stato confermato dal colonnello Armando Sportelli, che fu addetto militare a Beirut dal 1975 al 1977 - con responsabilità anche per Siria e Irak - e poi capo dell'Ufficio "R" del SISMI dal 1979 al 1984. Audito dalla Commissione il 16 maggio 2017, Sportelli ha inquadrato i rapporti con i palestinesi nell'ambito di un'azione di intelligence che si rivolgeva a una pluralità di servizi collegati, compresi quelli palestinesi a quelli israeliani.
In questo contesto si collocavano anche i rapporti con il Fronte popolare per la liberazione della Palestina di George Habash, che Sportelli ha definito come «un cristiano» che «aveva con noi parecchie relazioni», nonostante questo movimento fosse ritenuto estremista e fortemente implicato in azioni terroristiche. Sportelli ha precisato che gli accordi comprendevano anche il Fronte popolare, in quanto «Arafat in un certo senso all'estero rappresentava tutte le correnti palestinesi. Quindi, se parlava di salvaguardare il territorio italiano da attentati, nella sua idea c'era anche quella di salvaguardare da attentati voluti dal Fronte popolare di Habash».
Il tema è stato approfondito anche nell'audizione, svolta il 26 giugno 2017, di Bassam Abu Sharif, personalità di notevole rilievo della politica palestinese sin dagli anni '70. Sharif fu un esponente importante del Fronte popolare per la liberazione della Palestina - organizzazione marxista guidata da George Habash - e già negli anni '70 e partecipò a diverse azioni antiisraeliane, subendo anche un attentato. Si avvicinò in seguito ad Arafat e divenne suo consigliere sfumando l'originaria impronta marxista delle sue posizioni.
Sharif ha fornito numerose indicazioni sul concreto funzionamento degli accordi italo-palestinesi. Ha in particolare affermato che era presente quando fu redatto un preciso impegno scritto del Fronte popolare per la liberazione della Palestina che fu dato al colonnello Giovannone. L'impegno del Fronte era quello di «non compiere nessuna azione che potesse minacciare la sicurezza degli italiani, dell'Italia o del suolo italiano da parte del Fronte popolare». Era prevista, correlativamente, una «collaborazione con l'Italia in tutto quello che riguarda l'Italia e la sua sicurezza» e un generale sostegno dell'Italia alla causa palestinese.
Le considerazioni di Sharif sembrano fare riferimento a un impegno del FPLP di cui esistono anche altre attestazioni in atti. Ad esempio in un documento SISMI del 1981, redatto in relazione alla nota vicenda dei "missili di Ortona" e già acquisito dalla Commissione Mitrokhin, si faceva riferimento al fatto che il FPLP avrebbe potuto interpretare negativamente la mancata scarcerazione di Abu Anzeh Saleh e che «non si dovrebbe più fare affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e contro interessi e cittadini italiani decisa dal FPLP nel 1973».
In questo ambito Sharif ha anche alluso al fatto che «alcuni giornalisti italiani progressisti hanno avuto un ruolo per «ammorbidire» questo processo di collaborazione tra l'Italia e le fazioni palestinesi, in particolare il FPLP». Il particolare è in realtà più specifico di quello che può apparire a una prima lettura e conferisce ulteriore verosimiglianza al racconto di Sharif. Con ogni evidenza si tratta infatti di un riferimento a Rita Porena, di cui sono stati da tempo approfonditi in sede giudiziaria i rapporti con Sharif e con il FPLP e il ruolo di tramite tra i palestinesi e il colonnello Giovannone. La Porena, che fu a Beirut dal 1971 al 1977 e poi dal 1979 al 1986, è stata escussa da collaboratori della Commissione il 21 maggio 2017. Oltre a confermare i rapporti con Giovannone e la stretta vicinanza a Sharif, ha detto di «non poter escludere» che lo stesso Sharif abbia dato
notizie preventive a Giovannone su attentati in Italia e di presumere un interessamento dell'OLP nel corso del sequestro.
Oltre a riconfermare l'impegno, dispiegato nel corso del sequestro Moro, per contribuire a produrre una soluzione positiva, Sharif si è a lungo diffuso sui rapporti tra i movimenti palestinesi e le Brigate rosse, che del resto sono ampiamente documentati in atti per il periodo 1979-1980. Mentre ha rivendicato il solido rapporto di amicizia tra palestinesi e governo italiano, cementato soprattutto dall'azione del Capocentro SISMI di Beirut, colonnello Stefano Giovannone, Sharif ha insistito molto sul fatto che il Fronte popolare, pur essendo di tendenza marxista, non considerava affidabili le Brigate rosse.
Sharif ha affermato testualmente: «Parlano di Brigate rosse e così via, ma personalmente ritengo che dopo l'arresto dei capi delle Brigate rosse, in Italia la maggior parte delle BR fosse infiltrata da agenti americani o Gladio della NATO, ad eccezione di alcune persone che erano ingenue e convinte di essere BR».
Ha inoltre aggiunto: «Il dottor Habash spiegò a Giovannone che non c'era alcun rapporto (anche un anno prima di quella data(8)) con le BR, e in quella sede mise in guardia Giovannone da quella generazione di leader delle Brigate rosse che era infiltrata».
Sharif ha sottolineato un punto importante, che viene talora trascurato: l'esistenza di rapporti di tipo operativo tra il Fronte e i movimenti terroristici europei di sinistra non al fine di colpire obiettivi europei, ma al fine di colpire obiettivi israeliani. Ha in particolare affermato che «il Fronte popolare non ha sostenuto alcuna operazione realizzata in Europa non solo dalle BR, ma nemmeno da alcun'altra fazione, con cui avevamo dei legami, se non quelle operazioni che erano al servizio della lotta palestinese, cioè contro chi che occupava la terra palestinese. Tuttavia, quando le BR svaligiavano una banca, il Fronte popolare non aveva nulla a che vedere con un'azione del genere. [...]
È vero che il Fronte popolare aveva rapporti con la Baader-Meinhof, la RAF tedesca, l'Armata rossa giapponese e poi con le BR (all'inizio, prima che fossero arrestati i suoi membri) ma su quale base? Solamente per sostenere la lotta in Palestina. Nacque così un'alleanza internazionale il cui obiettivo era aiutare il popolo palestinese a combattere contro l'occupante israeliano».
Tali riflessioni appaiono peraltro coerenti con alcune ben note vicende di cooperazione tra terrorismi, come quella dei missili di Ortona o quella del trasferimento alle Brigate rosse di armi dal Libano, o anche con l'azione di estremisti particolarmente legati al mondo palestinese come Oreste Strano.
Significativi appaiono anche i riferimenti di Sharif a campi presenti in Libano, Giordania e Siria, e al fatto che «migliaia di ragazzi e ragazze italiani sono venuti nei campi per contribuire alla lotta del popolo palestinese lavorando nelle unità sanitarie o negli ospedali oppure combattendo». Anche in questo caso la documentazione acquisita presenta diversi riscontri in questo senso, anche se non per numeri come quelli citati da Sharif, che ha comunque escluso la presenza di brigatisti nei campi.
Già nella precedente relazione della Commissione si erano del resto richiamati gli appunti del SISMI che sottolineavano come, a partire dal 1974, si fosse affermata, prima in Libano, poi in Libia e successivamente nello Yemen del Sud, una cooperazione tra le principali organizzazioni terroristiche, comprese le Brigate rosse, e l'appunto DIGOS del 31 agosto 1978, che riferiva che «il Fronte Popolare della Palestina e, in particolare, il gruppo facente capo a Abu Nidal, sarebbero tuttora favorevoli all'accoglimento di volontari europei, per l'addestramento e l'indottrinamento».
Per quanto bisognose di ulteriore verifiche, le affermazioni di Sharif toccano un punto importante: il fatto che i rapporti tra Brigate rosse e movimenti palestinesi, ben testimoniati sino al 1975/1976 sembrano poi cessare per riprendere nel 1978/1980.
Come già affermato nella sentenza - ordinanza Priore su Ustica, nel corso del 1975 si svolsero riunioni tra brigatisti e palestinesi, a cui partecipò un agente infiltrato, la cosiddetta "Fonte Damiano", assassinato nel 1980. "Damiano" fornì molte informazioni su questo tema, ma rimase sostanzialmente inattivo durante il sequestro Moro, come si vedrà nelle pagine successive.
Nel complesso, le audizioni di Bassam Abu Sharif e di Armando Sportelli integrano il quadro già illustrato nella precedente relazione. In questa si era documentato come subito dopo l'eccidio di via Fani ed il sequestro di Aldo Moro, il SISMI e, segnatamente il Capocentro di Beirut colonnello Giovannone, avessero intrapreso una serrata attività finalizzata a ottenere notizie utili a localizzare l'onorevole Moro ovvero ad avviare una trattativa con i brigatisti finalizzata al rilascio attraverso i gruppi palestinesi del Fronte popolare di liberazione della Palestina di George Habash e dell'OLP di Arafat.
In questo quadro il ruolo del Fronte popolare appare centrale, perché era una formazione marxista, in una posizione autonoma dall'OLP, e fungeva da cerniera con movimenti ostili all'OLP, come quello di Wadie Haddad e poi Abu Nidal.
Anche in questo caso l'audizione di Sharif contiene elementi importanti. Sharif ha infatti sottolineato che durante il sequestro aveva «cercato di contattare Wadie Haddad, che era il comandante delle operazioni speciali del Fronte popolare, ma stava morendo nel momento in cui Aldo Moro venne rapito». Ciò corrisponde alle indicazioni dei nostri Servizi già valorizzate nella precedente relazione, che avevano riferito, alla fine di marzo 1978, che «"Saleh" [Nimr Saleh], uno dei dirigenti di maggiore prestigio et ascendente anche presso organizzazioni Fronte Rifiuto sta operando ambito taluni elementi Fronte Popolare Habash ricercando contatto anche con Wadi Haddad».
Anche alla luce dell'audizione di Sharif, il quadro del rapporto con i movimenti palestinesi appare esteso non solo in direzione del gruppo dirigente dell'OLP, ma anche in direzione di formazioni che si andavano aggregando ai margini dell'OLP e in cooperazione con movimenti terroristici europei e mediorientali.
Sharif ha riferito che con Wadie Haddad si era determinata una irreversibile divergenza sulla questione dei dirottamenti aerei, ma che comunque egli era riconosciuto, al contrario di Carlos e Abu Nidal, come parte della causa palestinese. Ne risulta ulteriormente suffragata l'ipotesi che in corso di sequestro Moro sia stato ricercato un contatto con queste formazioni che più di altre condividevano l'orizzonte marxista e terroristico delle Brigate rosse.
La trattativa fece registrare momenti di significativo ottimismo circa la possibilità di una interlocuzione e di una positiva conclusione della vicenda verso la fine del mese di aprile del 1978, salvo poi concludersi bruscamente - come può dedursi dall'interruzione della corrispondenza sulla vicenda - per motivi che non è possibile accertare ma sui quali sono state al momento raccolte due indicazioni.
Secondo il colonnello Giovannone, come da dichiarazioni rese innanzi al giudice Mastelloni nel 1983, Arafat avrebbe riferito al generale Santovito che il contatto tra BR e palestinesi ci sarebbe stato, ma i brigatisti avrebbero richiesto per la liberazione dell'ostaggio contrapartite impossibili e poi, improvvisamente, avrebbero interrotto il dialogo.
Ad una conclusione in parte diversa si può giungere dall'esame di un appunto SISMI acquisito agli atti della Commissione, relativo alle proposte che Nemr Hammad, "ambasciatore" dell'OLP in Italia, avrebbe dovuto rivolgere al Governo italiano in cambio della collaborazione nella positiva risoluzione del sequestro Moro, ossia giungere «ad una forma di collaborazione permanente tra servizi di sicurezza palestinesi e quelli italiani».
Non essendoci alcun riscontro documentale sull'esito di questa richiesta è stato possibile anche ipotizzare che la mancata adesione del Governo italiano ad una prospettiva che avrebbe creato non pochi problemi nel rapporto del nostro Paese con i propri partner internazionali abbia determinato i palestinesi a cessare il loro impegno.
Tutto lascia ipotizzare che l'eliminazione di Moro, uno dei politici italiani che più si erano fatti carico delle istanze palestinesi, abbia creato una frattura tra le Brigate rosse e l'OLP, ma non necessariamente con altri movimenti estremistici (l'FPLP e il movimento di Abu Nidal).
Nel giugno 1978 c'è però un fatto nuovo, registrato in una informativa che il colonnello Giovannone inviò da Beirut.
Il 21 giugno 1978 Giovannone scrisse: «Le Brigate Rosse italiane avrebbero fatto pervenire in questi giorni personalmente at George Habash, leader del Fplp, copia dichiarazioni rese da Onorevole Moro corso interrogatori subiti durante prigionia, per quanto di interesse della resistenza palestinese alt si ritiene che iniziativa miri ristabilire rapporto ufficiale collaborazione et assistenza su piano anche operativo, asseritamente venuto meno ultimo biennio alt attendibilità tre»(9).
Un riscontro di questo possibile scambio potrebbe essere contenuto un articolo che Mario Scialoja, giornalista particolarmente ben informato sul sequestro Moro, scrisse per «l'Espresso» il 29 ottobre 1978. In esso, infatti, si affermava che tra le carte mancanti di Moro ci sarebbe stato «un pezzo di verbale d'interrogatorio in cui il prigioniero, partendo dal commento all'assassinio (compiuto a Roma dai servizi segreti israeliani il 16 ottobre 1972) di Wael Zfaiter, rappresentante di Al Fatah in Italia, descrive gli accordi in base ai quali i servizi segreti dei paesi NATO e quelli israeliani possono agire sul nostro territorio nazionale». Sentito sul punto in un'audizione presso la Commissione Stragi, il 14 marzo 2000, Scialoja dichiarò di non avere alcun ricordo in merito
Queste parti del "memoriale Moro" non sono mai state individuate. È certo però che dall'estate 1978 i rapporti di collaborazione tra terrorismo italiano e movimenti palestinesi furono intensi. Nell'agosto 1978 un primo carico di armi fu trasferito in Italia dal Libano per il tramite di ambienti di Autonomia operaia. Un anno dopo, nell'estate 1979, due dei capi brigatisti, Mario Moretti e Riccardo Dura, si imbarcarono a Numana su una barca, il «Papago», che raggiunse la costa libanese. Qui imbarcarono un carico di armi munizioni ed esplosivi palestinesi da trasportare e mettere in sicurezza nel nostro Paese.
7.1.L'attività della fonte "Damiano"
Proprio sulla base degli elementi sin qui esposti, la Commissione ha compiuto ulteriori approfondimenti sui rapporti tra Brigate rosse e palestinesi, nonché sulle attività dei Servizi in questo specifico settore. Ciò anche in considerazione della precoce allerta giunta dal Libano il mese precedente il sequestro dell'onorevole Moro.
In particolare, l'acquisizione e l'analisi di documentazione dell'AISE ha consentito di ottenere ulteriori, specifiche indicazioni circa rapporti tra Brigate rosse e organizzazioni palestinesi risalenti alla metà degli anni '70 e di accertare come l'intelligence italiana seguisse attentamente questa situazione, adoperandosi con specifiche attività per condizionarne l'evoluzione.
È ampiamente noto che sin dai primi anni '70 e dal convegno internazionale sulla resistenza palestinese organizzato da Potere operaio (Firenze, 1-3 ottobre 1971), si determinò una crescente attenzione dei movimenti estremistici italiani per le organizzazioni palestinesi, e in particolare per quelle di tendenza marxista, variamente legate alla Germania Est. In particolare, la documentazione acquisita evidenzia uno stretto rapporto tra Brigate rosse e gruppi palestinesi nel periodo 1974-1975, quando si svolsero alcune riunioni congiunte finalizzate a promuovere l'evasione di Curcio e Franceschini.
Per quanto emerge dagli atti, il rapporto tra i movimenti terroristici interni e movimenti palestinesi era complesso e articolato. Quella palestinese era, infatti, una galassia di organizzazioni che operavano, in maniera talora dissonante tra loro, sotto l'ombrello dell'OLP.
In questo ambito appare particolarmente plausibile un rapporto tra Brigate rosse e Fronte popolare per la liberazione della Palestina, l'organizzazione filomarxista guidata da George Habash, che, come si è detto, operava come snodo nel rapporto, talora conflittuale, della dirigenza palestinese, da un lato con gli Stati dell'Europa orientale, dall'altro con i movimenti estremistici finanziati da Libia e Iraq come quello di Wadie Haddad e poi Abu Nidal.
Alla luce di questi elementi, i rapporti dei brigatisti italiani con il Fronte potrebbero dunque configurarsi com un tentativo di inserire le Brigate rosse in una più ampia e internazionale galassia di lotta armata.
L'azione delle Brigate rosse andava perciò a incidere su un quadro, ampiamente documentato, di collaborazione tra i Servizi italiani e la dirigenza OLP, che si era impegnata, in più occasioni, a non svolgere azioni terroristiche sul suolo italiano e che allo stesso tempo si rivolgeva ai Servizi italiani allo scopo di mantenere aperto un canale di dialogo politico e facilitazioni alla circolazione di armi e persone sul territorio italiano. Va a questo proposito sottolineato che lo stesso Fronte popolare, nonostante la sua sintonia ideologica con il terrorismo interno, operava in questo quadro.
Infatti il noto messaggio del 17 febbraio 1978 con il quale il colonnello Giovannone, nel riferire di una prossima azione che avrebbe potuto interessare l'Italia, sottolineava che Habash aveva garantito che «"FPLP" opererà in attuazione confermati impegni miranti ad escludere nostro Paese da piani terroristici genere». Allo stesso tempo peraltro, i Servizi italiani si preoccuparono di garantire che questa informazione non fosse diramata ai «servizi collegati OLP Roma».
Nella ricostruzione del rapporto tra Brigate rosse e movimenti palestinesi occorre partire da un'informativa dell'ottobre 1974, con la quale il Centro C.S. di Milano segnala che tale "fonte Dino" avrebbe incontrato a Beirut il capo dei servizi di informazione e sicurezza palestinesi, Abu Ayad (alias Salah Khalaf). Questi gli avrebbe riferito di rapporti tra esponenti palestinesi e dirigenti del PCI; tramite questi ultimi i palestinesi sarebbero entrati in contatto con Renato Curcio. Nella circostanza, Abu Ayad avrebbe riferito, commentando il recente arresto di Curcio, che altri «potranno continuare i piani di collaborazione con l'esercito rosso».
In seguito, a Rabat, "Dino" avrebbe appreso dell'esistenza di «un piano dei guerriglieri palestinesi per catturare - in collaborazione con estremisti italiani - un certo numero di grossi industriali dell'Italia settentrionale» e che «recentemente sarebbero giunte a Milano due valigie contenenti armi ed esplosivi destinati allo armamento del gruppo prescelto da questa azione». In quell'occasione Dino avrebbe anche propiziato l'arresto di alcuni estremisti palestinesi in procinto di compiere attentati contro esponenti arabi moderati (verosimilmente in occasione della riunione della Lega araba).
Questa informazione, il successivo 10 novembre, viene "girata" a tutti i Centri CS con l'indicazione che il Ministero dell'interno, in particolare l'Ispettorato generale azione contro terrorismo, e il Comando generale dell'Arma sono stati informati.
Successivamente, il 12 febbraio del 1975, una nota SID, che riferisce l'esito dell'incontro con una fonte, tale "Moma", segnala: «Le organizzazioni estremiste irlandese e italiana, IRA e Brigate Rosse, sono sicuramente in contatto con gli estremisti palestinesi che fanno capo ad "Abu Ayad" (pseudonimo del noto esponente terrorista Salah Kalaf) ed a George Abbash dell'ala estremista di sinistra (PFLP) della "PLO" (The Palestine Liberation Organization)». Secondo la stessa nota «le notizie sono una ulteriore conferma: dell'estremismo di alcuni capi della guerriglia palestinese che non esitano a stabilire contatti con rappresentanti internazionali delle più violente organizzazioni terroristiche anche se tali rapporti si risolvono, in definitiva, in danno della loro stessa causa». Il documento si conclude con l'indicazione che sui contatti tra IRA, Brigate rosse e l'ala estremista palestinese saranno effettuate attività per
acquisire elementi di riscontro.
Tra l'ottobre del 1974 e il febbraio 1975 ci sono dunque due fonti, verosimilmente mediorientali, che parlano dell'esistenza di rapporti di Abu Ayad con le Brigate rosse.
Le indicazioni su una vicinanza tra brigatisti e movimenti palestinesi trovarono ulteriori precisazioni e riscontri pochi giorni dopo, il 15 febbraio 1975, quando un marconigramma del Raggruppamento Centri CS ai "Reparto D"(10) segnala: «Fonte "Moma" riferisce che ore serali odierne in Beyrouth aut Damasco est in programma riunione segreta capi guerriglia palestinese aderenti gruppo George Abbash et "Abu Ayad" (alias di Salah Khalaf). Non est improbabile presenza elementi italiani facenti parte Brigate Rosse tenuto conto che argomento riunione sarebbe incentrato opportunità attuare clamoroso gesto in Italia scopo ottenere liberazione brigatisti rossi attualmente stato detenzione». Il testo prosegue con la raccomandazione avvisare gli organi di polizia e il servizio di sicurezza dell'Alitalia.
Lo stesso giorno la notizia è girata a tutti i Centri C.S. ed è ulteriormente dettagliata. La notizia fiduciaria è indicata come "molto attendibile" e la notizia della riunione che dovrebbe avere luogo in serata a Beirut o Damasco, con la possibile partecipazione di «non indicati brigatisti rossi», riporta maggiori dettagli circa «realizzazione clamoroso gesto in Italia per determinare scarcerazione brigatisti rossi che potrebbe estrinsecarsi anche in dirottamento breve scadenza aut altro gesto imprecisato terroristico». Anche in questo caso la notizia è girata al Ministero dell'interno, al fine di sensibilizzare i servizi di sicurezza dell'Alitalia, e al Comando generale dei Carabinieri.
Nei giorni successivi, il SID riesce a entrare in contatto per «favorevoli, improvvise circostanze, peraltro propiziate dal noto "Moma", con una persona» che avrebbe partecipato alla riunione del 15 febbraio precedente. L'uomo, un arabo, fu contattato da un elemento del Servizio ad insaputa dello stesso "Moma". In seguito inizierà una collaborazione strutturata e, da quel momento, diverrà la fonte "Damiano".
È proprio "Damiano" che fornisce un dettagliato resoconto della riunione tra palestinesi e brigatisti rossi del 15 febbraio 1975.
La riunione si è tenuta a Beirut, di notte, tra le 22 e le 4, in un elegante appartamento sito in una zona controllata dai palestinesi, e vi hanno preso parte Abu Ayad, George Habash che sarebbe giunto appositamente da Bagdad, elementi arabi non riconosciuti e quattro italiani, tre uomini e una donna. Argomento dell'incontro, secondo quanto riferito da "Damiano", sarebbe stato discutere sulla «possibilità concreta da parte della guerriglia palestinese facente capo ad "Abu Ayad" e Abbash, di offrire la loro collaborazione alla causa rivoluzionaria condotta dai brigatisti rossi». I brigatisti, dal canto loro, avrebbero manifestato l'intenzione di procedere a dirottamenti di aerei Alitalia e attentati contro obiettivi preferibilmente israeliani come banche, consolati ed ambasciate per ottenere la libertà per tutti i brigatisti in carcere. I brigatisti, ritenendosi l'unica forza rivoluzionaria presente in Italia, si sarebbero
rivolti ai palestinesi, in quanto «più vicini ai loro ideali rivoluzionari» per «la necessità di trovare, prima di muoversi, un paese disposto a concedere asilo politico per coloro che ne avranno bisogno, nonché lo scalo aereo per quegli aerei eventualmente dirottati».
Sempre a dire di "Damiano" gli italiani «sarebbero stati accreditati da imprecisato parlamentare PCI che li avrebbe raccomandati come degni di essere aiutati» e i due capi arabi si sarebbero riservati una risposta in una successiva riunione da tenersi dopo una decina di giorni.
Nel documento seguono una descrizione degli "italiani" che hanno partecipato alla riunione e l'indicazione che sarebbero rientrati in Italia sparpagliati e che avevano dato l'impressione di essere dell'Italia del Nord, forse veneti. All'organizzazione di questa riunione peraltro avrebbero concorso anche Al Tayeb Ali El Fergani e Elhndi Amin, indicati come «componenti noto commando lanciamissili Ostia», che avrebbero rilevato i partecipanti all'aeroporto di Beirut. "Damiano" è quindi la terza fonte che in breve tempo parla dei rapporti tra organizzazioni palestinesi e BR e il suo resoconto assume particolare valore in quanto riferì di fatti a cui assistette direttamente.
Non a caso il Servizio valorizzò molto questa informazione. Infatti, anche se questa fu la prima informazione comunicata dallo stesso "Damiano" e la sua attendibilità non fosse stata già testata, si rilevava, a proposito dei legami tra brigatisti e movimenti palestinesi che «in effetti i legami delle frange estreme della guerriglia palestinese con organizzazioni estremiste di Europa e Giappone, sono ampiamente e tristemente noti da tempo. Non è quindi da sottovalutare la possibilità che detti legami possano materialmente concretizzarsi con l'estremismo italiano».
Della vicenda, evidentemente ritenuta della massima importanza, furono informati il Ministro dell'interno Gui, il Ministro della difesa Forlani, il Capo di stato maggiore della Difesa ed i Comandanti generali di Carabinieri e Guardia di finanza. Inoltre, furono avviate attività informative ed operative, coinvolgendo Polizia e Arma dei Carabinieri, per acquisire il maggior numero possibile di fotografie di brigatisti, al fine di identificare gli italiani partecipanti alla riunione, e furono effettuati servizi di osservazione agli aeroporti all'arrivo dei voli provenienti da Atene, Beirut, Damasco, Bagdad e Kuwait. Dall'assenza di riscontri, si ritiene che i tentativi di giungere all'identificazione dei partecipanti alla prima riunione siano stati vani.
Pochi giorni dopo questa riunione, il 18 febbraio, le Brigate rosse fecero evadere dal carcere di Casale Monferrato Renato Curcio, con un'operazione di sorprendente efficacia della quale non sono noti tutti i dettagli organizzativi.
La notizia dell'evasione, naturalmente, giunse alle organizzazioni palestinesi e fu oggetto di valutazioni da parte di "Damiano", che sottolineava che l'azione potrebbe essere stata precipitata dai brigatisti prima della seconda, programmata riunione, o per ragioni operative o per dimostrare le proprie capacità militari.
La fonte aggiungeva che i brigatisti avrebbero potuto ancora effettuare azioni in Italia e in Svizzera e indicava quest'ultimo paese e la Jugoslavia come località dove Curcio avrebbe potuto trovare rifugio perché i brigatisti vi disporrebbero di forti appoggi. I brigatisti, peraltro, potrebbero operare in autonomia rispetto ai palestinesi «sicuri, alla fine, di trovare comunque rifugio in qualche paese arabo estremista tipo Repubblica Popolare dello Yemen».
Anche in questo caso, il Servizio ritenne queste indicazioni "operativamente valide" e provvide a "girarle" al dottor Santillo, Capo dell'Ispettorato antiterrorismo, e al generale Ferrara, Capo di stato maggiore dell'Arma dei Carabinieri.
Nel proseguimento dei rapporti con la fonte, "Damiano", in vista della futura, seconda riunione con i palestinesi, prospettò di farsi accompagnare da un elemento del SID, da accreditare come sua segretaria. Un'operazione così delicata portò ad una serie di valutazioni sulla sua figura e sul suo operato, anche in considerazione del fatto che la collaborazione era iniziata da poco.
Il SID rilevava che «per il momento, in considerazione anche del precipitare della situazione, non si è ritenuto opportuno approfondire taluni aspetti della vicenda nonché della personalità di "Damiano" che, obiettivamente, appaiono poco chiari. L'uomo sembra essere sincero e leale, per quanto possa esserlo un arabo, e non spinto da alcun particolare motivo se non quello di evitare spargimento di sangue innocente, in particolare in Italia, cui è profondamente attaccato e che considera una seconda patria». Si osservava inoltre che «il noto "Moma", che in effetti ha consentito il contatto, ha garantito che "Damiano" è una persona seria ed attendibile che è entrato in contatto con i fedayn solo per motivi strettamente familiari, riuscendo successivamente ad acquistare la fiducia di "Abu Ayad"». Inoltre, «i fatti finora verificatisi sembrano indicarlo come elemento attendibile. La
richiesta di essere affiancato da un nostro elemento dimostra l'effettiva volontà di collaborare in maniera concreta nonché la serietà dei propositi da cui è animato».
Le informazioni comunicate dalla fonte "Damiano" trovarono anche un'eco di stampa. Un articolo di Laura Griffo intitolato Le Brigate Rosse legate ai Feddayn? del 24 febbraio 1975(11), nell'evidenziare le criticità legate all'evasione di Curcio, riportava infatti la notizia dei rapporti tra Brigate rosse e palestinesi negli stessi termini delle informative della fonte "Damiano", pur senza citarla. La fuga di notizie fu attribuita dai Servizi a colloqui della giornalista con il commissario capo Criscuolo, capo dell'antiterrorismo del Piemonte, e con i giornalisti Renato Pasquario, Arnaldo Giuliani e Giovanni Moncini, colloqui avvenuti a Casale Monferrato dopo l'evasione di Curcio.
Secondo una ulteriore nota, tra il 16 ed il 18 marzo 1975, "Damiano", a Roma di rientro da Casablanca e in attesa di partire per Beirut, incontrò un elemento del SID e annunciò che nei giorni successivi si sarebbe tenuto un nuovo incontro tra brigatisti ed esponenti palestinesi. "Damiano" non solo assicurò il suo impegno ma sostenne che si sarebbe adoperato per tener fuori l'Italia da attacchi terroristici, facendo leva su due argomenti: un asserito suo interesse ad aprire un'attività commerciale in Italia e la possibilità che Abu Ayad potesse curare nel nostro Paese la sua figlia undicenne.
Poiché "Damiano" avrebbe dovuto partecipare alla seconda riunione in qualità di interprete, il SID decise di attuare una specifica manovra e fornì al collaboratore istruzioni di «svolgere azione di disinformazione nei confronti delle Brigate Rosse e dei suoi rappresentanti», di «effettuare opportune alterazioni e modificazioni su quanto riferivano i brigatisti, secondo una linea che non si discostasse troppo dal contenuto dei discorsi ma che, tuttavia, mettesse in evidenza tutti gli elementi negativi della "brigate Rosse", al fine di far apparire ai capi arabi l'assoluta mancanza di ogni motivo ideale degno di essere preso in considerazione» e di «svolgere opportuna azione tendente ad illustrare la necessità di non appoggiare le Brigate Rosse in quanto, essendo questo un organismo banditesco, l'organizzazione palestinese, che ha già avuto riconoscimenti ufficiali in campo internazionale,
non ne avrebbe tratto alcun vantaggio ma, al contrario, ne avrebbe potuto subire solo conseguenze negative».
La riunione si svolge la sera del 20 marzo con le stesse modalità di quella precedente. Per quel che riguarda i brigatisti, vi partecipano un uomo e una donna, non presenti alla prima riunione, mentre, da parte palestinese: Abu Ayad, Atef Basaysu (membro del commando arrestato a Ostia il 5 sttembre 1973) e altri soggetti di minore rilievo.
Secondo quanto riferito, la manovra riuscì e in una successiva riunione tra i capi arabi, tenutasi l'indomani mattina, gli stessi sarebbero giunti alla conclusione di non concedere, almeno al momento, la loro fiducia alle Brigate Rosse e «un eventuale riesame della questione è stato rinviato a data da destinarsi o comunque non prima di tre o quattro mesi».
L'operazione di disinformazione fu considerata un successo. All'esito della stessa, in un appunto per il Capo Servizio del 20 aprile 1975, si affermava che «l'ottima azione condotta dal Raggruppamento Centri, pur se allontana nel tempo un serio pericolo per la sicurezza interna del Paese, non estingue definitivamente la minaccia eversiva. Essa, infatti, dirottata questa volta su altre componenti di alleanza strumentale tra "Brigate Rosse" e terroristi di altra nazionalità, potrebbe in futuro spingere gli italiani a ricercare collegamenti con altri più spregiudicati leaders della guerriglia palestinese». A testimonianza del rilievo dell'operazione, poi, le lettere di compiacimento inviate dai superiori gerarchici ai protagonisti della vicenda.
Proprio la considerazione svolta dal SID appare in linea con quanto avvenne nel 1978-1979, ovvero la costruzione di rapporti tra terrorismo interno e movimenti palestinesi esterni alla galassia OLP, contattati tramite il Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Per converso, l'operazione stessa potrebbe dare sostanza alla convinzione, espressa da Bassam Abu Sharif nel corso dell'audizione, di una inaffidabilità delle Brigate rosse dopo l'arresto dei brigatisti del nucleo storico.
Peraltro, all'epoca, segnalazioni di rapporti tra brigatisti e palestinesi pervenivano anche da altra fonte. Il 26 marzo 1975 il direttore del carcere di Volterra segnala che un detenuto avrebbe riferito di avere appreso di quei rapporti dal noto brigatista Roberto Ognibene, che avrebbe parlato anche di azioni eclatanti come progetto di un sequestro di ambasciatori o di un alto prelato del Vaticano per ottenere la liberazione dei brigatisti.
Il 18 gennaio 1976 Curcio fu arrestato e con tale arresto la prima generazione delle BR risultò sostanzialmente decapitata.
7.2.Intorno al sequestro Moro
L'identificazione della fonte "Damiano" si è rivelata complessa. Secondo la sentenza-ordinanza Priore su Ustica, "Damiano" si identificherebbe con Azzedine Lahderi, un esule libico che fornì ai Servizi italiani numerose e qualificate notizie sui Servizi libici, prima di essere assassinato alla stazione di Milano l'11 giugno 1980. La stessa sentenza-ordinanza ricordava pure che Lahderi avrebbe «portato a fallimento un progetto di contatto a Roma tra quei Servizi [libici] e le Brigate rosse».
Sul punto è stato escusso il 5 luglio 2017 da collaboratori della Commissione il colonnello Aldo Sasso, già funzionario del SID e poi del SISMI, che ha confermato di essere stato il gestore della fonte informativa e che «il Lahderi era denominato Damiano e che probabilmente questo nome fu da me coniato».
Il colonnello Sasso ha tuttavia precisato di non ricordare che il Lahderi gli abbia fornito informazioni sulle Brigate rosse. Ha inoltre affermato che il Lahderi gli fu presentato da Omar Yehia (o Yahia), finanziere mediorientale emerso nelle indagini sulla vicenda dei terroristi palestinesi arrestati a Ostia nel 1973 e consegnati alla Libia (si veda più ampiamente la sentenza ordinanza "Abu Ayad"). Yahia collaborava con il SID e assunse nella sua società il colonnello Giovanni Battista Minerva, già Capo ufficio amministrazione del SIFAR e poi del SID, dopo che questi lasciò il Servizio segreto italiano. Si può dunque ritenere che egli si identifichi effettivamente con la persona che presentò "Damiano" ai Servizi italiani. Va per inciso ricordato che lo stesso Yahia aveva i suoi uffici in un condominio di via Massimi 91, oggetto di indagini in relazione alla vicenda Moro.
All'esito degli approfondimenti compiuti dalla Commissione l'AISE ha confermato l'identificazione tra "Damiano" e Azzedine Lahderi.
L'attività disinformativa posta in opera da Damiano poté creare una interruzione nei rapporti tra Brigate rosse e palestinesi, tanto più che nel corso del 1975 la prima generazione dei brigatisti fu decapitata dagli arresti, con alcune eccezioni, come quella di Moretti. Tuttavia, agli atti del Servizio, risultano ulteriori segnalazioni su questo tema anche per il periodo 1976-1977.
Di particolare interesse è una segnalazione di servizio collegato del febbraio 1977, secondo la quale all'esponente del cosiddetto. "Fronte del Rifiuto", Wadie Haddad - secondo notizie da confermare - «farebbe capo un vasto traffico [di] armamenti cui intermediari apparterrebbero at gruppo terroristico (B)ader Mahinof [Baader-Meinhof] et Brigate Rosse italiane». Poiché è noto che nel 1979 le Brigate rosse importarono armi dal Libano impegnandosi a tenerne una parte a disposizione dei gruppi palestinesi attivi in Europa, la notizia porterebbe a retrodatare questo tipo di operazioni e ad individuare una collocazione delle Brigate rosse in un circuito terroristico internazionale che aveva un polo nel Medio Oriente e un altro nei Paesi del blocco orientale i quali, come è stato da tempo dimostrato, agivano come tramiti tra la RAF e l'area mediorientale.
Proprio alla luce delle attività di collaborazione con l'OLP e il FPLP acquisisce particolare rilievo la comunicazione inviata il 17 febbraio 1978 dal colonnello Giovannone alla Direzione del SISMI, d cui si è ampiamente trattato nella precedente relazione.
Come si ricorda, la comunicazione riferiva che «mio abituale interlocutore rappresentante "FPLP" Habash, incontrato stamattina, habet vivamente consigliatomi non allontanarmi Beirut, in considerazione eventualità dovermi urgentemente contattare per informazioni riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei, che potrebbe coinvolgere nostro Paese se dovesse essere definito progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da rappresentanti organizzazione estremista. At mie reiterate insistenze per avere maggiori dettagli, interlocutore habet assicuratomi che "FPLP" opererà in attuazione confermati impegni miranti ad escludere nostro Paese da piani terroristici genere, soggiungendo che mi fornirà soltanto se necessario elementi per eventuale adozione misure da parte nostre autorità».
Il messaggio, dunque, confermava il rapporto dei Servizi con il FPLP e i «confermati impegni miranti ad escludere nostro Paese da piani terroristici [in] genere» L'informazione fornita, pur se non specifica, avrebbe dovuto assumere un particolare rilievo a causa della qualità della fonte e della continuità di rapporti di collaborazione tra i Servizi italiani e quelli palestinesi.
In questo ambito acquisisce qualche consistenza l'ipotesi che Moro sia stato messo al corrente del messaggio da Beirut, anche in virtù dei rapporti che continuava a intrattenere con Giovannone, e che ciò spieghi i colloqui con autorità di Polizia che avvennero nello studio di via Savoia tra il 14 e il 15 marzo 1978.
E, anche al di là di questo, è evidente che una semplice lettura combinata dei documenti programmatici delle Brigate rosse e delle informative che provenivano da Beirut avrebbe consentito di individuare una specifica necessità di tutelare la persona dell'onorevole Moro con le massime misure di sicurezza.
È noto che l'operazione di via Fani, fu, per molti aspetti, un azzardo militare ed è evidente che una protezione efficace di Moro o anche una semplice staffetta con il compito di bonificare il percorso avrebbe impresso agli avvenimenti tutt'altro esito.
Come è stato evidenziato nella precedente relazione, durante il sequestro Moro sia l'OLP che lo FPLP furono interessati per una positiva soluzione della vicenda. Il fatto, di per sé, non presentava, in linea di principio, aspetti controversi, in quanto, come ha ricordato il colonnello Sportelli, già comandante dell'ufficio "R" del SISMI, era prassi interessare i Servizi collegati, tra cui c'era quello dell'OLP. Non però quello del FPLP, in quanto ritenuto estremista.
In questo quadro colpisce la mancata attivazione della fonte "Damiano", che non risulta abbia prodotto alcuna annotazione in quel periodo, neanche a un livello di semplice riflessione sugli eventi. E ciò nonostante essa sia rimasta attiva ben oltre il sequestro Moro.
Tra la documentazione recentemente acquisita si trova peraltro una nota del 3 maggio 1978 che riferiva le confidenze della fonte "Ferraro" relative a un viaggio a Cuba di George Habash, finalizzato a progettare un'azione a sostegno dei terroristi tedeschi, viaggio di cui «sarebbero al corrente esponenti dell'ultrasinistra italiana gravitanti nell'area dell'Autonomia operaia italiana».
Mettendo in relazione le ultime acquisizioni con quanto segnalato nella precedente relazione, emerge dunque una difficoltà nel reperire informazioni, che dovette rendere più difficile l'azione dei Servizi. Se infatti, le fonti precedentemente ritenute più affidabili, come "Damiano", - per quanto risulta - tacquero, le indicazioni che pervenivano dal Medio Oriente, spesso, non era suscettibili di produrre approfondimenti di indagine.
Sempre in corso di sequestro Moro si colloca una vicenda già a suo tempo affrontata, senza molti risultati, dalla prima Commissione Moro, che, alla luce della riflessione svolta qui e nella precedente relazione, assume contorni più significativi di quanto in passato si ritenne.
Nell'aprile 1978, al Cairo, fu arrestato un gruppo di estremisti di sinistra in contatto con l'AKO (organizzazione anarchica tedesca), con il Comitato palestinese di Zurigo e con la rete di Soccorso rosso internazionale insieme a un gruppo di egiziani e di giordani, e il giornalista svizzero Sergio Mantovani.
La notizia fu tempestivamente acquisita dal Servizio segreto militare, che produsse su questo tema numerosi appunti a partire dal 27 aprile 1978.
Un appunto del 27 aprile 1978 dall'addetto militare al Cairo al SISMI comunicava la notizia, fornita dal Procuratore generale egiziano al Cairo, dell'arresto di ventiquattro persone accusate di «partecipazione a complotto con obiettivo a comitati di pace Egitto-Israeliani», tra le quali Mantovani, una studentessa tedesca di nome Gunter e uno studente palestinese, già frequentatore dell'università di Roma. L'appunto riferiva inoltre che «presunto collegamento con Brigate rosse ed altre organizzazioni terroristiche tramite libraio svizzero Bellini è emerso durante gli interrogatori».
Anche se i Servizi italiani valutarono con molta prudenza l'informazione, ulteriori accertamenti furono compiuti. Emerse in particolare che, nelle confessioni degli imputati, «il collegamento tra le Brigate rosse italiane e il gruppo terroristico arrestato in Cairo avrebbe dovuto avvenire inoltrando lettere tramite casella postale sita a Posta centrale San Silvestro [Roma] cui numero nessuno dichiara conoscere. Lettere alla casella postale venivano portate da studenti palestinesi residenti a Roma. Bellini da Zurigo ha smentito quanto sopra dichiarato dal Mantovani» (telegramma trasmesso da "Ufficio" "R" a Reparto "D", nr. 824/060).
Queste prime informazioni sulle confessioni acquisirono maggiore concretezza solo il 25 maggio 1978, quando l'ambasciata d'Italia al Cairo trasmise la traduzione del testo delle confessioni fornito dalla Procura generale egiziana. Da questo emergeva che il giornalista svizzero Sergio Mantovani, simpatizzante della causa palestinese e vicino a Fatah, si era legato dal 1977 a un'ala detta "gli avanguardisti", che faceva riferimento a Awad Khalil Abdel Kader. Nello stesso 1977 Bellini, noto agitatore politico e titolare della libreria "Echo" a Zurigo, avrebbe detto a Mantovani «che le Brigate rosse desideravano avere un dialogo con le Organizzazioni palestinesi di sinistra e gli chiese di aiutarlo a tale scopo». Mantovani accettò e, tornato in Egitto, fu messo in contatto dal Kader con Mohamed Aref Hussein Al Mussa, capo di un altro gruppo dissidente di Fatah.
Bellini andò poi in Egitto nel febbraio 1978 ed ebbe, insieme a Mantovani, diversi incontri con il Mussa, il quale «fornì un recapito segreto, rappresentato dal numero di una casella postale a Roma, per lo scambio della corrispondenza tra le Brigate rosse e la "Linea corretta di Al Fatah", e manifestò il proposito di recarsi in seguito personalmente a Roma per prendere diretti contatti». Bellini e Mantovani si sarebbero inoltre fatti coinvolgere nel progetto, gestito da gruppi vicini a Wadie Haddad, per un'operazione contro una commissione egizio-israeliana, che si riuniva al Cairo.
Anche Aref Al Mussa avrebbe confermato le confessioni di Mantovani, mentre due altri implicati, i coniugi svizzeri Gianni e Doris Bacchetta, e un'altra cittadina svizzera, Elvira Martina Genz, dichiararono di aver recapitato dei messaggi per contro di Aref Al Mussa in Irak e in Sudan, ma senza conoscerne il contenuto.
Le indagini della DIGOS furono sviluppate a partire dal 28 aprile, quando la Polizia, tempestivamente informata dal SISMI, prese contatto informalmente con il «direttore responsabile delle caselle postali» allo scopo di compiere verifiche sulle caselle postali di cittadini arabi presenti nell'Ufficio di San Silvestro.
Le indagini si conclusero solo in agosto quando, come riferisce il rapporto all'Autorità giudiziaria della DIGOS, si individuò la casella postale n. 142, nella quale si ritrovò una lettera che gli inquirenti definirono «scritta evidentemente in codice» indirizzata a tale Mokassian, identificato in Alain Mokassian, nato a Parigi il 7 ottobre 1949, di origini armene, residente in Francia e di fatto domiciliato a Roma. La casella postale 142 di Roma-San Silvestro era invece intestata a Kassem Jammoul Nabil, nato a Beirut il 9 giugno 1946, abitante a Roma in via Baccina 80, titolare della ditta JNK Import-Export e ritenuto in contatto con esponenti di Fatah.
L'inchiesta svoltasi al Cairo si concluse invece nel mese di giugno, con l'espulsione degli stranieri implicati, mentre nulla si sa della sorte degli altri imputati.
All'esito della vicenda il SISMI osservò che l'arresto avrebbe potuto essere in relazione a un'operazione politica del governo egiziano. Nella relazione del Servizio alla prima Commissione Moro, si osservava che «gli accertamenti praticati non consentivano di raccogliere concreti elementi di conferma, mentre risultava abbastanza evidente che la notizia dell'operazione era stata artatamente gonfiata».
Parzialmente diversa fu la valutazione del SISDE che, nella relazione per la prima Commissione Moro, sottolineò che il 18 aprile 1978 il Ministero dell'interno austriaco aveva indicato la Svizzera come "centrale di collegamento" dei gruppi eversivi europei e pose tale indicazione in relazione proprio con gli arresti del Cairo, nonché con le vicende dei traffici di armi del 1972/1974 per i quali furono arrestati, tra gli altri, Sergio Spazzali e Valerio Morucci.
Da un esame degli atti, la caratura degli arrestati e delle persone implicate non appare affatto banale e fa ritenere possibile che si sia ricercato o realizzato un contatto con le Brigate rosse.
Georges (Giorgio) Bellini è infatti un personaggio ampiamente noto. Fu indicato in alcune informative che la Francia acquisì dagli archivi dei Paesi ex sovietici come intermediario tra le Brigate rosse e il gruppo Separat di Carlos. Bellini apparteneva in effetti all'area di Potere operaio e manteneva contatti con brigatisti presenti in Svizzera. Responsabile di traffici di armi negli anni '70, poté avere a che fare con gli episodi di introduzione di armi in Italia di cui si rese responsabile Valerio Morucci.
Mohamed Aref Hussein Al Mussa è pure personaggio ampiamente noto agli atti dei Servizi italiani. Dalla documentazione recentemente acquisita da collaboratori della Commissione, risulta che Al Mussa, studente presso l'università di Siena, fu più volte segnalato nel corso del 1976 come esponente di "Giugno nero" di Abu Nidal, impegnato nella progettazione di attentati contro ambasciate di Paesi arabi e mediorientali e responsabile di un attacco all'ambasciata siriana in Italia. In ragione di queste notizie, il rappresentante palestinese in Italia Nemr Hammad richiese più volte la sua espulsione dall'Italia. Con appunto del 22 ottobre 1976 il Servizio propose di aderire alle richieste.
Al Mussa fu quindi oggetto di un provvedimento di espulsione, ma si rese irreperibile e, ancora nel giugno 1977, non era stato individuato. Un appunto del Centro SISMI di Perugia del 26 settembre 1981 (n. 4441/RR) riferì conclusivamente che Al Mussa «durante il soggiorno in Italia faceva parte del gruppo di Abu Nidal responsabile dell'azione terroristica compiuta ai danni dell'Ambasciata siriana di Roma, successivamente individuato dai Servizi di sicurezza italiani su indicazioni fornite da elementi della PLO, sostenitori della linea di Al-Fatah, i quali avevano rilevato anche il numero della casella postale presso la sede centrale di Piazza S. Silvestro in Roma, della quale il gruppo di Abu Nidal si serviva per il recapito della corrispondenza. In seguito Al Mousa Mohammed Aref venne invitato a lasciare l'Italia, ma, temendo rappresaglie, anziché rientrare in Libano, si trasferì in Egitto dove qualche mese dopo venne ugualmente
raggiunto e assassinato da un comando di Al Fatah».
Il nome di Mussa compare anche in un Appunto del Direttore del SISMI relativo all'esito di una missione effettuata a Beirut e dei colloqui intercorsi con esponenti dell'OLP del 28 aprile 1978, già valorizzato nella precedente relazione.(12) L'appunto riferiva gli esiti di un incontro con Abu Hol, reponsabile dei servizi di sicurezza dell'OLP, nel quale si erano esaminati «gli elementi raccolti sulla vicenda Moro in Europa ed in Medio Oriente da informatori e fonti occasionali dei predetti servizi al fine di individuare un "canale" diretto che consentisse di accertare l'esistenza in vita dell'on. Moro ed eventuali alternative alla richiesta di rilascio dei 13 detenuti».
Secondo i Servizi italiani, il contatto possibile sarebbe passato attraverso simpatizzanti della rete estremista di Wadie Haddad, poi passata nelle mani di Abu Nidal e di Carlos. Si precisava infatti che «l'elemento palestinese che, secondo le indagini svolte dalla polizia egiziana, teneva i collegamenti tra la "centrale" del gruppo di Baghdad, ed i suoi affiliati in Egitto, tale Mohamed Aref Mussa, faceva parte del primo gruppo di borsisti palestinesi della "O.L.P." in Italia, ma venne privato della borsa di studio ed espulso su proposta del rappresentante della "O.L.P." a Roma, essendo risultato agente iraqeno coinvolto in attività illecite. Egli potrebbe essere stato l'eventuale tramite per il progettato collegamento tra il gruppo di Baghdad e le Brigate rosse».
Anche un terzo personaggio emerso nell'inchiesta del Cairo appare particolarmente interessante e suscettibile di aver realizzato contatti tra terrorismo palestinese e terrorismo italiano. Si tratta della persona che, in una prima informativa sugli arrestati (nota dall'ufficio "R" all'ufficio "D"), viene identificato come il terrorista "Pierino Brugat".
In realtà, come chiariva una nota inviata dal SISDE al SISMI il 2 maggio 1978, il nome Pierino Brugat sarebbe risultato da una errata traduzione mentre l'arrestato si sarebbe identificato in Bruno Bréguet. Nel 1978 Bréguet era noto soprattutto per essere stato arrestato nel 1970 in Israele con dell'esplosivo che intendeva utilizzare per un attentato. Condannato a quindici anni nel 1972, fu liberato nel 1977 a seguito della mobilitazione di molti intellettuali europei e del suo amico François Genoud, finanziere svizzero che finanziò i movimenti armati algerini e palestinesi. Avvicinatosi al gruppo di Carlos e probabilmente anche a ambienti terroristici di Prima Linea, Bréguet fu arrestato nel 1982, dopo aver compiuto diversi atti di terrorismo, insieme alla compagna di Carlos, Magdalena Kopp. Rifugiatosi in seguito a Damasco, sparì nel 1995 in circostanze misteriose, nel corso di un viaggio in nave tra Italia e
Grecia.
L'episodio insomma evidenzia ancora una volta l'esistenza di un'area, brigatista o erede di Potere operaio, in stretti rapporti con le formazioni marxiste della galassia palestinese, che, a loro volta, erano fortemente legate all'Irak - allora ritenuto il più filosovietico degli Stati mediorientali - e alla Germania Est. Si trattava di un rapporto di cooperazione strumentale, che lasciava ampi margini di autonomia operativa, ma che allo stesso tempo testimoniava, al di là delle ricorrenti dichiarazioni di autosufficienza delle Brigate rosse, la loro inserzione in una dimensione internazionale e riconfermava il rapporto con un più vasto partito armato. Dallo sfondo sommariamente evidenziato emerge dunque la plausibilità di rapporti operativi tra Brigate rosse e i gruppi palestinesi esterni all'OLP, gli stessi che Giovannone raggiunse per il tramite del Fronte popolare per la liberazione della Palestina sino a giungere, alla fine
di aprile 1978, a una fase avanzata che sembrava sfociare in una vera e propria trattativa.
Come si è ampiamente sottolineato nella precedente relazione, il carteggio dei Servizi evidenzia come alla fine di aprile 1978 esistesse una forte fiducia nei contatti stabiliti dall'OLP per il tramite di studenti palestinesi attivi in Italia. È in questo contesto che si colloca uno degli snodi più importanti di questa vicenda che chiama in causa, insieme, il rapporto con i palestinesi e l'esistenza di un possibile canale di comunicazione tra Moro ed esponenti politici e istituzionali.
Il 24 aprile 1978 il colonnello Giovannone inviò in una nota «personale per direttore generale» il messaggio che era stata «concordata positiva immediata azione vertici O.L.P. che habent già raccolto qualche utile elemento per stabilire contatti noti interlocutori». Giovannone partì dunque in fretta dal Medio Oriente con un aereo della Snam e, il 25, mentre era in viaggio, inviò una nuova nota per informare che «sono proseguiti in nottata per ricerca valido contatto con Brigate rosse in Europa, con prospettive che dovrebbero finalizzarsi brevissima scadenza».
Colpisce la concomitanza dei movimenti di Giovannone con quanto Moro scriveva nelle sue lettere. Tra il 28 e il 29 aprile furono infatti recapitate ben quattro lettere che trattavano di questo tema.
Nella lettera alla Democrazia cristiana, recapitata il 28 aprile e scritta il giorno precedente Moro scriveva: «Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti della Dc che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la Dc lo ignorasse, anche la libertà (con l'espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. ....».
Il giorno successivo, 29 aprile 1978, fu recapitata una lettera al Presidente del Gruppo parlamentare della DC alla Camera, Flaminio Piccoli, che si ritiene scritta già il 23 aprile, nella quale Moro affermava: «Ma, per tua tranquillità e per diffondere in giro tranquillità, senza fare ora almeno dichiarazioni ufficiali, puoi chiamarti subito Pennacchini che sa tutto (nei dettagli più di me) ed è persona delicata e precisa. Poi c'è Miceli e, se è in Italia (e sarebbe bene da ogni punto di vista farlo venire) il Col. Giovannone, che Cossiga stima. Dunque, non una, ma più volte furono liberati con meccanismi vari palestinesi detenuti ed anche condannati, allo scopo di stornare gravi rappresaglie che sarebbero state poste in essere, se fosse continuata la detenzione. La minaccia era seria, credibile, anche se meno pienamente apprestata che nel caso nostro. Lo stato di necessità
è in entrambi evidente. Uguale il vantaggio dei liberati, ovviamente trasferiti in paesi terzi».
Sempre il 29 aprile 1978, venne recapitata un'altra missiva, stavolta al Sottosegretario del Ministero di grazia e giustizia Renato Dell'Andro, anch'esso sollecitato a seguire lo stesso iter percorso in passato per i palestinesi: «Tu forse già conosci direttamente le vicende dei palestinesi all'epoca più oscura della guerra. Lo Stato italiano, in vari modi, dispose la liberazione di detenuti, allo scopo di stornare grave danno minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata. Nello spirito si fece ricorso allo stato di necessità. Il caso è analogo al nostro, anche se la minaccia, in quel caso, pur serissima, era meno definita. [...] Io non penso che si debba fare, per ora, una dichiarazione ufficiale, ma solo parlarne di qua e di là, intensamente però».
Lo stesso giorno, il 29 aprile, fu recapitata un'altra lettera al Presidente del Comitato parlamentare per il controllo sui servizi di informazione, Erminio Pennacchini, anch'essa ritenuta del 23 aprile. Moro scriveva: «Si tratta della nota vicenda dei palestinesi che ci angustiò per tanti anni e che tu, con il mio modesto concorso, riuscisti a disinnescare. L'analogia, anzi l'eguaglianza con il mio doloroso caso, sono evidenti. [...] Di fronte alla situazione di oggi non si può dire perciò che essa sia del tutto nuova. Ha precedenti numerosi in Italia e fuori d'Italia ed ha, del resto, evidenti ragioni che sono insite nell'ordinamento giuridico e nella coscienza sociale del Paese. Del resto è chiaro che ai prigionieri politici dell'altra parte viene assegnato un soggiorno obbligato in uno Stato terzo. Ecco, la tua obiettiva ed informata testimonianza, data ampiamente e con la massima urgenza, dovrebbe togliere alla
soluzione prospettata quel certo carattere di anomalia che taluno tende ad attribuire ad essa. [...] Lascio alla tua prudenza di stabilire quali altri protagonisti evocare. Vorrei che comunque Giovannoni(13) fosse su piazza».
Insomma, quando Moro, il 23 aprile, scriveva «vorrei che comunque Giovannoni fosse su piazza», Giovannone stava acquisendo le informazioni che avrebbero dovuto consentire di avviare una trattativa per salvare la vita di Moro e, il giorno dopo, lasciava Beirut. Quale che fosse la fondatezza delle speranze riposte da Giovannone e da Moro in una positiva conclusione della vicenda, la concomitanza dei movimenti di Giovannone con le lettere di Moro sembra indicare che Moro fu in qualche modo partecipe o addirittura promotore di questo tentativo di trattativa, il che apre la questione dell'esistenza di un canale informativo non noto. Ma vi è di più. Il 24 aprile 1978 l'avvocato Guiso, che perseguiva un analogo tentativo anche sfruttando il suo rapporto professionale con i brigatisti in carcere, affermò, all'uscita di un incontro in carcere che «come si decise che quei palestinesi [i responsabili dell'attentato di Fiumicino]
potevano andarsene all'estero, così si potrebbe decidere per le tredici persone di cui parla il documento numero 8»(14). Affermazioni che, come si vede, si collocano dopo la presunta stesura delle lettere di Moro e in contemporanea alla partenza di Giovannone, ma prima del recapito ai destinatari delle lettere stesse.
Va a tale proposito ricordato che, come emerso nelle loro audizioni presso la Commissione, Guiso operava, in questa fase, di concerto con Aldo Bonomi e Umberto Giovine, entrambi appartenenti a ambienti socialisti legati a "Critica sociale" e vicini ad ambienti "autonomi" milanesi, che operavano su mandato di Craxi. Tanto Bonomi che Giovine hanno, con diversi accenti, ricordato di aver avuto tra le mani copie di lettere di Moro non ancora rese note. Giovine ha in particolare precisato che furono almeno tre, tutte pervenute successivamente al 18 aprile 1978, quindi in periodo compatibile con l'attivazione di Giovannone. Lo stesso Giovine ha peraltro ricordato una sua conoscenza e una forte confidenza con Giovannone, datandola ai primissimi anni '80 e ha affermato che Giovannone «era stato coinvolto, sia pure in modo secondo me surrettizio, nella questione Moro da parte di quel «partito» che riteneva che ci potesse essere un addentellato con il
Medio Oriente nel rapimento di Moro».
Se effettivamente circolarono negli ambienti milanesi e, tramite Guiso, Giovine e Bonomi, giunsero a Craxi lettere di Moro relative alla trattativa con i palestinesi, sarebbe ulteriormente confermata l'esistenza di un canale politico tra la "prigione del popolo" ed esponenti politici nazionali, non riducibile ai noti contatti di Signorile con Pace e Piperno, ma pienamente inserita in una dimensione internazionale.
Il 28 aprile 1978 un Appunto del Direttore del SISMI relativo alle richiesta di Nemr Hammad di un incontro con il Ministro dell'Interno(15) riferiva che il rappresentante OLP in Italia Nemr Hammad aveva chiesto di essere ricevuto da Cossiga, allo scopo - si riteneva - di: «illustrare dettagliatamente la presa di posizione della "O.L.P" a riguardo delle "Brigate rosse" e della vicenda dell'on. Moro, di cui tratta il comunicato diramato ieri dall' "O.L.P."»; «rappresentare la disponibilità e l'interesse della dirigenza "O.L.P." ad una forma di collaborazione permanente tra i servizi di sicurezza palestinesi e quelli italiani. Confidenzialmente mi è stato asserito che, pur ritenendosi che i servizi di sicurezza italiani collaborino come tutti quelli occidentali, con i servizi israeliani, sussistono margini ed interessi comuni per una valida collaborazione nel campo
dell'antiterrorismo come i recenti avvenimenti dimostrano».
Alla fine di aprile era dunque evidente al più alto livello politico l'esistenza di una operazione finalizzata alla liberazione di Moro che si svolgeva tramite la dirigenza palestinese e con la piena consapevolezza dei vertici dei Servizi e dei Ministri competenti. La strada della trattativa era tuttavia problematica. Al di là della volontà collaborativa dell'OLP, il contatto eventuale con le Brigate rosse passava da frange del FPLP che potevano seguire linee diverse o addirittura competitive rispetto all'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Per converso, l'avvio di una più strutturata collaborazione tra Servizi italiani e palestinesi poteva comportare prezzi politici insostenibili in campo internazionale. Da questo punto di vista, è significativo che non si ritrovino seguiti alla richiesta di Hammad di un incontro con Cossiga.
All'indomani della morte di Moro, i Servizi italiani ripresero il filo di un confronto con i rappresentanti OLP in Italia che, probabilmente, era stato interrotto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 1978 per i rischi politici che avrebbe comportato un diretto intervento palestinese in una funzione di mediazione.
In un documento del 27 maggio 1978, riferito ad un contatto di Nemer Hammad con il Raggruppamento Centri, si segnalava che Hammad aveva riferito che le organizzazioni palestinesi più pericolose erano quelle che facevano capo ad Abu Nidal ed a Wadie Haddad, recentemente deceduto per malattia. Quest'ultima organizzazione era «senz'altro da ritenere la più pericolosa, in campo operativo internazionale, in quanto è quella che mantiene i contatti, intesi nel senso più ampio, con le similari organizzazioni terroristiche non solo europee (IRA - BR -ecc. ecc.) ma anche di altri paesi extraeuropei tipo l'armata rossa giapponese».
L'indicazione, peraltro, era stata recentemente confermata anche dalla fonte "Damiano" che aveva riferito che «nel corso di una visita da poco resa da George Habash, a Cuba, [la vicenda è indicata come già nota da parte del SID] a Fidel Castro, quest'ultimo avrebbe espresso il suo vivo apprezzamento per gli ideali che ispirano la lotta politica delle BR, invitando i palestinesi a fraternizzare con i brigatisti rossi nel nome dei comuni ideali antimperialisti da cui traggono alimento le lotte sostenute da entrambi i movimenti».
Alla fine di giugno giunse in Italia Matassi Raboh Zakaria, con il compito di addetto alla sicurezza dei membri dell'OLP presenti in Italia e di ufficiale di collegamento con le autorità di polizia italiane. Lo stesso aveva anche il compito di «collaborare con la Polizia italiana allo scopo di individuare eventuali infiltrazioni, collegamenti favoreggiamenti o collusioni di qualsiasi genere fra organizzazioni terroristiche italiane e cittadini arabi, in genere, o stranieri che ad essi sono notoriamente collegati».
Il 4 luglio 1978 Zakaria e Hammad ebbero un colloquio con elemento del Raggruppamento Centri. Nel corso del colloquio si concordò che i palestinesi avrebbero consegnato al Raggruppamento un «elenco di arabi ritenuti pericolosi dal punto di vista del terrorismo» e un elenco fotografico di 127 esponenti palestinesi ritenuti vicini ad Abu Nidal. A questo scambio di informazioni si univa un impegno a approfondire la vicenda Moro. In proposito, i palestinesi segnalarono che in corso di sequestro era stato distribuito a Beirut un volantino di appoggio all'organizzazione brigatista e che c'era stata in Italia una penetrazione di irakeni, impegnati a compiere attentati a danno dei palestinesi.
Colpisce la prossimità temporale di questa attivazione dell'OLP con una nota che l'11 agosto 1978 il vicedirettore del SISDE, Silvano Russomanno, inviò al Segretario generale del CESIS. Nella nota si riferiva che «secondo notizie provenienti da fonte estera attendibile esiste un· piano di stretta collaborazione fra le Brigate Rosse e Giugno Nero al punto che i capi di questa ultima organizzazione - i quali sembra fossero già al corrente del piano relativo al rapimento dell'On.le Moro - sarebbero stati informati dalle B.R. in merito a rapimenti e ad altre azioni terroristiche che saranno tra breve intraprese in Italia». Si citavano in merito alcuni "comitati" che George Habash avrebbe costituito in Libia e Iraq, per assicurare il coordinamento con le Brigate rosse, nonché la presenza, in un campo di addestramento iraqeno, di due italiani(16). La notizia ha
peraltro un riscontro specifico. Come si apprende dalla stampa internazionale, il 29 aprile 1978, cioè nell'ultima fase del sequestro Moro, Habash si era recato a Tripoli, dove si era fermato alcuni giorni, prima di proseguire per Algeri.
Pochi giorni dopo, il 17 agosto, Craxi pose, in un articolo su l' "Avanti!" il tema dei collegamenti internazionali del terrorismo italiano, sia nei riguardi dell'Europa dell'Est sia nei riguardi dei gruppi più estremisti di Wadie Haddad. La tesi di Craxi fu oggetto di un giudizio piuttosto limitativo in alcuni rapporti dei Servizi, che sono stati esaminati nella precedente relazione, nei quali significativamente non si fa riferimento alla collaborazione in atto con l'OLP. Certo è che proprio in quel periodo un primo carico di armi fu trasportato dal Libano in Italia, nell'estate nel 1978, dai CO.CO.RI. di Scalzone che si avvalsero dell'opera di Maurizio Folini (Armando).
Le dichiarazioni di alcuni pentiti (Donat Cattin, Sandalo) portano a ritenere che l'intermediazione fu realizzata dal FPLP di Habash o, come disse Sandalo, da «gruppi minori che sfuggono alle trattative e agli impegni che l'OLP prende e decide a livello europeo e mondiale» (Relazione della prima Commissione Moro, p. 131). Il tentativo di Scalzone di porsi come snodo tra diverse organizzazioni terroristiche, speculare al tentativo del gruppo "Metropoli", come è noto, fallì, ma di esso vennero messe a parte, per il tramite di Morucci, le Brigate rosse, che l'anno successivo acquisirono direttamente armi in Libano, utilizzando lo stesso Folini.
7.3.Conclusione
L'esame della documentazione acquisita, che completa quella di cui si è già dato conto nella precedente relazione, sembra individuare una scansione abbastanza precisa del rapporto tra Brigate rosse e movimenti palestinesi. Peraltro, accanto ai rapporti diretti, va considerata l'esistenza di rapporti, già ampiamente documentati in sede giudiziaria, di un'ampia area di estremismo politico di sinistra con movimenti mediorientali.
La scansione individuata vede un robusto tentativo di creare un rapporto di collaborazione tra Brigate rosse e i movimenti palestinesi maggiormente orientati in senso marxista già nel 1974/1975, quando si svolsero a Beirut le riunioni documentate dalla fonte "Damiano". La stessa fonte, dotata di una rilevante caratura e in rapporto con molteplici ambienti arabi e mediorientali, realizzò, su incarico dei Servizi segreti italiani, un'opera di disinformazione sulle Brigate rosse, che probabilmente non fu estranea al giudizio di inaffidabilità sulle BR che è stato riproposto da Bassam Abu Sharif nel corso dell'audizione presso la Commissione. Ciò peraltro è coerente con la citata informativa del giugno 1978, che si riferiva a «rapporto ufficiale collaborazione et assistenza su piano anche operativo tra BR e FPLP» che sarebbe «asseritamente venuto meno ultimo biennio».
Nel corso del sequestro Moro la situazione appare assai più complessa e opaca. Come si è documentato nella precedente relazione, esiste, dal lato dei movimenti palestinesi, una certa fiducia nella loro capacità di dialogare con le Brigate rosse al fine di garantire la salvezza di Moro, il che sembra presupporre che a quella data un rapporto fosse stato ricostruito o fosse in corso di ricostituzione. È possibile che in quest'ambito abbiano potuto giocare un ruolo quegli ambienti dell'Autonomia operaia che in parte transitarono nella colonna romana delle Brigate rosse dopo il 1976, in parte diedero vita a autonomi movimenti di estrema sinistra. Inoltre l'episodio, alquanto opaco, degli arresti del Cairo sembra anch'esso rimandare a forme di scambio e cooperazione tra movimenti armati, in varia maniera solidali con la causa palestinese, e brigatisti.
Per converso, nel corso del sequestro l'attività dei Servizi non sembra essersi giovata delle fonti attivate nel corso degli anni precedenti. I Servizi stessi appaiono per molti aspetti dipendere, con ridotto o nullo margine di iniziativa autonoma, dalle attività e dalle informative riconducibili al FPLP e all'OLP. Ciò peraltro testimonia di un solido rapporto di collaborazione nel quadro degli accordi definitisi all'indomani dell'attentato all'aeroporto di Fiumicino del 1973 e proseguiti sin dentro gli anni '80.
In questo contesto l'iniziativa assunta dal colonnello Giovannone negli ultimi giorni di aprile 1978, giudicata promettente dai Servizi e significativamente coeva alle indicazioni che Moro inviava dalla prigione brigatista, costituisce il più rilvante tentativo di utilizzare a fondo il tessuto di rapporti esistenti tra Stato italiano e movimenti palestinesi. Il fallimento dell'iniziativa è verosimilmente legato sia all'enormità dei prezzi politici che una simile trattativa comportava, sia anche alla necessità di non rendere pubblico uno degli elementi centrali di quella parte della politica estera italiana che non era soggetta al sindacato dell'opinione pubblica e dei partner internazionali del Paese. Da questo punto di vista è significativo che non esista, per quanto è stato possibile accertare, alcun atto dei Servizi che renda conto dell'esito di una iniziativa di trattativa sulla quale si era manifestato fino
all'inizio di maggio 1978 un certo ottimismo. Ugualmente significativo è che il flusso informativo che probabilmente consentì a Moro di proporre l'opzione politica di uno scambio analogo a quello praticato in passato con i terroristi palestinesi sia rimasto, sino ad oggi, sconosciuto.
E non appare neppure casuale il fatto che quando il SISMI citò, nella redazione consegnata alla prima Commissione Moro, il noto cablogramma del 17 febbraio 1978, riferì della notizia acquisita dal FPLP «secondo cui sarebbe stata possibile nel prossimo futuro un'operazione terroristica di notevole portata», ma non dell'impegno del FPLP a operare «in attuazione confermati impegni miranti ad escludere nostro Paese da piani terroristici».
Anche se le dinamiche che operarono nel corso del sequestro Moro non sono ancora del tutto chiare, la documentazione analizzata evidenzia che, all'indomani della morte di Moro, il rapporto tra Brigate rosse e movimenti palestinesi riprese con intensità crescente già nell'estate 1978 e poi, ancora più consistentemente nel corso del 1979. Proprio nel 1979 il viaggio di Moretti e Dura in Libano e l'acquisizione di armi di provenienza palestinese può essere visto come l'esito ultimo di quella ripresa di rapporti tra brigatisti e palestinesi che l'informativa del giugno 1978 attribuiva, con notevole verosimiglianza, a una cessione di parte delle trascrizioni degli interrogatori di Moro al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.
Al contrario, la prosecuzione della collaborazione dei Servizi italiani con i Servizi OLP non sembra aver prodotto risultati di rilievo ai fini dell'identificazione di collegamenti tra il terrorismo interno e il terrorismo internazionale. Ciò derivò probabilmente dal fatto che, data la natura composita della galassia palestinese, l'OLP non era in grado di garantire una efficace tenuta degli impegni non solo a formazioni legate alla Libia e all'Irak come quella di Abu Nidal, ma anche rispetto allo stesso Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che costituiva uno snodo tra la stessa OLP, i Servizi segreti dell'Est e le componenti terroristiche di Abu Nidal e Carlos.
8. Approfondimenti su Alessio Casimirri
8.1. Premessa
Sin dalla prima relazione la Commissione ha dato conto delle iniziative assunte in relazione ai due principali brigatisti latitanti condannati per il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro: Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri.
Lojacono riuscì a espatriare grazie all'aiuto della madre, la cittadina svizzera Ornella Baragiola, e del padre Giuseppe, che secondo quanto dichiarato dallo stesso Lojacono, in una sua intervista al "Corriere della sera" del 22 ottobre 2000, gli procurò, tramite suoi contatti nel PCI la possibilità di fuggire in Algeria. Dalle indagini a suo tempo compiute dalla Procura di Roma risultano in effetti diversi riscontri in questo senso.
In relazione alla sua posizione, la Commissione ha preso atto che la legislazione svizzera non consente né l'esecuzione in Svizzera delle pene comminate, né la consegna della richiesta dell'estradizione, a meno che non vi consenta l'interessato, che ha rifiutato di farlo. Va a tale proposito segnalato che Lojacono è stato condannato in Svizzera per l'omicidio Tartaglione e due tentate rapine, mentre non è mai stato rigiudicato per l'omicidio Mantakas, il concorso nel sequestro e nell'omicidio Moro, né per gli omicidi Varisco e Schettini. Con una lettera alla Commissione del 25 novembre 2015 Lojacono ha fornito alcuni chiarimenti sulle pene scontate e si è dichiarato indisponibile a fornire collaborazione alla Commissione, dichiarando di essere «un ex-militante comunista condannato per atti, motivazioni e finalità esclusivamente politiche» e lamentando il persistere di una "linea della
fermezza" che impedisce il «superamento del rapporto tra vincitori e vinti».
Per quanto attiene a Casimirri, è stata compiuta una complessiva revisione della sua posizione, avviando anche con il Ministero degli affari esteri interlocuzioni finalizzate a verificare concrete possibilità estradittive. La Commissione ha inoltre condotto approfondite indagini allo scopo di meglio inquadrare il ruolo di Casimirri nella vicenda Moro.
Il ruolo di Casimirri nella vicenda Moro emerse sulla base delle dichiarazioni rese da Morucci nel maggio 1987, nell'ambito del processo Moro-ter. Già precedentemente, peraltro, Morucci aveva individuato la partecipazione di Casimirri all'azione di via Fani nel "memoriale" datato 1986 che fu consegnato a suor Teresilla Barillà e comunicato all'Autorità giudiziaria solo nel 1990.
Nel "memoriale" Morucci precisò che Casimirri era entrato nelle Brigate rosse poco tempo dopo l'ingresso suo e della Faranda, tra la metà del 1976 e l'inizio del 1977. Casimirri partecipò poi alla strage di via Fani. In quell'occasione era, insieme a Lojacono, a bordo della Fiat 128 bianca «che aveva sbarrato via Fani dietro l'Alfetta della scorta» e che poi si accodò alla Fiat 132 su cui era stato caricato l'onorevole Moro. L'auto fu poi abbandonata a via Licinio Calvo e Casimirri ebbe l'incarico di nascondere le armi che, come successivamente emerse, furono consegnate a Raimondo Etro.
La sentenza del Moro-ter rilevò per la prima volta che proprio «in forza delle accuse o meglio delle chiamate in correità sostanziali elevate da Morucci, nel corso di questo dibattimento, chiamate che sono pienamente attendibili proprio perché tortuose e reticenti» emergeva «con certezza la partecipazione all'operazione di via Fani di due brigatisti, conosciuti come tali ma non componenti di quel nucleo operativo, e cioè di "Otello" Lojacono e di "Camillo" Casimirri».
Il ruolo di Rita Algranati, non nominata nel "memoriale", emerse solo successivamente e non in sede processuale, tanto che la stessa fu assolta per la vicenda Moro. Rispondendo a una contestazione del Procuratore Marini il 31 marzo 2015, Morucci affermò a questo proposito che «l'Algranati me la so' proprio dimenticata!».
Dopo aver partecipato ad altre azioni brigatiste, Casimirri avrebbe poi abbandonato le Brigate rosse nel corso del 1980. In seguito se ne persero le tracce, fino al 1986, quando fu segnalato in Nicaragua.
La scoperta della localizzazione di Casimirri in Nicaragua avvenne a seguito di un evento fortuito. Casimirri aveva contratto matrimonio a Managua il 17 dicembre 1983 sotto il falso nome di Guido Di Giambattista, con la cittadina nicaraguense Mayra De Los Angeles Vallecillo Herrera. Come precisato dalla nota inviata dall'Ambasciata italiana a Managua, il 29 aprile 1986, successivamente integrata da ulteriori note e informative, la Vallecillo si presentò presso l'Ambasciata italiana per denunciare il comportamento violento e minaccioso di suo marito, che, «secondo il certificato di matrimonio esibito» era il cittadino italiano Guido Di Giambattista. La stessa Vallecillo dichiarò che si trattava di un nome falso e che suo marito doveva identificarsi con il latitante Alessio Casimirri.
Le attività svolte dalla Commissione hanno portato a numerose acquisizioni rispetto a un terrorista che è riuscito a scampare all'arresto attraverso una serie di passaggi spesso poco chiari, che evidenziano l'esistenza di forti protezioni in Nicaragua e di possibili appoggi anche in Italia.
In questo contesto ha un'importanza cruciale la ricostruzione puntuale delle modalità di fuga di Casimirri dal nostro Paese, perché è proprio da questo tema che emergono una serie di circostanze documentalmente rilevabili.
La Commissione ha in particolare approfondito tre aspetti: la vicenda dell'esistenza di un cartellino fotosegnaletico di Casimirri datato 4 maggio 1982; le modalità di fuga e la latitanza di Casimirri; la missione del SISDE nel 1993 in Nicaragua, quando Casimirri fu contattato da due funzionari del Servizio.
8.2.Il cartellino fotosegnaletico del 4 maggio 1982
Nell'ambito di accertamenti, delegati alla Polizia, finalizzati a comparare le impronte digitali repertate sulla Rénault 4 nella quale fu ritrovato il corpo di Aldo Moro e non attribuite, con quelle di brigatisti o, comunque, di soggetti segnalati, è stato rinvenuto, tra la documentazione versata alla Commissione dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma il 13 aprile 2015, un cartellino fotosegnaletico intestato ad Alessio Casimirri che risulta compilato il 4 maggio 1982.
Il cartellino, proveniente dagli archivi del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma, riporta, nella parte descrittiva, i seguenti dati: «Pregiudizi e tecnica criminosa: partecipazione a banda armata»; «Motivo del segnalamento: arresto»; «Falsi nomi: "Camillo"; Ufficio segnalatore "Rep. Op. CC. RM"». Nessun segno particolare è evidenziato; è invece riportata la statura «Altezza: 1.70». Al cartellino è apposta una foto - solo frontale - che presenta Casimirri in età sicuramente giovanile e senza barba né baffi.
L'esistenza di questo cartellino, in precedenza non nota, è ovviamente apparsa meritevole di approfondimento, poiché non risulta in atti che Casimirri sia mai stato arrestato né fotosegnalato, sia anche perché alla data 4 maggio 1982 era già colpito da più mandati di cattura.
Già il 16 febbraio 1982 era stato infatti colpito da ordine di cattura nr.151/82-B emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, per partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata denominata "Brigate Rosse". Il 4 marzo 1982 fu colpito da un secondo mandato di cattura nr.341/82 R.G. -nr.107/82 M.C. emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, per partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata denominata "Brigate Rosse". Conseguentemente, dal 26 febbraio 1982 Casimirri risultava iscritto in rubrica di frontiera, per il provvedimento di arresto.
Pertanto ad un eventuale fotosegnalamento sarebbe dovuto seguire un immediato arresto. Lo stesso cartellino riporta tuttavia, come motivazione del segnalamento, «arresto».
Ne risultano due alternative. O si verificò effettivamente un fatto abnorme; un arresto di Casimirri, con un suo successivo rilascio, che gli diede la possibilità di sottrarsi a due mandati di cattura e di proseguire la latitanza.
Oppure il cartellino riporta impronte digitali non di Casimirri e fornisce informazioni non veritiere sull'arresto e sulla data di redazione dello stesso cartellino. Ciò peraltro pone la questione di quali motivazioni possano aver condotto a redigere un documento che attesta una cattura, in realtà mai avvenuta, di un brigatista latitante e possano aver indotto a conservare agli atti di archivio del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma un documento falso.
Data la rilevanza delle questioni emerse, la Commissione ha condotto numerosi accertamenti di natura documentale e testimoniale per dare la più corretta interpretazione di un documento che presenta evidenti anomalie e singolarità.
È stato innanzi tutto accertato che il cartellino fotodattiloscopico non è mai stato trasmesso al Casellario centrale d'identità presso la Direzione centrale della Polizia criminale, che le impronte rilevate sul cartellino in questione non risultano censite nel sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), che il cartellino risulta mancante della classifica deca dattiloscopica necessaria per procedere all'archiviazione. Le ricerche condotte al fine di reperire impronte di Casimirri non hanno dato esito. Anche il Centro documentale dell'Esercito ha escluso che siano state rilevate impronte in occasione della visita di leva.
Il cartellino è stato dunque acquisito in originale dalla Commissione. Dagli accertamenti effettuati dalla Commissione è emerso quanto segue.
Si sono in primo luogo approfondite le caratteristiche della modulistica utilizzata. Il cartellino in questione era in uso alle Forze dell'ordine e riporta l'intestazione «Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Casellario Centrale di identità».
L'intestazione riportata colloca la modulistica utilizzata sicuramente in periodo successivo alla legge 1 aprile 1981, n. 121, «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», a seguito della quale fu emanato il decreto ministeriale n. 555/43 del 15 maggio 1981, che disciplinava le articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tra le Direzioni centrali era appunto indicata anche la Direzione centrale della Polizia criminale.
Dall'esame della corrispondenza amministrativa dell'epoca, è emerso che nel 1982 venivano utilizzate sia la dizione "Direzione Centrale della Polizia Criminale" sia quella, più risalente, di "Direzione Centrale di Pubblica Sicurezza". Tuttavia, la dizione più datata "Direzione Centrale di Pubblica Sicurezza" si trova in tutti i moduli di cartellini fotodattiloscopici censiti nel sistema AFIS compilati nel 1982 sia dalla Sezione rilievi che avrebbe fotosegnalato Casimirri, sia dagli altri uffici di segnalamento, per i quali sono stati effettuati ripetuti accertamenti a campione. Per converso, la dizione più recente compare nei cartellini stampati a partire dal 1983.
Appare pertanto che la modulistica utilizzata era compatibile con una redazione a maggio 1982, ma che essa si diffuse solo successivamente. Anche gli accertamenti compiuti presso il Poligrafico dello Stato, interpellato in proposito, non hanno consentito di accertare la data in cui iniziò la produzione della modulistica riportante l'intestazione "Direzione Centrale della Polizia Criminale".
Si è inoltre verificato che nel registro dei fotosegnalamenti del Reparto operativo dei Carabinieri di Roma - Sezione rilievi, effettuati sia il 4 maggio 1982 che in date prossime, non è registrato il segnalamento di Alessio Casimirri.
Pertanto, sono stati escussi diversi carabinieri che all'epoca si occupavano del fotosegnalamento presso il Reparto operativo.
Le escussioni descrivono in maniera sostanzialmente concorde le procedure in uso. Queste prevedevano un'immediata compilazione integrale del cartellino fotosegnaletico, completo delle impronte digitali e della firma del militare responsabile. Le foto, al contrario, «venivano apposte sul cartellino nei giorni successivi, di norma all'esaurimento del rullino fotografico e comunque al termine delle operazioni di sviluppo e stampa dei negativi della pellicola fotografica». Del cartellino erano compilate più copie. Le copie «venivano compilate nei giorni successivi, anche da militari diversi da quelli che materialmente compilavano il primo originale, questo perché era necessario utilizzare il personale quando era libero da altri servizi operativi». La firma era dunque lasciata in bianco, «in modo da permettere in un secondo momento al militare compilatore di firmare tutte le copie». Poteva però
verificarsi che «per motivi diversi, per esempio la prolungata assenza del militare compilatore o l'urgenza dell'invio presso altri Reparti delle copie dei cartellini, il militare che stava compilando le copie dei cartellini ricopiasse anche la firma del compilatore del primo originale».
Il fatto che venissero redatte copie in numero variabile e a distanza di tempo e che l'apposizione delle foto avvenisse anch'essa a distanza di tempo e non seguisse un ordine cronologico è stato confermato da tutti gli operanti interrogati. Del resto, anche Walter Di Cera, audito dalla Commissione, ha affermato di ricordare di essere stato fotosegnalato immediatamente dopo l'arresto, il 2 marzo 1982, mentre il relativo cartellino reca la data 6 maggio 1982.
Per converso, gli operanti hanno sottolineato - come aveva già fatto il generale Domenico Di Petrillo nell'audizione del 19 giugno 2017 - le singolarità formali che avevano già attratto l'attenzione della Commissione: la presenza di una solo foto (o copia di foto) presa solo in frontale; la mancanza del numero progressivo necessario ad abbinare il cartellino al registro dei fotosegnalamenti, i rilievi delle impronte palmari. Nessuno degli escussi è stato in grado di riconoscere la firma dell'operatore sul cartellino.
Poiché tale fotografia raffigura Casimirri senza baffi in età non databile, ma sicuramente giovanile, e non è tra le foto immediatamente disponibili in atti, si è cercato di riscontrare le modalità di acquisizione e circolazione della foto utilizzata. È stata quindi accertata la presenza della medesima immagine in un "Bollettino segnaletico dell'Arma dei Carabinieri", il "Manifesto n. 11. Latitanti pericolosi in campo nazionale, datato 1/4/1985" (Doc. 298/1, p. 799). In tale "Bollettino segnaletico" la foto di Casimirri è attribuita al 1982. La stessa foto presente sul cartellino (in età giovanile e senza baffi) è presente, senza data, negli atti di diverse strutture dei Carabinieri, segnò che essa circolò, sia pure meno della più nota foto con baffi.
Sull'origine della fotografia riportata sul cartellino segnaletico non è stato possibile acquisire riscontri esaurienti. Infatti sono stati reperiti copia del cartellino della carta di identità di Casimirri (rilasciata il 3 agosto 1977) e copia comprensiva di foto di un "visto per l'identità personale e per l'autenticità della firma", datato 11 settembre 1972. Entrambi non presentano la stessa foto del cartellino fotosegnaletico, ma una foto del Casimirri con baffi. Le ricerche esperite in relazione al foglio matricolare, al libretto universitario e alla patente di guida non hanno dato esito positivo perché nessuno degli enti interessati ha conservato documentazione fotografica.
È possibile che sia la foto della patente rilasciata il 29 gennaio 1970, oppure della carta d'identità rilasciata il 2 novembre 1969. Comunque ulteriori copie della stessa foto sono state reperite tra le carte del Reparto anticrimine di Roma (1987) e di Ancona (1985), nonché in documentazione pertinente alla Compagnia Carabinieri di Roma San Pietro, che effettuò una perquisizione senza esito a carico di Casimirri il 3 aprile del 1978, durante il sequestro Moro.
Il fascicolo impiantato presso la Compagnia comprende documentazione disomogenea, tra la quale un'agendina, una foto di Casimirri analoga a quella presente sul cartellino, una foto di Rita Algranati, documenti relativi alla perquisizione, segnalazioni e comunicazioni degli anni successivi, fino al 1988.
Conclusivamente è stato dunque accertato che il cartellino presenta diverse singolarità formali e non presenta la firma di Casimirri, ma l'indicazione "si rifiuta". Il rifiuto di apporre la firma non era infrequente, tuttavia la mancanza di una firma, vera o apocrifa, taglia alla radice la possibilità di effettuare verifiche di natura grafologica.
Allo stesso tempo, però il cartellino, che presenta alcune caratteristiche di quel tipo di documento, inclusa la firma del fotosegnalatore, è stato oggetto di conservazione presso una struttura dell'Arma dei Carabinieri e, soprattutto, riporta delle impronte digitali allo stato non riscontrate.
Nell'ambito delle indagini ancora in corso, l'identificazione delle impronte digitali presenti sul cartellino acquisisce, ovviamente, un valore decisivo. La Polizia di Stato ha in proposito interessato l'Ufficio interpol di Managua, al fine di «voler mettere a disposizione le impronte dattiloscopiche di Alessio Casimirri». Allo stato non sono state fornite risposte.
8.3 Accertamenti sulla latitanza di Alessio Casimirri
Il documento reperito potrebbe acquisire rilevanza alla luce delle molte incertezze che caratterizzano la fuga e la latitanza di Casimirri, per il quale è del tutta ignota la tempistica dell'espatrio.
Anche alla luce del fatto che gli accertamenti compiuti non hanno consentito ancora di chiarire appieno la funzione del cartellino fotosegnaletico intestato ad Alessio Casimirri, è stato avviato un complessivo riesame della vicenda di Casimirri, già oggetto di diverse audizioni, non solo in relazione al tema della mancata estradizione dal Nicaragua e alla missione degli agenti del SISDE Fabbri e Parolisi nel 1993, ma anche al complesso della sua militanza brigatista nel periodo 1976-1982.
Come è noto, Casimirri, militante di Potere operaio vicino a Morucci e Savasta, entrò nelle BR tra la metà del 1976 e l'inizio del 1977.
Al pari di altri estremisti di sinistra, a quella data era già stato oggetto di numerosi provvedimenti: il 21 marzo 1972 fu denunciato per tentata violenza privata nei confronti di un militante di destra; il 7 novembre 1973 fu segnalato alla Procura della Repubblica di Roma, quale responsabile, in concorso con altri, di violenza privata nei confronti di un militante di destra; il 30 dicembre 1974 fu segnalato per una rapina-esproprio alla Standa; il 10 gennaio 1975 fu inquisito per attacchi alle sedi del MSI. Le segnalazioni relative all'irruzione alla Standa comprendono, insieme a Casimirri, anche altre persone emerse successivamente, a vario titolo, in indagini, come Stefania Rossini, compagna di Lanfranco Pace e attiva nel Cerpet, e Giuseppe Biancucci, uno dei militanti extraparlamentari che sono stati accreditati di essere stati sulla motocicletta Honda che diversi testimoni segnalarono come presente in via Fani.
Il curriculum di Casimirri è dunque quello tipico dei militanti di Potere operaio che, dopo aver compiuto un apprendistato criminale nell'ambito dei conflitti con i movimenti di estrema destra sotto la guida di Morucci, Seghetti e degli altri responsabili dell'ala militare del Movimento, transitarono nella Colonna romana delle Brigate rosse, costruitasi attorno agli ex di Potere operaio e delle FAC. Come si rileva da una scheda della Compagnia San Pietro dei Carabinieri del 21 maggio 1975, già a quella data Casimirri era riconosciuto come «di pessima condotta morale» e come «elemento fazioso e violento, [che] milita nelle fila del gruppo extraparlamentare "Sinistra rivoluzionaria». Indicazioni che rimandavano più a una generica appartenenza politica estremista che non a uno specifico gruppo.
A caratterizzare il profilo di Casimirri rispetto ad altri militanti è la sua estrazione sociale più elevata. È infatti noto che il padre, Luciano era capo ufficio stampa dell'«Osservatore Romano» e responsabile della sala stampa vaticana, e uomo di un certo peso e vaste relazioni.
Dagli atti acquisiti dalla Commissione risulta inoltre che, anche in questa fase in cui era oggetto di segnalazioni e denunce, Casimirri acquistò due pistole sportive: il 10 febbraio 1973, una pistola a due colpi cal. "6 Flobert" e il 5 novembre 1973, un revolver cal. "6 Flobert", entrambe regolarmene denunciate.
Essendo Casimirri, come la moglie Rita Algranati, un "irregolare", egli condusse diverse attività di tipo lavorativo. Il 14 marzo 1977 registrò alla Camera di commercio di Roma la società in nome collettivo "A & C." con sede legale in Via Germanico 42. Dalla primavera del 1977 alla fine di gennaio 1978, Casimirri e Algranati locarono un locale commerciale destinato alla vendita di articoli sportivi (materiale da subacqueo) in via Maddalena Raineri 25, nel quartiere Monteverde in Roma. La successiva affittuaria, Marisa Fantini, riferì che il negozio, gestito da due ragazzi, era stato utilizzato in precedenza per la rivendita di articoli subacquei. Le chiavi dello stesso furono consegnate dal padre della Algranati il 1° febbraio 1978. In seguito, il 18 aprile 1979 il Comune di Roma revocò alla società "A & C." l'autorizzazione amministrativa per la tabella merceologica XIV, per indisponibilità
del locale.
Su questo negozio si diffusero a suo tempo, sulla base di dichiarazioni rese da Patrizio Peci, ipotesi che sono state riprese, anche in tempi recenti, di un suo utilizzo nel corso del sequestro Moro, anche come prigione dello statista.
Si tratta, in realtà di illazioni prive di ogni fondamento. A suo tempo, l'indicazione fu spiegata da alcuni brigatisti (Cianfanelli) come un'errata indicazione fornita a Peci da Raffaele Fiore. Ma, qualunque ne sia l'origine, occorre sottolineare, per sgombrare definitivamente il campo da questa ipotesi, che Peci parlò del «retrobottega di un negozio poco fuori Roma». Se questo è già sufficiente a escludere che si trattasse del negozio di Casimirri, a escludere l'ipotesi concorre anche la testimonianza resa alla DIGOS il 16 giugno 1982 dalla successiva affittuaria, Maria Pia Fantini. Questa precisò che la sua locazione iniziò il 1 febbraio 1978 e che tra febbraio e aprile furono realizzati lavori di ristrutturazione. Aggiunse inoltre: «Escludo che nel periodo compreso tra l'aprile e il settembre di quell'anno qualcuno possa aver avuto la disponibilità continua nel tempo e indisturbata
del locale, che ero solita visitare nelle occasioni in cui ricevevo della merce».
Al pari di molti altri ex militanti di Potere operaio, Casimirri fu oggetto di attenzione durante il sequestro Moro.
Come si è già accennato, il 3 aprile 1978, nell'ambito di una più vasta indagine condotta a tappeto, fu oggetto di perquisizione, senza esito, da parte dei Carabinieri (Compagnia Roma San Pietro).
Il rapporto della perquisizione, che riguardò Alessio e Luciano Casimirri e Marino Clavo, del quale anni dopo furono accertate le responsabilità per il Rogo di Primavalle, riferisce che la perquisizione diede esito negativo, sia con riferimento all'abitazione di famiglia, sita in via Germanico 42, sia dell'abitazione di via del Cenacolo 56, a La Storta, dove Casimirri effettivamente risiedeva.
Anche se i relativi verbali non riportano del sequestro di atti o oggetti, fu verosimilmente proprio nell'ambito della perquisizione che fu rinvenuta un'agendina telefonica che sino ad ora non era mai emersa ed era rimasta agli atti della Compagnia Roma San Pietro.
Dai riscontri compiuti sui numeri telefonici emerge che l'agendina era pertinente ad Alessio Casimirri. Inoltre, l'esame speditivo della grafia evidenzia che le annotazioni sull'agendina sono di mano dello stesso Casimirri.
Nell'ambito della perquisizione fu anche, con ogni evidenza, acquisito un foglio manoscritto con la dicitura «Avrei bisogno dei soldi!! Perché non vi siete fatti sentire? Telefonate urgentemente 382571 Nico». Proprio sulla base dei numeri elencati nell'agendina, è stata identificata la persona che lasciò il biglietto e che ha confermato che l'utenza telefonica in questione era a lui in uso nel periodo 1974/1979. Ha inoltre precisato che in quel periodo realizzò alcune mensole in legno per un negozio di sport in corso di allestimento nella zona di Monteverde nuovo e che il lavoro gli fu pagato solo tardivamente e non per intero. Tramite con i proprietari del negozio fu un conoscente, Fabrizio Russo, che militava nella sinistra extraparlamentare. Peraltro Russo è personaggio noto in atti. Già militante di Avanguardia operaia, fu arrestato nel 1975 per fabbricazione di ordigni, violenza a pubblico
ufficiale e danneggiamento aggravato. Il suo nominativo ricorre inoltre negli interrogatori di Raimondo Etro relativi al gruppo di autonomi che, insieme a lui, a Casimirri e ad altri, cercarono di dare vita, nel 1975-1976, a una formazione armata.
Sulla base dei dati raccolti, si può dunque confermare la datazione dell'agendina al periodo 1977/1978, quando Casimirri e Algranati erano titolari di un negozio di sport in zona Monteverde.
Il reperimento, a distanza di anni, di un'agenda che sembra prevalentemente legata a una dimensione familiare e professionale è un fatto importante, anche se l'interesse investigativo del documento è fortemente limitato dal tempo trascorso, che rende inattuale la ricostruzione del quadro relazionale che emerge dall'agenda.
Data la natura del documento, appare singolare che su di esso non siano state compiute, a suo tempo, verifiche e riscontri.
A proposito della perquisizione del 3 aprile 1978 vale la pena di sottolineare che essa "rischiò" realmente di intercettare gli assassini di via Fani. Secondo un interrogatorio reso da Raimondo Etro ai procuratori Marini e Meroni nell'aprile 1998, Etro trattenne le armi usate in via Fani per circa una settimana, poi, preso da timori per la presenza sotto la propria abitazione di un furgone di polizia, si recò nell'abitazione di Casimirri e da qui telefonò a sua madre, ottenendo rassicurazioni che nulla era accaduto. Etro riferì poi che «il giorno dopo, però seppi che era stata effettuata una perquisizione a casa di Casimirri, dopo che io me ne ero andato, quindi ci rendemmo conto del grave rischio corso».
Lo stesso Etro ha inoltre fornito al Procuratore Marini il 23 aprile 1998 alcuni ulteriori dettagli sulla perquisizione. Secondo Etro i Carabinieri avrebbero reperito all'interno di un libro «un numero di targa di un'auto, che sapevamo che era un'auto di un militante di destra o di un magistrato o di un politico», ma Casimirri riuscì a far credere che si trattasse del numero di targa di un privato con cui c'era stato un incidente stradale. Secondo Etro il numero di targa sarebbe comunque stato sequestrato, ma il fatto non può essere riscontrato poiché non fu redatto un verbale di sequestro.
Dopo la perquisizione dell'aprile 1978, non risulta che il nome di Casimirri sia emerso in indagini. Da quanto successivamente accertato, in particolare dalla sentenza di Corte d'Assise del Moro-ter, Casimirri e Algranati «rimangono in questa struttura (Fronte della Contro), ideando, proponendo e quasi sempre compiendo tutti i più gravi reati del tempo fino all'autunno del 1979, quando Casimirri viene inviato a Napoli per la costituzione ed organizzazione della Colonna napoletana e l'Algranati viene cooptata, per un breve periodo, sembra per un mese, nella Direzione di Colonna romana». In particolare la partecipazione dei due brigatisti è stata riconosciuta per l'attentato a Emilio Rossi, l'attentato Perlini, l'attentato a Publio Fiori (solo la Algranati), l'omicidio Palma, l'omicidio Tartaglione, gli omicidi Mea e Ollanu (Piazza Nicosia), l'omicidio Varisco, nonché, ovviamente, per la strage di via Fani e
l'omicidio Moro, anche se in questo caso la responsabilità della Algranati fu riconosciuta solo dopo che questa era stata assolta, in quanto Morucci omise di indicarla nel "memoriale".
Casimirri e Algranati, come molti altri membri della Colonna romana, abbandonarono le Brigate rosse all'inizio del 1980. In proposito, una datazione abbastanza certa è offerta dall'interrogatorio di Emilia Libéra del 7 aprile 1982, nel corso del quale la stessa riferì che «rientrammo a Roma intorno al 2/3 gennaio 1980 e proprio in questa circostanza apprendemmo che Camillo alias Casimirri e la moglie Rita avevano deciso di uscire dall'organizzazione».
Va a questo proposito rilevato che proprio in quel periodo, il 12 gennaio 1980, Casimirri versò presso la stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto le armi da lui detenute. È possibile ipotizzare che ci sia un nesso tra l'abbandono delle Brigate rosse e il versamento di armi, peraltro di tipo sportivo. Appare però singolare che Casimirri si sia assunto il rischio senza aver compiuto prima una qualche verifica sul fatto che non esistessero a suo carico provvedimenti in relazione ai delitti già compiuti.
Le gravi responsabilità di Casimirri emersero progressivamente all'inizio del 1982, sulla base delle convergenti dichiarazioni di una serie di pentiti, tra cui: Loris Scricciolo (dal 5 febbraio 1982), Luciano Buzzati (dal 12 febbraio 1982), Massimiliano Corsi (dal 16 febbraio 1982), Emilia Libera (1 marzo 1982, 8 e 16 aprile 1982), Antonio Savasta (dal 14 febbraio 1982), Walter Di Cera (dal 2 marzo 1982), Lorenza Bazzoni (6 maggio 1982), che imputarono a Casimirri la partecipazione agli omicidi Palma e Tartaglione e l'attacco alla sede della DC di Piazza Nicosia.
Su questa base, già il 16 febbbraio 1982 il Tribunale di Roma emetteva mandato di cattura per partecipazione a banda armata. Successivamente furono emessi mandato di cattura Tribunale di Napoli del 4 marzo 1982 per associazione sovversiva e banda armata; mandato di cattura del Tribunale di Roma del 16 luglio 1982 per insurrezione armata contro i poteri dello Stato; mandato di cattura del Tribunale di Roma (Priore) che assorbe i precedenti del 26 luglio 1982; mandato di cattura del Tribunale di Napoli del 18 novembre 1982 per banda armata.
In questa fase era del tutto ignorata la partecipazione di Casimirri al sequestro Moro. Questa emerse per la prima volta nel cosiddetto "memoriale Morucci", redatto intorno al 1986 e rimasto ignoto - per quanto risulta - all'Autorità giudiziaria e poi nelle dichiarazioni rese da Morucci al processo Moro-ter a partire dal marzo 1987.
Le ultime tracce accertate della presenza di Casimirri a Roma risalgono al 17 febbraio 1982, ovvero un giorno dopo che il giudice Domenico Sica aveva spiccato l'ordine di cattura nei confronti di Casimirri e Algranati.
Infatti, il 17 febbraio 1982, i due si presentarono dal loro datore di lavoro, Alfredo Vaiani Lisi, titolare della società "Sperimentazione didattica", che forniva insegnanti di educazione fisica a istituti religiosi, per ritirare alcune loro spettanze economiche. Secondo quanto dichiarato da Vaiani Lisi, l'intenzione di lasciare il lavoro gli era stata comunicato il 15 febbraio. In quella occasione Casimirri avrebbe manifestato l'intenzione di tornare in Sardegna presso il villaggio turistico in cui l'anno prima aveva lavorato come istruttore sommozzatore.
Tali notizie vennero apprese quando il signor Vaiani Lisi si presentò spontaneamente alla DIGOS di Roma per rilasciare dichiarazioni il 4 maggio 1982, nella stessa data riportata sul il cartellino fotosegnaletico.
Le ricerche di Casimirri furono intense sin dal 15 febbraio 1982.
Da quella data iniziò un servizio di intercettazione, che non diede esiti significativi, e furono effettuati numerosi appostamenti e ricerche nei luoghi frequentati da Casimirri, identificando un gran numero di persone in potenziale relazioni con il latitante.
Un fonogramma del 18 marzo 1982 riferì che Casimirri e Algranati «si troverebbero presso imprecisato grosso centro subaqueo ubicato zona Stintino (Sassari)». La notizia portò a numerose indagini, sia di Polizia che dell'Arma dei Carabinieri, senza esito. Le attività di ricerche in Sardegna, peraltro, erano particolarmente intense proprio nella fase in cui sarebbe stato redatto il cartellino fotosegnaletico (inizio maggio 1982).
Diversi mesi dopo, una nota SISDE del 29 dicembre 1982 segnalava che «fonte confidenziale attendibile» riferiva dell'esistenza di un covo brigatista in via Giacinta Pezzana, nel quale si sarebbe dovuta tenere, il 1 gennaio 1983, una riunione con tali "Marco" e "Camillo", con due donne e due cittadini cecoslovacchi, da tempo residenti in Italia, che sarebbero stati controllati dalla Polizia già nel 1971, davanti al Liceo Dante di Roma. L'appunto del SISDE identificava la casa e indicava "Camillo" in Alessio Casimirri e in "Marco" Viero Di Matteo.
Il 4 febbraio 1983 l'operazione si concluse. Il relativo appunto segnalava che «non sono emersi elementi di interesse», senza fornire altre indicazioni. Certo è che, in questo caso, gli accertamenti del Servizio appaiono alquanto superficiali. Mentre si acquisivano le piante dell'appartamento, si ometteva di considerare che Viero Di Matteo si era costituito nel carcere di Regina Coeli l'8 marzo 1982 e che quindi l'eventuale "Marco" non poteva essere lui.
Ulteriori segnalazioni di una presenza di Casimirri in Italia sono anche successive. In particolare, agli atti della DIGOS di Roma è presente un appunto datato 25 luglio 1983 che testualmente riporta: «Verso le ore 22,30 di ieri, tale Cherubini Mario, Ispettore della Gendarmeria del Vaticano, afferma di aver notato, nei pressi del Ponte Garibaldi, i noti latitanti Casimirri Alessio e Algranati Rita che si accompagnavano ad altra persona. Il predetto è certo delle sue affermazioni, in quanto ha conosciuto personalmente le persone summenzionate essendo un amico della famiglia Casimirri. Nella serata di ieri era in corso nel quartiere di Trastevere la "Festa de noantri". Il Cherubini ha precisato che il Casimirri vestiva con abiti trasandati ed aveva le sopracciglia rasate al centro. Per ulteriori informazioni, il Cherubini può essere contattato ai seguenti numeri telefonici: [...]».
La notizia appare di qualche rilievo. Dall'attività professionale di Cherubini e dalle intercettazioni telefoniche realizzate sulle utenze in uso a Luciano Casimirri dopo il 15 febbraio 1982, emerge che effettivamente egli era in rapporti con Luciano Casimirri.
In proposito il funzionario di Polizia all'epoca interessato delle indagini, sentito da collaboratori della Commissione, non ha ricordato particolari seguiti, in quanto la notizia, pur proveniendo da «soggetto inserito nel contesto sociale del Casimirri» era «una ipotesi difficilmente riscontrabile». Nondimeno «ci fu ovviamente maggiore attenzione in quanto proveniva da fonte più qualificata essendo il Cherubini un dipendente della gendarmeria vaticana».
L'individuazione di una presenza in Italia di Casimirri nell'estate 1983 emerge anche con un altro appunto della DIGOS, datato 9 agosto 1984, che riferiva che «fonte di estrema attendibilità ha riferito di aver visto circa un anno fa il noto latitante Alessio Casimirri in compagnia dell'ex militante di Potere operaio, Mariano Squillante, noto in questi atti». I due sarebbero stati notati a Castelnuovo di Porto.
In periodo molto successivo un appunto del SISDE, da «fonte confidenziale solitamente attendibile», dell'8 giugno 1987, segnalava la presenza di Casimirri e Algranati «presso una missione cattolica dell'Africa centrale».
Allo stato non esiste alcuna certezza sul momento in cui Casimirri lasciò l'Italia, né sulle modalità in cui lo fece, né sulle eventuali complicità di cui poté giovarsi.
Lo stesso Casimirri fece diverse dichiarazioni ai giornali in proposito.
In una prima intervista del 16 novembre 1988 a due giornalisti di "Famiglia cristiana", Guglielmo Sasinini e Angelo Montonati, entrati in contatto con Casimirri per il tramite della famiglia, Casimirri rifiutò di rispondere alla domanda «Quando, come, con chi e perché ha raggiunto il Nicaragua?». Nell'intervista dichiarò tuttavia che «dal principio dell'82 non ho più contatti di nessun tipo con i compagni o con l'Italia».
In seguito, nell'ottobre 1995, Casimirri dichiarò alla Commissione diritti umani del Parlamento del Nicaragua di essere entrato nel Paese il 18 aprile 1983 e di averlo fatto senza celare la sua indentità. L'affermazione, peraltro, si colloca in un contesto nel quale Casimirri cercava di resistere a un procedimento di revoca della cittadinanza e estradizione che sembrava prossimo e che non si realizzò, a seguito degli interventi dei gruppi sandinisti che ancora dominavano le forze armate e ampie aree della burocrazia e della magistratura.
In una più tarda intervista del 23 aprile 1998 al giornalista Maurizio Valentini de «L'Espresso», Casimirri afferma, in ordine al suo arrivo in Nicaragua: «Sono arrivato nel 1982. Dopo un anno passato a Parigi. Avevo lasciato l'Italia a fine 1981, quando avevo cominciato a capire che l'aria stava cambiando, che i pentiti stavano ormai facendo i nomi degli appartenenti alle Br». In quell'occasione Casimirri scrisse: «L'aiuto dei servizi è una balla. Ci riuscii scappando come un pazzo. A Parigi, poco prima di partire, i gendarmi erano sul punto di beccarmi. Mi inseguirono a piedi per un giorno intero... Poi però ce la feci a fuggire. Con Managua ultima tappa. La prima fu Mosca... Non avevo alcun visto. Rimasi chiuso nell'aeroporto ‘Sheremetevo' in attesa della coincidenza per Managua. In quegli anni il modo più economico, rapido e sicuro per arrivare in Nicaragua era di volare Aeroflot, e io questo
feci».
L'intervista contiene alcuni riferimenti (arresto di Emilia Libera) incompatibili con una partenza dall'Italia anteriore «a fine 1981», nonché riferimenti al suo passaporto che non hanno riscontri. Casimirri afferma che «scappai senza soldi e con il mio passaporto», mentre risulta che egli ne era sprovvisto. È stato infatti riscontrato che il 10 gennaio 1974 fu rilasciato a suo nome il passaporto n. 10220824/P, ma che il titolo non fu mai ritirato.
In una intervista rilasciata al giornale nicaraguense "El nuevo Diario" il 2 febbraio 2004, Casimirri ha invece affermato di essere giunto in Nicaragua «en un vuelo de la linea rusa Aeroflot, via Italia, Paris, Moscou».
Se Casimirri ha modificato più volte la datazione del suo ingresso in Nicaragua, pochissime e di dubbia affidabilità sono le testimonianze di altri su questo punto.
La principale è quella di Raimondo Etro, che appare però notevolmente oscillante per quanto attiene alle date. Nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero Marini il 5 dicembre 1994, Etro affermò di essere fuggito in Francia nel marzo 1982, a seguito delle confessioni di Savasta, e di aver raggiunto a Parigi Casimirri e Algranati, che già vi si trovavano. Tra il marzo e il settembre 1982 avrebbe più volte visto i due, che gli avrebbero proposto di andare in Nicaragua. Successivamente, in un interrogatorio con i procuratori Marini e Ionta del 6 marzo 1998, Etro affermò che vide Casimirri e Algranati nel settembre 1982, a Parigi, in un appartamento in cui si trovava da una settimana con Mauro Di Gioia, Gianna Marelli e Orlando Colongioli. Dopo una settimana, Casimirri avrebbe fatto pervenire una lettera nella quale affermava di essere pedinato da «agenti della Digos», di essere riuscito a seminarli,
«di essere stato nascosto in un bagno pubblico e che aveva intenzione di recarsi in Nicaragua che a suo giudizio era l'unico Paese che l'avrebbe ospitato». Affermazioni che appaiono di dubbia plausibilità sia in relazione al tema del pedinamento da parte di agenti della DIGOS sia, ancor più, in relazione al fatto che Casimirri avrebbe fatto pervenire una lettera manifestando i suoi progetti di espatrio.
In altri interrogatori, Etro ha invece fatto riferimento più genericamente al 1982 e ha dato ulteriori riferimenti alle persone che erano con lui, come Mauro Di Gioia e Olrando Colongioli.
In un intervento nel blog "InformISKRazione" (2015) Etro ha invece scritto che: «Alessio Casimirri e Rita Algranati, già a Parigi da tempo, fanno sapere tramite un contatto comune al sottoscritto e ad altri che Savasta sta collaborando ed è quindi il caso di spostarsi a Parigi...Partiamo in 5 a fine febbraio/inizio marzo 1982. Il nostro referente è Antonio Bellavita, ex direttore della rivista delle BR "Controinformazione" latitante in Francia da anni per una condanna a sette anni». Si afferma poi che successivamente «vengo a sapere che un giorno di settembre [1982] Casimirri e Algranati sono "spariti"». In questo caso è il "da tempo" che non appare perspicuo, alla luce del fatto che il 17 febbraio 1982 Casimirri e Algranati erano a Roma. Nell'audizione presso la Commissione del 31 gennaio 2017, Etro è tornato, rispondendo a alcune domande, su questo tema. Ha nuovamente fatto riferimento
genericamente al 1982 e ha ricordato che si recarono a Parigi anche Orlando Colongioli, Sandro Pietrisanti e Eugenio Ghignoni.
Orlando Colongioli, nelle dichiarazioni rese al Pubblico ministero Marini il 9 gennaio 1995, dichiarò invece di non essere mai stato a Parigi prima del 1985, quando si trasferì nella capitale francese.
Anche Mauro Di Gioia, nell'interrogatorio con i Procuratori Marini e Ionta del 9 gennaio 1995 ha negato di aver visto Casmirri e Algranati davanti all'Opera di Parigi insieme a Marelli, Colongioli e Pietrisanti.
Appena meno lontano dalle dichiarazioni di Etro è quanto asserito da Eugenio Pio Ghignoni nell'interrogatorio davanti ai procuratori Marini e Ionta del 10 gennaio 1995. Ghignoni riferì in quell'occasione che, «quando sono stato arrestato, l'8 agosto 1982, ritornavo in italia dalla Francia e esattamente da Parigi, dove mi ero recato per ragioni personali. Il mio soggiorno a Parigi è durato soltanto una settimana. Era la prima volta che mi recavo a Parigi. A Parigi non ho incontrato Orlando Colongioli». Ghignoni ha pure rimarcato che a quella data le dichiarazioni di Savasta erano ampiamente di pubblico dominio.
Si ricorda per ultimo che nell'audizione presso la Commissione il 17 giugno 2015 Marco Clementi ha detto, riferendosi a Casimirri e Algranati: «Quando la loro situazione si fece difficile in seguito all'arresto di Savasta, vennero forniti di documenti e denaro e si rifugiarono all'estero».
La notizia, però, non ha riscontri documentali. Il passaggio a Parigi appare sicuramente in linea con le pratiche che allora e anche successivamente caratterizzarono i terroristi italiani di sinistra, ma, proprio perché la fuga in Francia costituiva una soluzione largamente praticata, nulla impedisce che i resoconti affidati da Casimirri ai giornali siano una delle tante manovre depistatorie che egli pose in opera nel corso degli anni. Del resto, anche per il periodo 1984-1986 non si dispone di notizie sicure sul ruolo di Casimirri all'interno della vasta colonia di terroristi internazionali che venivano ospitati nel Nicaragua dal governo sandinista.
Dal complesso delle testimonianze a suo tempo raccolte, non si riscontra dunque alcun elemento certo per datare l'espatrio di Casimirri e Algranati dall'Italia, né, tanto meno, per individuare le modalità in cui esso avvenne. Le dichiarazioni, spesso contrastanti dell'interessato, oscillano tra la fine del 1981 - impossibile per le ragioni già dette - e il 1983, mentre quelle di Etro, che si riferiscono alla primavera-estate 1982, non hanno trovato ulteriori riscontri.
Le uniche date dotate di un sufficiente grado di certezza sono quella del 17 febbraio 1982, quando Casimirri e Algranati fecero visita al loro datore di lavoro, e quella del 17 dicembre 1983, quando Casimirri contrasse in Nicaragua matrimonio con Mayra De Los Angeles Vallecillo Herrera.
Allo scopo di chiarire più esaurientemente possibile la tempistica dell'espatrio, la Commissione ha assunto come base proprio le dichiarazioni della Vallecillo. Questa, come ricordato, si presentò all'ambasciata italiana il 18 aprile 1986 per denunciare il comportamento violento e minaccioso di suo marito, che, secondo il certificato di matrimonio esibito, era il cittadino italiano Guido Di Giambattista. La stessa Vallecillo dichiarò che si trattava di un nome falso e che suo marito doveva identificarsi con il latitante Alessio Casimirri.
Precisamente, la Vallecillo «ha affermato che suo marito ha ripetutamente tentato, con percosse e minacce di morte, di toglierle il figlio minore Alessandro e che ha dovuto desistere da questo proposito solo in seguito ad un ordine scritto delle competenti Autorità nicaraguensi». La donna affermò inoltre «di essere stata minacciata anche da altri amici italiani del marito che potevano identificarsi con altri latitanti tra cui la Algranati Rita». Secondo l'Ambasciata il gruppo di italiani si identificava con Sergio Adamoli, Maurizio Falessi e Rita Algranati.
Mentre riconferma la posizione di impunità localmente assunta dal Casimirri in ragione dei suoi rapporti con i sandinisti, l'indicazione è interessante perché valorizza il falso nome (Guido Di Giambattista) che sarebbe stato utilizzato da Casimirri.
Avendo accertato che nessun riscontro è stato effettuato su questo nominativo, la Commissione ha ritenuto opportuno delegare le necessarie attività di indagine.
È stato così identificato il signor Guido Di Giambattista, al quale, in data 8 luglio 1978, fu rilasciato un passaporto, successivamente rinnovato in data 21 luglio 1982 per 5 anni. Dello stesso passaporto fu denunciata la sparizione, per furto o smarrimento, il 3 settembre 1983.
La circostanza è dello smarrimento è stata quindi approfondita, tramite l'escussione dello stesso Di Giambattista. Questi ha riferito di essere al corrente del fatto che Casimirri aveva utilizzato il suo nome e di non averlo mai conosciuto. Ha però dichiarato di aver avuto, nei primi anni '80, rapporti di natura amicale con il fratello di Rita Algranati, Paolo Algranati, e con la sua ex moglie. Ha inoltre ricordato di avere rinnovato il passaporto nel 1982 per effettuare un viaggio in Tunisia. Non ha saputo ricordare i suoi viaggi nel 1983, ma non ha escluso che possa avere denunciato lo smarrimento del suo passaporto in occasione di un viaggio che doveva effettuare.
Paolo Algranati, escusso da collaboratori della Commissione, ha dichiarato di non ricordare, tra le sue conoscenze, Guido Di Giambattista, e che «non è mai capitato che io, la mia ex moglie, mia sorella e suo marito Alessio Casimirri siamo usciti insieme da soli o frequentato amici comuni».
L'affermazione appare in realtà destituita di fondamento alla luce del fatto che Paolo Algranati e la moglie andarono in vacanza insieme a Casimirri e Algranati nell'aprile 1980 nel villaggio "Torre Vignola" di Aglientu. Secondo l'informativa della Questura di Sassari del 14 maggio 1982, nel 1981 il gruppo era tornato nel villaggio. In quell'occasione, secondo quanto dichiarato dal cuoco della struttura, «l'Algranati Paolo, mentre apriva il cofano della sua autovettura (una Fiat 132 diesel targata Roma di colore bianco) aveva fatto inavvertitamente intravedere un revolver. Alla richiesta di spiegazioni avanzata dal Mura, il citato Algranati aveva asserito che si trattava di una pistola lanciarazzi. Per tale "sbadataggine" l'Algranati era stato aspramente rimproverato dal Casimirri Alessio».
L'acquisizione appare importante al fine di datare l'espatrio di Casimirri. Poiché il passaporto del Di Giambattista è stato rinnovato nel luglio 1982, utilizzato dallo stesso per un viaggio effettuato intorno al settembre 1982 e smarrito o rubato tra il settembre 1982 e il settembre 1983, ne consegue che un eventuale utilizzo dello stesso passaporto da parte del Casimirri si colloca necessariamente dopo il settembre 1982. Ciò implica che o Casimirri rimase in Italia per molti mesi dopo gli ordini di cattura o che un complice sottrasse il passaporto del Di Giambattista e lo portò allo stesso Casimirri in Francia o altrove.
In linea teorica è possibile che Casimirri abbia fatto uso del nome Di Giambattista senza avere materialmente in mano il passaporto in questione. Tuttavia, allo stato l'ipotesi di un uso di questo passaporto con la semplice sostituzione della fotografia appare la più probabile.
Nel suo sforzo autodifensivo Casimirri è arrivato a dichiarare alla stampa nicaraguense di essere entrato nel Paese con un documento regolare, ma questa circostanza è smentita dalla documentazione acquisita. Agli atti si riscontra infatti un certificato di matrimonio, celebrato il 17 dicembre 1983, tra Guido Di Giambattista, di trenta anni, professore italiano, e Mayra de Los Angeles Herrera, di diciotto anni, e un certificato di nascita (2 marzo 1985) di Alejandro Daniel De Giambattista Vallecillo, figlio del trentaquattrenne Guido Di Giambattista, «fotografo professionale» e della ventenne Mayra de Los Angeles Vallecillo De Giambattista. Ad abundantiam si riporta inoltre che agli atti esiste un atto di intimazione (con foto di Casimirri) contro Guido Di Giambattista affinché restituisse a Mayra de Los Angeles Vallecillo il piccolo Alejandro, che aveva sequestrato. La notizia ebbe una eco nella stampa nicaraguense
in un breve articolo che ricordava che la donna aveva potuto recuperare il figlio grazie a un'azione di polizia che aveva portato alla detenzione di Guido Di Giambattista presso la stazione di polizia di Barrio Altagracia.
Si richiama poi quanto dichiarato dal fratello di Casimirri, Tommaso, a collaboratori della Commissione il 13 settembre 2016. In quella sede Tommaso Casimirri ha infatti affermato che Fabbri e Parolisi avevano «appreso da mio fratello che era entrato in territorio nicaraguense con il passaporto di un'altra persona».
Infine, anche il funzionario del SISDE Carlo Parolisi, audito dalla Commissione il 30 maggio 2017, ha riferito che Casimirri gli dichiarò di essere entrato in Nicaragua con un volo che transitò da Mosca e «di essere stato sicuro che lì [a Mosca] sarebbero stati arrestati perché i passaporti erano palesemente falsi. [...] Invece furono trattenuti all'interno dell'aeroporto di Mosca per 24 ore, se ricordo bene, poi furono imbarcati in un aereo per Cuba e da lì raggiunsero in un secondo momento il Nicaragua». In una successiva escussione, Parolisi, dopo aver sottolineato la reticeza di Casimirri sul tema, ha anche dichiarato che «Casimirri adombrò che c'era una organizzazione che aveva provveduto alla loro fuga, fornendo anche i documenti per l'espatrio. Da come ne parlava, ma era volutamente fumoso, sembrava una organizzazione di sinistra, che si occupava appunto di dare supporto, anche
logistico».
Del resto, risulta che anche Rita Algranati abbia utilizzato un'alias, quello di Donatella Rappini, moglie, appunto, di Tommaso Casimirri.
Gli accertamenti condotti sembrano dunque ricondurre a un'attivazione di legami familiari e relazioni legate a una partecipazione a movimenti di estrema sinistra che poté favorire la latitanza di Casimirri. La famiglia Casimirri ha del resto mantenuto negli anni un atteggiamento di solidarietà con il latitante. Questo si trova chiaramente espresso anche in una lettera - acquisita dalla Commissione - del 23 dicembre 1982 di Luciano Casimirri al suo collega Federico Alessandrini, di alcuni mesi successiva ai mandati di cattura, nella quale le imprese criminali di Alessio vengono attribuite a un mal orientato amore di giustizia e alla corruzione che avrebbe caratterizzato la politica italiana. Questa dimensione familiare, evidenziatasi anche in momenti successivi, non è tuttavia in contraddizione con con altre, più elevate protezioni.
8.4. La missione SISDE del 1993.
Nel periodo trascorso in Nicaragua, Casimirri stabilì solidi legami con i sandinisti, allora al potere, divenendo parte, insieme agli altri latitanti italiani rifugiati nel Paese, di una sorta di brigata internazionale di estremisti europei e sudamericani. La cospicua documentazione acquisita dalla Commissione evidenzia soprattutto il suo ruolo di istruttore sommozzatore, i suoi duraturi rapporti con Manlio Grillo e altri latitanti, gli affari condotti in società con esponenti del regime e con aziende anche importanti, come la Esso Nicaragua, la INE (ente nicaraguense dell'energia), l'ENAP (ente nicaraguense dei porti) e - secondo fonti dei Servizi - la Parmalat Nicaragua.
È noto che nel 1993, nel nuovo contesto determinatosi in Nicaragua con la sconfitta dei sandinisti alle elezioni del 1990, sembrarono maturare le condizioni per la fine della latitanza di Casimirri. Non è questa la sede per riprendere nel suo complesso la questione delle iniziative assunte dai Governi italiani per porre termine alla latitanza di Casimirri, che coinvolge molteplici aspetti politico-diplomatici e il nodo del rapporto politico di Casimirri con Daniel Ortega, il leader sandinista tornato al potere nel 2006 in un contesto di crescente limitazione del ruolo delle opposizioni politiche.
Nell'ultima fase dei lavori la Commissione tornerà, se ci saranno i tempi, su questo tema, anche analizzando eventuali profili di criticità emersi nelle richieste estradittive.
L'attenzione della Commissione si è focalizzata soprattutto sulla missione compiuta in Nicaragua da due agenti del SISDE, Mario Fabbri e Carlo Parolisi, che nel corso del 1993 raccolsero dallo stesso Casimirri diverse informazioni sulla vicenda Moro. La missione, come è noto, si concluse senza successo, perché i colloqui avviati non poterono proseguire, anche a seguito di una fuga di notizie, ed è stata oggetto di plurimi accertamenti in sede giudiziaria.
Nell'ambito dell'inchiesta sono stati affrontati soprattutto due aspetti: in primo luogo quello della natura del rapporto creato con Casimirri e delle informazioni acquisite; in secondo luogo quello delle ragioni della fine della missione e delle eventuali interferenze che poterono determinarla. Gli accertamenti sono stati numerosi e hanno compreso l'acquisizione di un'ampia documentazione, anche classificata, e l'audizione di Fabbri e Parolisi.
Per quanto attiene al primo aspetto, la sostanza delle acquisizioni informative ottenute da Casimirri fu condensata in diversi appunti del settembre 1993, coerenti con le successive testimonianze rese dai due funzionari all'Autorità giudiziaria e alla Commissione. Gli elementi essenziali erano soprattutto tre.
In primo luogo Casimirri avrebbe chiarito che, in fase di progettazione del sequestro, si era comunque convenuto che, in ogni caso, Moro sarebbe stato ucciso. Ciò anche se una delle finalità del sequestro era quella di interrogarlo e di far esplodere le "contraddizioni" dello Stato italiano. Anche Morucci e Faranda erano su questa posizione e solo successivamente se ne sarebbero allontanati.
In secondo luogo Casimirri confermò che il nucleo che operò in via Fani comprendeva - in una prima fase - Etro e Rita Algranati (a quella data già assolta nel processo Moro-ter), sulla quale Casimirri fornì anche informazioni relative al suo passaggio, con Falessi, in Libano (a metà del 1985) e poi in Algeria.
Casimirri affermò di non aver sparato in via Fani. In proposito si richiama tuttavia che nell'audizione presso la Commissione del 31 gennaio 2017 Raimondo Etro ha dichiarato che «Casimirri mi riferì, dopo quello che era successo in via Fani, che si erano inceppati diversi mitra e, quindi, lui e Alvaro Lojacono erano stati costretti a intervenire. Ricordo perfettamente che Casimirri mi disse che Iozzino era uscito dalla macchina strillando come un'aquila e che loro avevano dovuto sparare. Adesso non ricordo bene se era stato Casimirri o se era stato Lojacono. Comunque loro intervennero, almeno secondo quello che mi disse Casimirri, che comunque non diceva cose che poi non aveva fatto».
Casimirri avrebbe poi confermato che quella di via Montalcini era l'unica prigione di Moro e dichiarato di aver raccolto confidenze dello stesso Morucci sul fatto che lui stesso aveva predisposto l'appartamento costruendo la falsa parete.
Infine Casimirri fornì gli elementi utili a identificare il "quarto uomo" della prigione, il sedicente ingegner Altobelli, descrivendolo come vagamente somigliante a Renato Arreni, alto 1.80 metri e soprattutto individuandolo come «il braccio destro di Morucci allorquando era in piedi l'organizzazione sovversiva clandestina denominata "Formazioni comuniste armate" (FCA)». Casimirri avrebbe inoltre chiarito che Altobelli non viveva nel covo, per non alterare l'immagine di coppia di Gallinari e della Braghetti. In una prima fase gli agenti del SISDE identificarono l'Altobelli in Giovanni Morbioli, identificazione che si rivelò poi inesatta.
Le acquisizioni informative erano dunque significative e in alcuni casi furono valorizzate. Non furono valorizzate però quelle che riguardavano Morucci, in particolare quella relativa a una sua conoscenza del covo di via Montalcini, conoscenza che può spiegare la sicurezza con cui Morucci fece notare a Imposimato e Priore i segni del pannello nel corso del sopralluogo compiuto a via Montalcini il 17 giugno 1985. In quell'occasione, «dopo attento esame dei diversi vani, anche sulla base dei rilievi foto-planimetrici già eseguiti, l'attenzione dell'Ufficio veniva richiamata da Morucci su una delle due stanze attualmente adibite a camera da letto» e in particolare su «una striscia di colore più scuro rispetto a quello del legno residuo». Su questa base «Morucci fa rilevare che il vano in questione deve essere quello utilizzato come "prigione"», fornendo ulteriori indicazioni tecniche
specifiche.
Anche l'indicazione relativa alla posizione di Morucci e Faranda sulla sorte di Moro e la tesi che esistesse una concordia sull'idea di uccidere l'ostaggio già prima che si attuasse il sequestro avrebbe ben potuto essere approfondita, quanto meno su un piano storico-politico, perché poteva rendere ragione di una serie di aspetti non chiariti del sequestro, dalla mancata diffusione degli interrogatori, al rapporto tra chi gestì il sequestro e i brigatisti del nucleo storico, alle stesse modalità della decisione di procedere all'esecuzione.
Vero è che la dichiarazione di Casimirri giunse in una fase molto avanzata, dopo che, nel corso degli anni '80, le dichiarazioni dei dissociati, ampiamente valorizzate in sede pubblicistica e giornalistica, avevano proposto un'interpretazione del sequestro Moro, presente anche nel "memoriale Morucci" secondo la quale l'uccisione di Moro era principalmente conseguenza della linea della fermezza assunta dalle principali forze politiche, poiché all'inizio del sequestro non esisteva ancora una linea precostituita sulla sorte dell'ostaggio e tale linea andò definendosi in relazione al mancato riconoscimento "politico".
Per quanto attiene al secondo aspetto, la Commissione ha approfondito una serie di snodi della missione che evidenziano, quanto meno, alcuni difetti di collegamento tra le varie filiere delle operazioni poste in essere.
La vicenda può essere così riassunta a grandi linee. Nell'agosto 1993 Mario Fabbri e Carlo Parolisi riuscirono a ottenere, tramite Tommaso Casimirri, un incontro con il fratello Alessio, tuttora latitante. Nel corso di un colloquio, Casimirri mostrò una certa volontà collaborativa, rivelando diversi particolari su Via Fani e su alcuni aspetti della vita interna delle Brigate rosse. A questa prima fase avrebbero dovuto seguire ulteriori colloqui, ma questa possibilità fu "bruciata", anche in conseguenza di un articolo di Gianni Cipriani, comparso su "l'Unità" del 16 ottobre 1993 e di altri articoli comparsi sulla stampa nicaraguense e internazionale.
Va aggiunto che pochi mesi dopo, tra il 24 ottobre e il 12 novembre 1993, si recò in Nicaragua una delegazione della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, con il compito di operare per la espulsione e consegna di Casimirri. La missione non ebbe successo.
Dall'analisi della documentazione acquisita emerge un difettoso collegamento tra l'azione del SISDE e quella dell'ambasciata italiana a Managua.
Già in un appunto del 30 giugno 1993, relativo a contatti con la famiglia Casimirri, nel riferire delle ampie protezioni di cui Casimirri godeva in Nicaragua, si segnalava che «alcuni tra gli italiani che lavorano in ambasciata sono soliti frequentare il suo ristorante, in particolare i Carabinieri dell'Ufficio Cifra». La notizia fu successivamente rettificata, il 7 settembre, descrivendo i rapporti con personale dell'ambasciata come «limitati e sporadici, occasionali incontri avvenuti in Managua, favoriti anche dall'attività di ristoratore svolta dal latitante».
L'elemento che più suscita perplessità è però l'intreccio tra le iniziative del SISDE e quelle assunte per il tramite dell'Ambasciata.
Preceduta da un lungo lavoro istruttorio, la missione del SISDE si svolse, come già ricordato, nell'agosto 1993, dopo essere stata autorizzata il 18 agosto dal Direttore, che ne aveva informato l'Autorità giudiziaria nella persona del dottor Ionta. L'Autorità giudiziaria non aveva ravvisato profili di criticità, stante l'assenza di accordi di estradizione con il Nicaragua.
Nel frattempo, secondo quanto ricostruito in plurimi appunti dei Servizi e della Polizia e nel carteggio diplomatico, già il 5 agosto 1993 Casimirri - probabilmente ritenendo che le reti di protezione sandiniste non lo avrebbero più protetto - si sarebbe presentato all'ambasciata italiana dichiarando la sua disponibilità a rispondere in una sede rogatoriale.
Secondo il messaggio inviato dall'ambasciata il 13 settembre, nella sua visita all'ambasciata del 5 agosto Casimirri «ha fatto inoltre conoscere di essere disposto a collaborare con la giustizia italiana ed a rendere ogni dichiarazione utile ai fini del processo di cui trattasi, chiedendo che della sua deposizione non venga fatta pubblicità sulla stampa e che la commissione rogatoria sia fatta direttamente in Nicaragua da magistrati italiani senza l'intervento di queste autorità». Il messaggio in oggetto, alquanto tardivo rispetto alla visita di Casimirri all'ambasciata, fu ritrasmesso al SISDE e alla DIGOS il 19 settembre 1993, ma non è affatto chiaro se di queste notizie il SISDE e l'Autorità giudiziaria fossero al corrente quando, alcune settimane prima, si svolgeva la missione di Fabbri e Parolisi.
La documentazione acquisita sembrerebbe in realtà escluderlo.
In un appunto riassuntivo della Direzione della polizia di prevenzione del 22 novembre 1993, indirizzato ai Direttori dei Servizi, relativo alla missione compiuta in Nicaragua dal 24 ottobre all'11 novembre 1993, si descrivevano infatti i contatti con la rappresentanza diplomatica italiana e, per suo tramite, con il Viceministro dell'interno, Frank Cesar, valorizzando l'azione dell'addetto consolare Fernando Grassi, «uomo ben introdotto nell'ambiente e parente acquisito del viceministro dell'Interno Frank Cesar».
Ebbene, nel compendio informativo che il SISDE redasse e trasmise al Ministero dell'interno, alla Polizia e al CESIS, la circostanza della visita di Casimirri in ambasciata del 5 agosto è ignorata, mentre si lamenta - a ragione - la fuga di notizie verificatasi in quegli stessi giorni, con l'articolo di Cipriani del 16 ottobre 1993 e con le dichiarazioni rese in dibattimento dal Procuratore Marini su una disponibilità di Casimirri alla rogatoria. Il combinato dei due eventi aveva fatto saltare l'operazione. E, si rilevava, la fuga era imputabile allo stesso Grassi, che aveva da tempo cercato senza esito contatti con Casimirri, venendo respinto. Di qui l'invito a «intervernire presso le più alte cariche istituzionali al fine di tentare di porre un freno alla spasmodica attività del Grassi». Questi, secondo il SISDE, «potrebbe essere stata la fonte del PM Marini», mentre «è assai probabile
che quella del giornalista Cipriani sia da individuarsi nel circuito che per forza di cose ha qui avuto appannaggio delle notizie in parola».
Tra l'agosto e l'ottobre 1993 c'è, insomma, una duplice attivazione intorno a Casimirri, una legata a un'azione del SISDE che stava conseguendo risultati promettenti in termini informativi e una legata a un'azione dell'ambasciata, o di suoi funzionari, che sfociò in un tentativo, fallito, di ottenere la revoca della cittadinanza di Casimirri e la sua estradizione.
Le due linee di azione sembrano essersi sviluppate una indipendentemente dall'altra ed essere entrate in un conflitto, di cui poté giovarsi il Casimirri, grazie agli appoggi di cui godeva negli ambienti sandinisti, sconfitti elettoralmente ma ancora presenti e forti nell'esercito e nella burocrazia del Nicaragua.
In questo quadro l'attività dell'ambasciata sembra caratterizzata da un certo difetto di azione politica, che fu del resto rimarcato nel rapporto inviato dai responsabili della missione di polizia al Capo della Polizia il 18 novembre 1993. Secondo il rapporto, infatti, l'ambasciatore Lanzoni «ha accompagnato la delegazione dal Ministro il 28.10 per poi defilarsi quasi completamente. Nel corso dell'ultima settimana, allorché si cominciava a intuire un epilogo negativo della vicenda gli è stato chiesto di intervenire in qualche modo pur di uscire dall'impasse. Ha risposto negativamente adducendo come giustificazione che, senza la necessaria autorizzazione del MAE, non poteva prendere iniziative».
Tutta la vicenda sarebbe stata dunque gestita dall'addetto consolare Fernando Grassi, personaggio radicato nell'ambiente nicaraguense, anche per proprie attività imprenditoriali. Il rapporto riferiva che «secondo Carlos Bendana, capo del locale Interpol, il Grassi sarebbe uomo dei Servizi e grande amico del Casimirri, tanto da trascorrervi insieme un recente Natale, presenti le rispettive famiglie». Ciò anche in ragione di una frequentazione, da parte del figlio di Grassi, del ristorante "Magica Roma". Grassi avrebbe però subito da Casimirri minacce che lo avrebbero indotto a consigliare un'immediata partenza della delegazione.
L'episodio appare in effetti sintomatico di una situazione di superficialità operativa che consentì a Casimirri di avviare, con l'appoggio dei sandinisti, una insidiosa campagna di stampa contro l'ambasciata italiana e contro Grassi, che trovò eco anche in una intervista di Tommaso Casimirri a Liana Milella (pubblicata su "Panorama" il 31 ottobre 1993) e che culminò in pedinamenti e minacce a carico del personale dell'ambasciata, puntualmente denunciati nella corrispondenza tra la legazione di Managua e il Ministero degli affari esteri.
L'esistenza di un corto circuito si evidenzia anche dalla testimonianza resa da Tommaso Casimirri a collaboratori della Commissione il 13 settembre 2016, anche se si tratta di dichiarazioni il cui valore non può essere sopravvalutato. Secondo quanto dichiarato da Tommaso Casimirri, il fratello aveva richiesto che il colloquio con agenti del SISDE avvenisse senza informare le autorità nicaraguensi e quelle italiane attive in Nicaragua, e interruppe la collaborazione a seguito del tentativo di promuovere la sua estradizione nel momento in cui aveva avviato la stessa collaborazione.
Per quel che è stato possibile ricostruire, il sovrapporsi di linee operative dovette dunque creare problematiche rilevanti, che bruciarono, insieme, l'ipotesi estradittiva e la collaborazione informativa, consentendo a Casimirri di mobilitare i gruppi sandinisti e paramilitari con cui era da tempo in relazione. Gli eventi del 1993 finirono così per compromettere pesantemente anche le numerose, successive, iniziative poste in essere per assicurare alla giustizia Casimirri.
Conclusivamente, gli elementi raccolti in relazione al cartellino fotosegnaletico di Alessio Casimirri datato 4 maggio 1982 e all'uso dell'alias Guido Di Giambattista inducono dubbi sulla datazione dell'espatrio a un periodo immediatamente successivo alle confessioni di Savasta, mentre pare accertato - sulla base del certificato di matrimonio - che Casimirri si trovasse comunque in Nicaragua nel dicembre 1983.
Poiché le informazioni esistenti sull'espatrio e la latitanza prima di raggiungere il Nicaragua dipendono in ultima analisi dalle cangianti dichiarazioni rese negli anni dallo stesso Casimirri, l'ipotesi di una prolungata presenza in Italia di Casimirri acquisisce una certa consistenza.
In questo contesto può inquadrarsi il tema del presunto fotosegnalamento del 4 maggio 1982, che presenta una data compatibile con l'utilizzo del passasorto di Guido Di Giambattista.
Le vistose anomalie formali del documento non hanno, allo stato, trovato una spiegazione se non a un livello di ipotesi. Nel caso di un arresto del Casimirri e di un successivo contrordine, occorre accertare chi concretamente si assunse la responsabilità del mancato arresto. Nel caso di un falso, redatto il 4 maggio 1982 o in altra data, si deve ipotizzare che il cartellino fu redatto per messere mostrato intenzionalmente a qualche soggetto, brigatista o no, oppure che esso fu redatto per realizzare un'operazione di tipo depistante della quale sfuggono i contorni.
Poiché entrambe le ipotesi presentano profili di notevole gravità, la Commissione intende realizzare, in quest'ultima fase della sua attività, sia attività tecniche finalizzate a identificare le impronte apposte sul cartellino sia - anche in collaborazione con l'Autorità giudiziaria - tutte le attività di indagine utili a definire l'origine e l'utilizzo del cartellino. A questo proposito la Commissione ha richiesto all'Arma dei Carabinieri di fornire ogni elemento utile a precisare la collocazione e le modalità del reperimento del documento e darà conto delle informazioni che perverranno.
La ricostruzione di alcuni aspetti della carriera criminale e della latitanza di Casimirri evidenziano del resto un quadro inquietante di protezioni di cui il latitante potrebbe aver goduto anche prima di offrire i suoi servigi al regime sandinista.
In proposito, fu a suo tempo evocata la esistenza di un rapporto tra il generale Francesco Delfino e Casimirri, che sarebbe stato dunque una sorta di infiltrato dei Carabinieri nelle Brigate rosse. Questa ipotesi, valorizzata dal Procuratore Marini nell'audizione alla Commissione Stragi del 9 marzo 1995, non è stata poi ripresa dallo stesso magistrato nell'audizione presso la Commissione del 18 febbraio 2015. Essa ha trovato fondamento nelle dichiarazioni rese da Bou Ghebl Ghassan, un cristiano maronita libanese implicato in traffici di droga, rese all'Autorità giudiziaria di Brescia e poi di Roma. Secondo Ghassam il generale Delfino avrebbe arrestato, per caso, Casimirri prima del sequestro Moro e avrebbe ricevuto indicazioni sul progettato sequestro. L'indicazione, pur approfondita in sede giudiziaria, non ha trovato riscontri probanti e sembra derivare da notizie frammentarie acquisite dal teste in ambiente carcerario.
Emerge nondimeno la generale trasandatezza nell'inquadramento criminale del Casimirri. Più volte segnalato e denunciato, sottoposto a perquisizione insieme a altri membri del disciolto Potere operaio, Casimirri, ancora nel 1980, si reca a riconsegnare armi in una stazione dei Carabinieri con tranquilla fiducia. Dopo le confessioni dei pentiti dell'inizio del 1982, che lo chiamavano in correità, fa ancora a tempo a ritirare le sue spettanze presso il datore di lavoro due giorni dopo che erano stati spiccati i mandati di cattura. Espatria, verosimilmente, con un passaporto grossolanamente contraffatto con il quale, secondo la sua ricostruzione, non solo entra in Francia, ma riesce a raggiungere il Nicaragua facendo scalo a Mosca.
Anche per il periodo successivo emergono criticità. Quando Casimirri è già da tempo inserito in rubrica di frontiera e oggetto di ricerche internazionali, non ci si preoccupa di acquisire alle indagini il fascicolo esistente presso la Compagnia San Pietro, contenente materiali personali e l'agendina di cui si è già trattato. Quando, nel 1986, si manifestano la presenza di Casimirri in Nicaragua e l'alias "Guido Di Giambattista", non si compie alcuna indagine sul nominativo utilizzato.
A ciò si aggiunge la tardiva emersione delle responsabilità di Casimirri in sede giudiziaria, legata essenzialmente alle omissioni comprese nelle testimonianze di Morucci, e il fallimentare tentativo del 1993, caratterizzato da evidenti lacune organizzative.
In questo quadro, le evidenti protezioni godute da Casimirri per i suoi rapporti - anche di affari - con ambienti governativi sandinisti non sembrano l'unico elemento che ha favorito la latitanza del terrorista.
Alla luce degli accertamenti già compiuti dalla Commissione e ancora in corso di approfondimento, si evidenzia la costante e ripetuta protezione nel nostro Paese, di cui Casimirri poté godere in molte fasi della sua vita, con modalità e intensità diverse ed in molteplici ambiti. Protezioni che possono essere fondate ovvi elementi familistici, ma senza escludere anche, alla luce di comportamenti di soggetti diversi, ma con analoghi percorsi, elementi di collaborazione, più o meno ufficiale, con strutture dello Stato.
9. Iniziative per la liberazione di Moro e tentativi di recuperare scritti dello statista
Tra i temi non completamente esplorati nella vicenda del sequestro Moro ci sono certamente i percorsi seguiti dai tentativi di trovare una strada per individuare, tramite soggetti non appartenenti alle Brigate rosse ma comunque in grado di avere contatti anche indiretti con esse, il luogo ove era tenuto sequestrato Aldo Moro o comunque di instaurare qualche forma di trattativa al di fuori delle vie istituzionali ufficiali. Del resto, è questo un tema su cui più si sono riscontrate omissioni, legate anche a ben comprensibili timori degli attori non brigatisti che emergessero opzioni politiche e personali che, in alcuni casi, rischiavano di integrare estremi di reato.
Se dunque già nei primi anni '80 emersero i tentativi realizzati da esponenti socialisti per il tramite di Piperno e Pace, le iniziative vaticane restarono a lungo scarsamente conosciute, mentre l'esistenza di un "canale di ritorno", pur avendo riscontri nelle lettere di Moro, è stata spesso negata dagli interessati. Solo con l'attività di indagine della Commissione sono inoltre emersi appieno i tentativi attuati tramite i palestinesi e l'azione del colonnello Giovannone, esposti in altra sezione della relazione.
Un altro tema, non meno importante, su cui mancano molte risposte è quello degli spostamenti e della probabile sparizione di una parte, forse anche sostanziosa, delle "carte" provenienti dalla prigionia dello statista e cioè l'individuazione dei luoghi ove erano circolate e della loro destinazione finale.
Anche a questi temi quindi si è rivolta l'attenzione della Commissione. Come in altri casi si è operato cercando di acquisire elementi certi e documentabili, anche attraverso l'escussione di testi. Anche se ulteriori indagini restano ancora da compiere, sono emersi numerosi elementi di interesse, che hanno in particolare portato in primo piano una serie di iniziative assunte in ambito lombardo, e comunque settentrionale. Queste, tuttavia, non sono slegate da ciò che avveniva a Roma, al centro dello Stato, dove si intersecava l'azione di esponenti politici e ecclesiastici.
9. 1. La testimonianza del maresciallo Incandela
L'esame delle nuove acquisizioni relative a tali aspetti della vicenda deve partire, quale necessario inquadramento, dalle dichiarazioni rese da un testimone diretto, il maresciallo Angelo Incandela della Polizia penitenziaria, all'epoca in servizio con il ruolo di comandante presso il carcere di massima sicurezza di Cuneo ove furono detenuti numerosi personaggi di rilievo, sia appartenenti alle Brigate rosse e a gruppi affini sia appartenenti alla criminalità organizzata.
Il maresciallo Incandela fu trasferito alla fine del 1978 dal carcere di Fossano al carcere di Cuneo su volontà del generale Dalla Chiesa, allora responsabile delle carceri di massima sicurezza. A lui erano stati affidati dal generale compiti informativi e di monitoraggio all'interno del supercarcere.
L'obiettivo, reso possibile dalle notevoli capacità del sottufficiale, era quello di raccogliere informazioni e documenti, prevenire progetti di evasione(17) e intercettare la possibile disponibilità di qualche detenuto a collaborare. Il maresciallo Incandela ha avuto ad esempio un ruolo determinante nella collaborazione di Patrizio Peci(18).
Il maresciallo Incandela è stato sentito dalla Commissione il 7 marzo 2016(19), poco prima della sua morte, e ha rilasciato dichiarazioni che arricchiscono il quadro di quanto da lui in passato segnalato. Appare perciò opportuno riportare i passaggi salienti della deposizione nella quale egli ha tracciato un quadro completo della sua attività.
Incandela ha dichiarato di aver conosciuto Dalla Chiesa «quando divenuto maresciallo sono andato in servizio al carcere di Genova». In quell'occasione «Dalla Chiesa volle incontrarmi riservatamente nei pressi del cimitero di Staglieno per propormi di collaborare con lui che aveva avuto incarico a largo raggio nel campo dell'antiterrorismo e della gestione del carcere di massima sicurezza che era in via di allestimento. Io risposi positivamente perché ho sempre ritenuto importante fare quanto più possibile in favore dello Stato in quei momenti difficili e Dalla Chiesa mi promise di farmi trasferire a Cuneo che era il carcere con più elevato numero di detenuti pericolosi in particolare nel settore del terrorismo. L'incontro con Dalla Chiesa avvenne nel 1976 e poco dopo fui effettivamente trasferito a Cuneo».
Il maresciallo ha così precisato i suoi compiti: «La mia attività consisteva nell'attivare durante i colloqui tra i detenuti e i loro familiari e anche durante i colloqui con me un registratore che Dalla Chiesa aveva personalmente messomi a disposizione e che se ricordo bene era di marca tedesca. Era un tipo di registratore molto efficiente e io dovevo restituire i nastri personalmente al Generale. Non avevo possibilità di sentire quanto registravo perché mi era stato consegnato privo delle cuffie speciali che servivano. Questa è ovviamente una cautela che il Generale Dalla Chiesa, sempre molto attento, aveva preso anche nei miei confronti [...]. Oltre alle registrazioni fotocopiavo tutte le lettere e i documenti che era possibile intercettare ed aprire e li facevo avere al Generale».
Incandela ha precisato che la sua attività non si svolgeva esclusivamente in supporto di Dalla Chiesa, «ma anche con gli uomini del Sisde. Ciò iniziò poco dopo l'inizio del lavoro con Dalla Chiesa e io sinceramente non glielo dissi. Sono tuttavia convinto che tempo dopo l'abbia saputo. Dalla Chiesa con il Sisde aveva un rapporto che si potrebbe definire di concorrenza e comunque riteneva che in quella struttura non lavorassero in modo appropriato. Comunque un ufficiale del Sisde il colonnello Ferrero o almeno così mi sembra di ricordare il nome mi diede un registratore analogo a quello che mi aveva dato Dalla Chiesa ed io in pratica facevo contemporaneamente due registrazioni, attività in cui ero divenuto abilissimo».
Il testimone ha poi rievocato in dettaglio l'importante episodio del recupero di documenti attinenti al sequestro Moro all'interno del carcere e alla loro immediata consegna a Dalla Chiesa alla presenza del giornalista Mino Pecorelli: «Un giorno verso la fine del 1978 mi fece convocare da un suo subalterno e l'incontro era fissato fuori dal carcere di Cuneo in una zona piuttosto isolata chiamata Passatore non distante da un ristorante chiamato Pantalera. L'appuntamento era fissato per le ore 23.30. Io mi portai sul posto con la 500 di una guardia e la vettura Alfa Romeo su cui poi vidi che c'era il Generale mi fece i fari da un terreno abbandonato. Una volta sicuro che fosse lui, salii sulla macchina e mi accomodai sui sedili posteriori a fianco del Generale mentre alla guida c'era una persona che non conoscevo, e che in abiti civili credevo fosse l'autista.
Il Generale mi disse che doveva affidarmi un compito di estrema importanza e cioè il recupero di due pacchetti contenenti carte riguardanti il sequestro Moro. Dovevo recuperarli e riportarli chiusi come li avrei trovati solo a lui. Io chiesi ovviamente come quei documenti fossero entrati e in che punto del carcere avrei potuto trovarli.
Dalla Chiesa si sedette allora al volante e mi disse che la persona che era prima al volante e che si sedette al mio fianco poteva darmi delle spiegazioni.
Con l'accensione di una lucetta interna vidi bene quest'uomo in faccia, parlava con l'accento romanesco, e capii da uno scambio di battute tra lui e il Generale che non era un carabiniere come avevo pensato bensì un giornalista. Infatti Dalla Chiesa mi chiese un numero di telefono e lui rispose che aveva dimenticato l'agendina in redazione. Del resto il modo con cui la persona rispose al Generale mi fece chiaramente intendere che non era un suo subalterno dell'Arma. Aggiungo che pochissimo tempo dopo vidi su tutti i giornali la foto di questa persona che avevo capito essere un giornalista e che era stato assassinato a Roma e cioè Mino Pecorelli. Lo riconobbi senza ombra di dubbio avendolo visto del resto poco tempo prima».
Secondo Incandela, Pecorelli «mi spiegò che il modo per fare entrare di nascosto qualcosa di vietato nel carcere di Cuneo era quello di utilizzare delle finestre ubicate nel settore che portava al locale dove i parenti portavano i generi di conforto per i detenuti. Queste finestre infatti prive di inferriate davano sul cortile cui i detenuti potevano accedere per ricevere quanto a loro destinato e quindi in quel momento in realtà riusciva a passare di tutto».
Il maresciallo ha rilevato che «dal colloquio con il giornalista capii che egli conosceva molto bene il carcere di Cuneo, meglio di me che ero lì da pochi giorni. Sono anche convinto che vi sia entrato più volte e del resto dai registrini dei visitatori che io avevo consultato emergevano nomi di fantasia privi anche dell'indicazione del detenuto che dovevano incontrare».
Per quanto attiene ai plichi, Incandela ha affermato: «Io mi misi subito al lavoro mi furono necessari un po' di giorni ma alla fine in un pozzetto proprio in quella stanza in cui i detenuti ricevevano i generi di conforto trovai dopo aver sollevato la grata arrugginita un pacchetto avvolto fortemente con nastro tipo pacchi era della grandezza di 30 cm x 15 avvolto come un salame. Lo presi e telefonai al Gen. Dalla Chiesa il quale arrivò da Milano immediatamente. Gli consegnai il pacchetto alla caserma Carabinieri di Fossano. Come mi era stato ordinato non mi ero azzardato ad aprirlo. Dalla Chiesa insistette affinché io recuperassi il secondo pacchetto ma non fu possibile recuperarlo nonostante ogni sforzo. Faccio altresì presente che del ritrovamento non avvisai nessun altro nemmeno il Ministero di Giustizia».
Incandela ha anche riferito di un secondo progetto, non riuscito, questa volta di "sistemare" documenti all'interno del carcere, avvenuto «dopo il pentimento di Peci intorno al 1981». In quell'occasione, Dalla Chiesa «mi convocò a Milano negli uffici della Pastrengo. M fece grandi elogi, capii che voleva qualcosa di importante, e infatti mi chiese di nascondere dietro lo sciacquone dei detenuti un pacchetto di carte che aveva lì sulla sua scrivania. Il mio compito era poi di recuperare ordinando una perquisizione e ovviamente di riconsegnare tutto a lui. Io gli obiettai che non era un'operazione corretta ma lui rispose "Maresciallo lo Stato si serve anche così". Dovetti comunque obiettargli anche che era fisicamente impossibile entrare in quel reparto da solo per nascondere il plico. Infatti come comandante sarei stato comunque sempre accompagnato a fini di sicurezza da un sottufficiale e da una o più guardie
e certo anche di notte non avrei potuto avventurarmi in quel posto da solo. Quindi quanto richiestomi che pur io sarei stato disposto a fare, non era materialmente fattibile. Dalla Chiesa si arrabbiò moltissimo e per coprire comunque il contenuto di quel colloquio mi fece firmare una lettera retrodatata con la quale io chiedevo un colloquio con lui per motivi inerenti alla mia famiglia o comunque personali».
In occasione di tale incontro il maresciallo Incandela aveva avuto la possibilità di dare un' "occhiata" ai documenti che il Generale intendeva collocare o ricollocare nel carcere di Cuneo: «Devo però aggiungere un particolare che sinora non avevo mai raccontato le carte erano sulla scrivania e ad un certo punto il Generale uscì credo per andare in bagno io allora, rimasto solo, molto velocemente cercai di sbirciare sollevando dei fogli. Erano fogli dattiloscritti e in uno di essi c'era il nome di Andreotti l'unico che riuscii a memorizzare. Aggiungo che il pacchetto poteva essere di un centinaio di fogli in pratica il pacchetto era alto 2 centimetri 2 centimetri e mezzo e poteva corrispondere alla quantità di fogli contenuti nel pacchetto a forma di salame.
Ribadisco che erano fogli scritti a macchina in modo ordinato. Aggiungo che il Generale mi aveva detto che erano carte che riguardavano Moro e Andreotti ed io ne ebbi conferma da quel poco che avevo potuto vedere».
Il maresciallo Incandela ebbe anche una serie di contatti con importanti esponenti della criminalità organizzata detenuti a Cuneo anche al fine di acquisire da loro qualche informazione in merito al sequestro Moro. Ha dichiarato: «Dopo aver lasciato il servizio nella Polizia Penitenziaria ed essere passato alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio io feci varie missioni a Pianosa e in un'occasione incontrai Francis Turatello che io non avevo mai conosciuto. Avendo sentito parlare di me mi salutò in modo molto rispettoso dicendomi che ero il "grande Maresciallo Incandela". Parlammo abbastanza a lungo e dal suo discorso che cadde anche sul sequestro Moro capii che lui sapeva di quei documenti che erano arrivati nel carcere di Cuneo e che proprio per quella ragione era stato trasferito da Cuneo. Per coincidenza quando gli parlai fu proprio il giorno prima del suo ulteriore trasferimento a Nuoro dove fu ucciso il giorno
dopo».
Ha aggiunto inoltre che «che anche il detenuto Bossi Luigi, camorrista, poi politicizzatosi a sinistra, ebbe a parlarmi del sequestro Moro dicendo che Moro non avevano voluto salvarlo mentre per Cirillo il suo partito aveva pagato un miliardo e mezzo».
Incandela ha anche riferito di una estemporanea confidenza del brigatista Raffaele Fiore, uno dei componenti del commando che aveva agito in via Fani: «Questi era detenuto a Cuneo ed era già la fase in cui le Brigate Rosse erano entrate in crisi. Un giorno si mise a rapporto con me per piccole questioni legate al carcere. In quel contesto mi disse queste precise parole "Sono stato io a sparare per primo in via Fani alla scorta di Moro. La Magistratura ha individuato 6 persone che erano in via Fani ma eravamo molti di più"».
Incandela ha collocato l'episodio in «un periodo in cui avevo scritto una relazione al Ministero in cui tra le molte cose che riferivo spiegavo anche che il Prof. Fenzi sembrava vicino a collaborare cosa che poi è avvenuta. Dovrebbe essere un periodo anche più o meno corrispondente a quello in cui era stato sequestrato il Generale americano Dozier. Credo di avere ancora la relazione in cui si parla di Fenzi a casa». Incandela ha riferito infine che «nel 1993 ho distrutto buona parte della documentazione, tra cui alcune bobine, che era collegata all'attività che ho descritto».
I collaboratori della Commissione, nel corso di un'audizione dedicata anche ad altri argomenti, hanno sentito su quanto avvenuto nel carcere di Cuneo e sui rapporti tra il generale Dalla Chiesa e il maresciallo Incandela un testimone di rilievo, l'ex colonnello dei Carabinieri Michele Riccio che aveva lavorato in quel periodo alle dipendenze del generale. In merito a tali aspetti il testimone ha fornito alcuni significativi elementi di riscontro. Riccio ha infatti affermato: «Ho conosciuto il maresciallo Angelo Incandela in servizio presso il carcere di Cuneo, non sapevo fosse morto di recente. L'ho conosciuto credo nel ‘78 la prima volta e mi fu presentato proprio dal generale Dalla Chiesa. Per il Generale, che all'epoca era al Comando del Sicurpena, svolgeva compiti investigativi e di monitoraggio all'interno del carcere, raccogliendo informazioni e sondando chi potesse essere disponibile a collaborare, in particolare negli ambienti dell'eversione
di sinistra. Ebbe infatti anche un ruolo nella scelta di Patrizio Peci nel collaborare. Il maresciallo Incandela mi fece un'ottima impressione, mi sembrava un sottufficiale con capacità operative e doti naturali di comunicazione con le persone, unite comunque a rigore. Proprio per i compiti che ho indicato fui io stesso, a richiesta del Generale, a mettere a sua disposizione un buon registratore Naga anche se ne disponevo di uno solo e mi privavo così di quello».
Sui temi della circolazione delle carte, Riccio ha affermato che «posso dire che di carte memoriali non ne ho viste. Mi viene in mente però che il Naga fosse legato a qualche documento del caso Moro da cercare all'interno del carcere. Così mi disse il maresciallo Incandela e colloco questo riferimento del maresciallo Incandela subito dopo la vicenda del covo di via Monte Nevoso, un mese, un mese e mezzo dopo, quindi a fine novembre ‘78 o le settimane circostanti». Riccio ha infine precisato che «ho avuto modo di incontrare Incandela otto o dieci volte, molto probabilmente anche a Milano e a Genova e almeno un paio di volte con il generale Dalla Chiesa. Almeno una volta sono stato a casa sua, una palazzina attigua al carcere».
Il tema dei contatti avviati all'interno del carcere di Cuneo si è intrecciato con quello dei "movimenti" delle carte di Moro in una successiva deposizione, quella di Ugo Bossi, già luogotenente e uomo di fiducia negli anni ‘70 di Francis Turatello.
Ugo Bossi all'epoca del sequestro Moro era in stato di libertà. In seguito è stato condannato per gravi reati connessi alla sua attività nell'organizzazione di Turatello. Sentito da collaboratori della Commissione, Ugo Bossi ha riferito: «Sono stato incaricato dal consigliere regionale Edoardo Formisano del MSI di attivare nelle carceri contatti con persone di rilievo come Turatello e Buscetta per favorire la liberazione dell'on. Moro, cercando una strada in tal senso... don Cesare Curioni, cappellano di San Vittore, che conoscevo bene e da cui andai dopo le proposte di Formisano, espresse il suo assenso e mi spinse a fare il massimo presso i detenuti e nell'ambiente conoscevo, compresi gli ambienti romani».
Bossi ha precisato che «per portare a compimento questo incarico, per il quale personalmente non avevo alcun vantaggio, ebbi con facilità permessi di colloquio sia presso il carcere di Cuneo che quello di Novara, anche se non sempre sono stato registrato. Ho avuto colloqui con Francis Turatello, cui ero legatissimo, Tommaso Buscetta, Mingiardi e altri detenuti che adesso non ricordo» Rispondendo ai quesiti Bossi ha inoltre aggiunto che «a Cuneo, durante questi colloqui ed accessi, ho conosciuto il maresciallo Incandela che ha voluto conoscermi e ci siamo incontrati anche presso il bar del carcere. Formisano mi informò che i nostri colloqui, per garanzia, erano registrati; intendo dire i colloqui fra me e i detenuti».
Relativamente a una possibile circolazione delle carte di Moro, Bossi ha chiarito: «Ebbi vari incontri, credo tre o quattro, con Tommaso Buscetta, ovviamente nel primo incontro volle in realtà conoscermi e voleva sapere i miei rapporti all'esterno. In uno degli incontri successivi, oltre a quanto ho già avuto modo di riferire ai Pubblici ministeri e nel processo Pecorelli, posso dire che, senza che io affrontassi in alcun modo l'argomento, Buscetta mi disse che in carcere, così aveva saputo, giravano delle carte provenienti dall'on. Moro e che forse poteva procurarsele. Mi fece altresì cenno agli appelli che Moro aveva rivolto al suo mondo politico affinché si attivasse per la sua liberazione. Ovviamente riferii queste circostanze a Formisano, che si mostrò molto interessato alla questione di queste carte e credo anche a Don Cesare perché, per la confidenza e la stima che avevo di lui, gli
raccontavo tutto; Don Cesare era veramente sofferente per il destino dell'on. Aldo Moro, che credo conoscesse personalmente». Bossi ha poi sottolineato che «il maresciallo Incandela aveva stretti rapporti con Buscetta, certamente nell'ambito dei compiti che gli erano stati affidati, tant'è vero che, come seppi da Buscetta e dalla moglie di questi, faceva uscire dal carcere la corrispondenza di carattere privato dello stesso Buscetta».
L'attivazione di Bossi e l'iniziativa di Formisano erano, a suo tempo, già state approfondite, anche nell'ambito del cosiddetto processo Andreotti/Pecorelli, come ampiamente illustrato nella sentenza di appello (4/2002 del Tribunale di Perugia). In quella sede emerse la buona fede di Formisano, che discusse di quelle possibilità con Claudio Vitalone, formalmente solo magistrato, ma sostanzialmente personalità vicina al Presidente del Consiglio Andreotti. Emersero pure alcuni riscontri del rapporto Dalla Chiesa - Pecorelli - Incandela, che corrispondono a quanto recentemente dichiarato dallo stesso Incandela alla Commissione. La testimonianza di Incandela fu invece valutata con numerose riserve al processo Andreotti di Palermo.
Il maresciallo Incandela è scomparso il 15 giugno 2016, pochi mesi dopo la sua audizione dinanzi ai rappresentanti della Commissione. Il suo racconto, originato direttamente dalla sua esperienza di sottufficiale al servizio dello Stato in una fase molto delicata, scevro da ragioni di interesse passate o attuali, può essere considerato dal punto di vista soggettivo del tutto attendibile ed è stato corroborato da numerosi elementi di riscontro(20). Può dunque in sede di prime conclusioni affermarsi che il tentativo da un lato di aprire "canali paralleli" rispetto a quelli istituzionali sia stato più intenso di quanto sinora conosciuto e che d'altro lato, su altri fronti, fosse ritenuta un'assoluta necessità politica reperire qualsiasi documento proveniente dalla prigionia dell'on. Moro. Ciò anche al fine di prevenire e contrastare le reazioni negative
che, da una eventuale pubblicità integrale data dalle Brigate Rosse a tali documenti, potessero conseguire
Sempre relativamente alle tracce dei contratti attivati all'interno del carcere di Cuneo, su impulso dell'onorevole Craxi e tramite l'appoggio interno del maresciallo Incandela, è stato più volte sentito da consulenti della Commissione Raffaello "Lello" Liguori.
Lello Liguori, proprietario del "Covo di Nord est" di Santa Margherita Ligure e dello "Studio 54" a Milano, imprenditore nel campo dei locali e della musica, è stato un personaggio di rilievo negli anni '70 e '80 in quanto la sua attività lo aveva messo in contatto con il mondo dello spettacolo italiano e internazionale, con numerosi esponenti politici e anche con soggetti legati al mondo della criminalità organizzata che frequentavano alcuni dei moltissimi locali che egli aveva gestito in ogni parte d'Italia(21).
La prima deposizione di Lello Liguori ha avuto luogo il 12 luglio 2017 e contiene circostanze inedite in merito a due "missioni" che gli erano state affidate.
Liguori ha innanzitutto ricordato che i suoi «legami più stretti nell'ambiente politico erano con Bettino Craxi ed il suo entourage, tra cui Martelli, Pillitteri e Tognoli, già sindaco di Milano. I rapporti con questi ambienti erano professionali ma anche molto amicali ed ero in legami di amicizia con tutta la famiglia di Craxi»
In merito alla suo coinvolgimento nella vicenda Moro ha affermato: «In merito ai tentativi di liberare l'on. Moro, posso dire che anch'io vi presi parte incaricato di una missione specifica. Mi fu chiesto di recarmi presso il carcere di Cuneo e di prendere contatti con un maresciallo degli Agenti di custodia a nome Incandela. In questo modo avrei potuto parlare con Turatello per sollecitarlo a prendere tutte le iniziative possibili muovendo il suo ambiente, compreso quello della Magliana. Il mio contatto con Turatello poteva essere facilitato dal fatto che io già lo avevo conosciuto nell'ambiente dei locali a Milano. Addirittura una notte avevo avuto una lite con lui fuori dal locale "Ciao Ciao" di via Merlo. Io non avevo avuto paura a scontrarmi fisicamente con lui e, benché avessi avuto la peggio, avevo mostrato di non avere paura e per questo Turatello mi aveva mostrato rispetto.Ero anche incaricato di parlare con Renato Curcio
utilizzando il fatto che io nei miei locali avevo dato spazio ai Centri sociali e passavo un po' per una persona di sinistra, anche perché mia figlia Monica frequentava il Leoncavallo... avevo anche fatto delle interviste a Radio Popolare. Gestivo insieme ad alcuni elementi dell'Autonomia, ricordo Arcaini e Bruno Chiodi, il locale "Il Punto rosso" in piazzale Lagosta».
Liguori ha poi riferito che «con Incandela parlai poco ma comunque mi disse che prima di me erano venuti Ugo Bossi e Franchino Restelli, personaggi di spicco della malavita milanese, legati a Turatello». Liguori ebbe poi un colloquio sia con Turatello che con Curcio: «Parlai prima con Turatello e poi con Curcio. [...], Turatello mi disse che per avere notizie sul luogo di prigionia era necessario che io parlassi con quelli della banda della Magliana. Io da parte mia portavo l'ambasciata secondo cui nel caso che fosse stato raggiunto un risultato positivo sarebbe stato aiutato sul piano giudiziario.
Dopo l'incontro con Turatello parlai con Renato Curcio che si trovava in un'altra cella sullo stesso piano. Curcio fu molto più sulla difensiva e ricordo una frase sua un po' di scherno del tipo "tu vieni perché ti presenti come una persona di sinistra ma lo so che non sei dei nostri"». Rientrato da Cuneo, Liguori informò poi Craxi dell'esito della missione.
Alla missione a Cuneo ne era seguita, sempre su richiesta di Craxi, una seconda, anch'essa sinora sconosciuta. Liguori ha riferito che «Craxi mi diede anche appuntamento a Roma, all'Hotel Raphael perché mi disse che doveva parlarmi di alcune cose. Quindi dopo questo primo incontro a Milano rividi Craxi a Roma, mi fece fermare all'Hotel Raphael, ricordo che affittai una stanza sotto quello che era di fatto l'ufficio di Craxi, si trattava di una suite in cui dormì anche l'architetto Filippo Panseca. Craxi quella sera invitò a cena tutti e due, poi disse a Panseca che doveva parlarmi di cose riservate e Panseca si allontanò.
Rimasti soli, Craxi mi disse che avrei dovuto andare con due persone di sua fiducia a fare un sopralluogo in un appartamento che poteva essere stato la prigione di Moro. Voleva che ci fosse la mia presenza perché si fidava di me dato che lo avevo aiutato già in diverse occasioni».
La missione si sarebbe così svolta: «Il giorno dopo, in mattinata, vennero a prendermi al Raphael due persone mandate da Craxi che potevano essere poliziotti od ex poliziotti del gruppo di persone che egli aveva mosso per portare avanti la sua iniziativa. Mi accompagnarono in auto, con un'Alfetta e raggiungemmo nel giro di 15 -20 minuti un palazzo moderno, di 5-6 piani. Salimmo in un appartamento o al primo o al secondo piano. Uno dei due che mi accompagnavano aprì la porta d'ingresso con quello che mi sembra fosse un passepartout. Ci trovammo in un appartamento completamente vuoto di mobili, di due stanze e servizi. Mi portarono subito nella seconda stanza dove, toccando, sentii che c'era una parete di cartongesso dietro la quale doveva esserci uno spazio vuoto. Rimanemmo in quell'appartamento pochissimi minuti anche per ragioni di sicurezza. Tornato al Raphael, riferiì a Craxi che effettivamente secondo me in quell'appartamento
c'era un vano utilizzabile per un sequestro».
Liguori ha precisato che l'accesso avvenne «quando Moro era ancora vivo poiché avvenne durante i tentativi di Craxi per ottenerne la liberazione». L'appartamento descritto da Liguori non è stato ancora identificato ma comunque il testimone ha fornito qualche altro dettaglio in una seconda deposizione, in data 7 settembre 2017. In questa occasione ha dichiarato che «in relazione all'accesso presso l'appartamento che poteva essere collegato al sequestro di Aldo Moro e che effettuai su richiesta dell'On. Craxi devo aggiungere che in realtà oltre alle due persone che ritengo poliziotti o uomini dei Servizi e che avevano compiti esecutivi c'era una terza persona con il ruolo chiaramente di capo in quanto dava loro ordini e in pratica, in quel contesto, li ha dati anche a me. Costui non si è presentato, ma ritengo fosse un funzionario del Ministero dell'Interno di un certo livello.Era sui 30-36 anni, capelli
castani, alto, robusto, di origine sicula, ho capito dalla sua particolare inflessione che era del catanese. Quando giungiamo nell'appartamento ed io tastai il muro per vedere se c'era una parete di cartongesso che potesse occultare un nascondiglio, il funzionario che ho ricordato mi riprese perché mi disse che pur avendo i guanti si potevano lasciare delle tracce».
In seguito Liguori chiese a Craxi informazioni su questo funzionario: «Gli chiesi se lavorava ancora con lui e Craxi mi rispose che dopo qualche giorno da quell'accesso non aveva lavorato più per lui. In pratica in quel periodo disponeva di un gruppo di poliziotti che lavorava direttamente per lui nell'ambito delle attività di tutela della sua persona. Diversamente da quanto mi sembrava di ricordare l'appartamento non era completamente vuoto, ma c'era un tavolo con qualche sedia. Voglio anche aggiungere che ho saputo con certezza che in quell'appartamento era entrato per i medesimi miei scopi Franco Restelli, esponente di spicco della criminalità milanese, in particolare in quel periodo in cui Turatello era in carcere e di fatto Restelli fungeva da suo sostituto».
Liguori ha precisato in proposito che «Franco Restelli oltre ad essere ovviamente molto legato ai F.lli Bossi era in stretto contatto con la malavita romana della Magliana ed in particolare era in contatto con Danilo Abbruciati che quando veniva a Milano dormiva nella villa di Califano in zona Piazza Tricolore. Quindi il Restelli aveva saputo dell'appartamento da quelli della Magliana».
Per quanto attiene all'identificazione dell'appartamento, il testimone ha riferito altri dettagli, compresa la zona di Roma in cui esso cui si trovava, nella deposizione in data 25 settembre 2017: «In relazione all'episodio dell'appartamento posso solo aggiungere che il "capo" era armato di una machine pistole, cioè un mitra corto e anch'io avevo due rivoltelle calibro 38 avendo regolare porto d'armi. Gli altri avevano pistole calibro 9 di quelle in dotazione alla Polizia. L'appartamento comunque era in periferia nella zona della via Cassia che conoscevo abbastanza bene perché lì aveva la sua casa di produzione Riccardo Schicchi».
Il testimone ha infine spiegato che le due "missioni" così delicate che gli erano state affidate discendevano dagli stretti rapporti di fiducia che si erano instaurati con l'onorevole Craxi sino a portarlo con gli anni a situazioni di reciproca collaborazione. Ad esempio era stato proprio Liguori ad avvisare Craxi del progetto di attentato (o di attentato simulato) organizzato ai suoi danni a Milano da Ugo Filocamo finalizzato in realtà ad aiutare la posizione di Turatello.
In conclusione può affermarsi che durante i giorni del sequestro Moro, l'onorevole Craxi, oltre a prendere pubblica posizione politica in favore di una trattativa volta a ottenere la liberazione dell'ostaggio, si era impegnato a mettere in campo una task force impegnata ad attivare tutti i contatti possibili e a svolgere un'indagine parallela, conscio dell'importanza politica che per il suo partito avrebbe avuto una liberazione di Moro frutto delle iniziative di parte socialista.
9.2. Ulteriori presenze in via Monte Nevoso
In relazione alle indagini su una possibile circolazione delle carte di Moro, di cui sono state evidenziate tracce nella vicenda del covo brigatista di via Fracchia, la Commissione ha approfondito una recente acquisizione della Polizia. Nell'ambito di attività di polizia scientifica, rese possibili da nuove tecnologie, è stata attribuita un'impronta, precedentemente ritenuta non utile, reperita su una pagina del "Corriere della sera" del 7 settembre 1978, utilizzata, insieme ad altri fogli di giornale, per avvolgere diverse armi che sono state rinvenute il 9 ottobre 1990 a Milano, nell'appartamento di via Monte Nevoso 8, già covo delle Brigate rosse. Un'altra impronta era stata già attribuita, nel 2004, a Calogero Diana, di cui pure non era nota una frequentazione del covo di via Monte Nevoso.
L'impronta è stata attribuita a Valerio De Ponti, brigatista della Colonna milanese condannato per banda armata nel 1979 e poi nel 1981, in seguito dissociatosi.
In proposito, De Ponti è stato escusso da collaboratori della Commissione e ha affermato che «da quanto io rammenti circa la mia militanza dell'epoca posso affermare con certezza che non ho mai frequentato l'appartamento di via Monte Nevoso 8 di cui all'epoca ignoravo l'esistenza. Non ero assolutamente a conoscenza della base, anche perché all'epoca era molto rigida la "compartimentazione"».
De Ponti ha chiarito che, in quella fase, si era riavvicinato alle Brigate rosse, dopo l'estate del 1978, e ha aggiunto, a proposito del giornale che «non so spiegarmi come sia arrivato li. Certo è che noi utilizzavamo i quotidiani per le nostre attività di inchiesta e di analisi. Credo che si possa ipotizzare che sia passato di mano, magari mi sono incontrato con qualcuno dell'organizzazione in un bar, o in altro posto ove si facevano le riunioni e magari gli ho lasciato il giornale o letto il giornale di altri. Io in quella data ero clandestino. Per quanto riguarda il covo di via Monte Nevoso, ovviamente sono a conoscenza della caduta del covo e degli arresti del 1 ottobre 1978, nulla conosco circa il rinvenimento dell'intercapedine del 9 ottobre 1990»
Anche se non conclusive, le indagini compiute inducono dunque a ipotizzare che la frequentazione del covo di via Monte Nevoso da parte di brigatisti potrebbe essere stata più vasta di quanto accertato. In ambito brigatista potrebbero dunque ancora acquisirsi ulteriori indicazioni sulla nota vicenda delle carte di Moro reperite nel covo milanese.
9.3. Altri percorsi per liberare Moro: le dichiarazioni di Umberto Giovine e Aldo Bonomi
Un ulteriore contributo alla conoscenza delle iniziative avviate, sotto la direzione dell'onorevole Craxi, per stabilire un contatto con i rapitori di Moro e sondare le possibilità di una trattativa che coinvolgesse anche i brigatisti del nucleo storico detenuti, è giunto da Umberto Giovine. Questi, sin dalla giovinezza era stato iscritto al PSI, militando nella federazione milanese, aveva avuto incarichi nell'ambito dell'Internazionale socialista ed era divenuto alla fine degli anni '60 direttore di "Critica Sociale". Era inoltre persone legata a aree socialiste fortemente impegnate su un terreno internazionale, tanto che fu imputato di un dirottamento aereo compiuto in Francia in opposizione alla dittatura dei colonnelli greci.
Umberto Giovine è stato inizialmente sentito da un consulente della Commissione al quale ha dichiarato che: «l'input per cercare d'intervenire nella vicenda Moro per salvare la vita del sequestrato avvenne qualche giorno dopo il sequestro, a Torino, durante il congresso del Psi. Ebbi modo di parlare con Walter Tobagi che conoscevo da molti anni e mi disse che secondo lui avrei potuto e dovuto fare qualcosa attraverso "Critica Sociale" visto che lui personalmente, data la sua posizione al Corriere della Sera non poteva agire».
Secondo quanto da lui dichiarato, Giovine accettò e inizialmente operò con Tobagi: «Sempre a Walter Tobagi venne l'idea di coinvolgere l'avvocato Giannino Guiso malgrado costui si fosse pronunciato in una intervista contro la trattativa per la liberazione dell'onorevole Moro. Io e Tobagi valutammo che avrei potuto convincerlo a passare sulle nostre posizioni, grazie anche al fatto che Guiso era in buoni rapporti con Craxi. Il contatto per parlare con Giannino Guiso fu rappresentato da Aldo Bonomi, figura molto particolare e ambigua [...]. La linea che ci eravamo proposta e che sembrava fattibile, oltre all'obiettivo generico di raccogliere attorno a Critica Sociale il maggior numero possibile d'intellettuali, laici e cattolici favorevoli alla trattativa, era quella di creare un ambito favorevole ad una mitigazione del trattamento carcerario dei brigatisti detenuti, nel contempo però facendo in modo che essi, non direttamente
partecipi al sequestro di Moro, si esprimessero pubblicamente per la sua liberazione. Tutto questo in modo assolutamente indipendente ed anzi eludendo la posizione del Governo che secondo noi avrebbe continuato a manifestare un'assoluta chiusura. Questa attività milanese era speculare ad un'attività con le medesime finalità e medesimi contenuti, una vera trattativa, che era stata avviata a Roma dal segretario Craxi. Craxi poteva contare sull'appoggio e il contributo del generale Dalla Chiesa che era responsabile nazionale delle carceri di massima sicurezza e che in tale veste poteva muoversi anche in modo indipendente e specifiche autorizzazioni del Governo. In quelle settimane non ebbi incontri personali con Craxi ma solo colloqui telefonici protetti in quanto lo chiamavo nel ristorante dove andava a pranzo o a cena. Infatti come ho già avuto modo di riferire alla Commissione stragi nel 1998 io stesso ero sorvegliato nella mia abitazione di
via Manuzio a Milano e avevo notato più volte una macchina civetta dei Carabinieri sotto casa».
Secondo Giovine: «La nostra azione si sostanziò con colloqui dell'avvocato Guiso con Curcio e credo altri detenuti di quell'area per cercare di portarli sulle nostre posizioni. Era stato preparato anche un incontro tra Guiso e i giornalisti all'uscita del carcere, quello di Torino, dopo un colloquio di Guiso con i detenuti. In quel momento Guiso con qualche battuta anche senza esporsi e anche solo intrattenendosi con me avrebbe dovuto veicolare il messaggio di disponibilità dei brigatisti detenuti ad accettare una soluzione come quella che auspicavamo e cioè che Moro fosse salvato, e nel contempo vi fosse un trattamento meno duro nei confronti dei brigatisti in carcere. Garante riservato di quest'ultimo aspetto avrebbe dovuto essere il generale Dalla Chiesa, un nemico di cui paradossalmente i brigatisti apprezzavano le qualità e lo ritenevano un interlocutore affidabile». L'iniziativa non aveva però avuto
successo: «Purtroppo quando Guiso uscì dal carcere non riuscì neanche minimamente col suo comportamento e nonostante le indicazioni ricevute a portare questo messaggio, rimase zitto e impacciato. Fu persa quell'occasione che se avesse avuto successo avrebbe avuto anche una grande eco mediatica mettendo in moto un meccanismo politico favorevole. Di fatto dopo questo fallimento e tenendo conto che eravamo già ai primi di maggio non ci fu nessun altro tentativo concreto da parte nostra e non sentìi più in proposito l'onorevole Craxi che agiva sul fronte romano».
Giovine ha anche trattato della opaca vicenda di Volker Weingraber, l'agente tedesco che operò in Italia. In particolare, dalle informative originate da Weingraber risulta che egli giunse a Milano nel febbraio 1978 e che fu messo in contatto con diverse persone, tra cui il terrorista Oreste Strano, e con un gruppo che preparava il sequestro di un imprenditore svizzero. L'informativa del 6 novembre 1978 precisava inoltre che la fonte infiltrata «ha avuto contatti con Aldo Bonomi il quale gli avrebbe confermato di essere in grado di procurare armi e documenti falsi per sviluppare attività eversive». La fonte - continua l'informativa - «ritiene che Bonomi sia un provocatore e un confidente della polizia. Sarebbe stato isolato dalle BR perché ha sempre evitato di assumersi compiti rischiosi nell'ambito dell'organizzazione». Risulta inoltre che Weingraber - come confermato dal colonnello Giorgio Parisi al giudice
Priore il 28 settembre 1990 - entrò in contatto, tramite Strano, anche con Nadia Mantovani, cioè la persona che stava battendo a macchina il memoriale Moro. Va pure, infine, segnalato che Weingraber, forse per una casualità, venne ad abitare in Italia nello stesso palazzo dove abitava Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980.
Giovine ha dichiarato in proposito: «premetto che Aldo Bonomi, personaggio legato sicuramente a più ambienti, si era presentato a noi come l'estensore del famoso libro di controinformazione La strage di stato. Tale notizia non era verificabile ma tendeva a creare un suo forte accreditamento come del resto facevano i suoi rapporti con la sinistra tedesca, come ad esempio con Petra Krause. Fu lo stesso Bonomi ad indicarci la libreria Calusca di Primo Moroni sita in corso di porta Ticinese come uno dei punti in cui i comunicati delle BR, e quindi anche le lettere di Moro, pervenivano prima ancora che alla stampa o agli organi di polizia. Fu questo un particolare che verificammo personalmente.
Fu proprio Aldo Bonomi a presentarci Weingraber e a raccontarci la sua storia. Un giorno Weingraber si presentò a casa di Augusto Zuliani in via Solari mettendo sul tavolo una Smith &Wesson ben oliata. Bonomi aveva precedentemente spiegato che si trattava di un compagno tedesco di area anarchica molto amico di Petra Krause e che aveva bisogno di un alloggio. Di fatto Weingraber prese possesso della casa di via Solari che in quel periodo aveva funzionato un po' come una comune con vari ospiti di passaggio. Weingraber riuscì anche a farsi finanziare dalla moglie di Zuliani per l'acquisto di un casale in Toscana. A quel punto inoltre egli si propose come autore di un articolo o di qualche collaborazione per Critica Sociale. Il personaggio non convinse né me né mia moglie, legata al mio stesso mondo politico. Weingraber insisteva inoltre per avere da noi copie delle lettere di Moro che in parte provenivano dalla Calusca, e
qualcuna da Bonomi. Voleva tradurle in tedesco e accreditarsi in Germania. Preciso che tramite queste vie avevamo avuto queste lettere prima che diventassero note ma non ve n'erano di più e diverse da quelle che poi furono ufficialmente acquisite dagli organi di polizia. Non eravamo comunque gli unici ad averle».
Umberto Giovine è successivamente stato sentito in audizione dinanzi alla Commissione il 19 ottobre 2016 e ha sostanzialmente confermato l'intera vicenda. Ha in particolare riferito che nel corso del sequestro gli pervennero, per il tramite di ambienti vicini alla libreria Calusca di Milano e di Aldo Bonomi, copie di lettere dattiloscritte di Moro non ancora rese note. Giovine ha in particolare precisato che furono almeno tre, tutte pervenute successivamente al 18 aprile 1978, e ha dichiarato che, ogni volta che entrava in possesso di una di queste lettere, la trasmetteva a Craxi, il quale decideva se diffonderne subito il contenuto tramite le agenzie di stampa.
Sulla base delle dichiarazioni di Umberto Giovine è stato sentito, inizialmente da un consulente della Commissione, Aldo Bonomi, attivo negli anni '70 nel gruppo di "Controinformazione", e quindi in contatto con il variegato mondo della sinistra extraparlamentare anche nelle sue derive terroristiche. Aldo Bonomi ha confermato nelle sue linee essenziali il racconto di Umberto Giovine.
Ha infatti dichiarato che «Giannino Guiso è stato il mio avvocato per tutto il corso del procedimento di Controinformazione. I rapporti con lui sono proseguiti anche in seguito e sono diventati di grande amicizia. [...] Nel contesto di discussione che si sviluppò subito dopo il sequestro Moro e che vedeva coinvolti sia ambienti socialisti sia ambienti cattolici Umberto Giovine, anche tramite me e mia moglie che lavorava proprio a "Critica Sociale" e cioè la rivista di Giovine, entrò in contatto con Guiso. Certamente sviluppò con lui un discorso finalizzato a trovare qualche spazio di trattativa e mi sembra che a un certo punto Guiso entrò direttamente in contatto con Craxi con cui probabilmente non aveva rapporti in precedenza. È possibile che all'interno di questo discorso si sia prospettato di ottenere un segnale da parte dei brigatisti detenuti favorevole alle liberazione di Moro tenuto conto
appunto che Guiso ne difendeva molti e proprio in quel periodo era in corso un importante processo a Torino. Non sono al corrente delle specifiche mosse di Guiso anche se certamente si mosse in questo senso. Da un punto di vista politico un messaggio dall'interno del carcere poteva avere un significato anche se, nella logica delle Brigate Rosse, certo non erano i detenuti a decidere sulla sorte di Moro. Credo tuttavia che quel messaggio non venne nonostante i tentativi di Guiso».
Nell'audizione presso la Commissione del 18 ottobre 2017 Bonomi è stato più preciso. Dopo aver rievocato i tratti della sua militanza nei movimenti extraparlamentari e in "Controinformazione" ed aver escluso di aver agito come infiltrato in ambienti estremistici, ha confermato la circolazione, nel loro gruppo milanese, di fotocopie di lettere di Moro che provenivano verosimilmente da Guiso e che furono trasmesse a Craxi, venendo a costituire una base per le successive trattative gestite direttamente da Craxi.
La notizia, come si vede, è di grande rilievo e conferma l'importanza dei tentativi attuati su impulso di Craxi, ma anche l'esistenza di canali di circolazione diversi da quelli, da tempo accertati, che avvenivano per il tramite di Morucci e Faranda.
Va peraltro sottolineato che Guiso, oltre a mantenere rapporti con i brigatisti del "nucleo storico" incarcerati, lanciò spesso dei segnali importanti. Colpisce ad esempio la sincronia tra le iniziative assunte da Giovannone con i palestinesi - che hanno un'importante riscontro nelle stesse lettere di Moro - e la dichiarazione rilasciata da Guiso ai giornalisti il 24 aprile 1978, dopo i suoi colloqui con i terroristi in carcere, quando egli affermò che «come si decise che quei palestinesi [i responsabili dell'attentato di Fiumicino] potevano andarsene all'estero, così si potrebbe decidere per le tredici persone di cui parla il documento numero 8»(22).
9.4.Ulteriori accertamenti sulla "trattativa" della Santa Sede.
Già nella precedente relazione si era dato conto di alcuni accertamenti compiuti, sulla base delle dichiarazioni rese in audizione da monsignor Fabio Fabbri, intorno alla vicenda dei tentativi della Santa Sede di promuovere una trattativa sulla vita di Moro. In quella sede era stato confermato il ruolo centrale di monsignor Cesare Curioni, responsabile dei cappellani carcerari, che attivò molteplici contatti, sia con brigatisti in carcere sia con un ingnoto intermediario.
Fabbri ha dichiarato di non aver conosciuto né incontrato l'intermediario con cui Curioni trattava, ma di ritenere - per via di alcuni accenni - che l'interlocutore fosse mandato dalle Brigate rosse. Ha precisato che gli incontri - almeno uno a settimana - avvenivano previ contatti telefonici, e avevano luogo prevalentemente nella metropolitana di Napoli e in qualche caso nell'Italia settentrionale.
Fabbri ha inoltre dichiarato di aver visto, il 6 maggio 1978, nella residenza pontificia di Castel Gandolfo, le mazzette di dollari messe a disposizione per il riscatto, del valore di circa dieci miliardi di lire, appoggiate sopra un tavolo e coperte da un panno di ciniglia azzurra. Secondo Fabbri le mazzette recavano la fascetta di una «banca ebraica».
Fabbri ha poi riferito che, grazie alle fonti che Curioni aveva nel carcere di San Vittore e che comprendevano l'avvocato Guiso, lo stesso Curioni ricevette dall'intermediario delle Brigate rosse, alcune fotografie di Moro prigioniero.
La prima fotografia, secondo monsignor Fabbri, fu mostrata a Paolo VI, il quale ritenne che l'immagine non garantisse che Moro era vivo. Per questo motivo - ha riferito l'audito - fu successivamente scattata una seconda foto nella quale Moro aveva in mano il quotidiano "la Repubblica" del giorno. In entrambi i casi Curioni e Fabbri portarono personalmente al Pontefice le fotografie, di cui Fabbri dichiara di ignorare il destino.
Fabbri ha poi smentito alcuni articoli di stampa in cui si afferma che Curioni era con Paolo VI e con Macchi nell'appartamento papale la sera del 21 aprile 1978 e che partecipò materialmente alla stesura della lettera del Papa «agli uomini delle BR». Per quanto egli ricorda, infatti Curioni era nella sua casa di Asso, in Lombardia, dove - dopo la mezzanotte - ricevette una telefonata del Pontefice, che gli lesse il testo dell'appello per avere un suo riscontro in merito. La situazione rimase tuttavia aperta fino alla fine, tanto che, secondo quanto riferito da Fabbri, l'8 maggio 1978 la Santa Sede era in attesa di un segnale positivo per il rilascio di Moro, che poi non arrivò.
Ha infine affermato che Curioni dedusse, dalle fotografie dell'autopsia di Moro, che il modus operandi dell'assassino di Moro era quello tipico di un criminale di professione, da lui conosciuto al carcere minorile Beccaria di Milano.
Questa ricostruzione, che pure lascia aperte numerose questioni, è stata approfondita anche con diverse audizioni. In particolare, nell'audizione del 4 ottobre 2017, Gianni Gennari, che all'epoca dei fatti era assistente spirituale di Benigno Zaccagnini e in relazione con diverse personalità della politica e della Chiesa, come Antonio Tatò e Cesare Curioni, ha ridimensionato la vicenda dell'intermediario, dichiarando di aver raccolto da Curioni la confidenza che questi non era una persona particolarmente affidabile. Ha inoltre affermato che Curioni gli disse di aver partecipato materialmente alla stesura della lettera del Papa «agli uomini delle Brigate rosse», e che l'espressione «senza condizioni» era presente nella lettera fin dalla prima stesura. Gennari non ricorda peraltro se la partecipazione di Curioni avvenne telefonicamente - come affermato da monsignor Fabio Fabbri - o con la sua presenza fisica in
Vaticano.
Ha infine affermato che Curioni gli espresse l'impressione che sul cadavere di Moro ci fosse un solo colpo sparato a bruciapelo su Moro vivo, che aveva lasciato l'alone caratteristico di bruciatura e mostrava il sangue che ne era fuoriuscito, mentre tutti gli altri colpi, una decina, fossero stati sparati a distanza maggiore e dopo parecchio tempo,
L'audizione - in forma segreta - di altra persona in relazione con monsignor Curioni ha integrato questa indicazione, con l'informazione che, proprio sulla base dell'osservazione dei colpi inferti a Moro, Curioni avrebbe dedotto che l'uccisore di Moro sarebbe stato Giustino De Vuono.
Gli accertamenti condotti dalla Commissione in relazione a questa convinzione soggettiva di una personalità certo non superficiale come monsignor Curioni, espressa a diverse persone in relazione con lui, non hanno consentito di trovare riscontri probanti di un ruolo di De Vuono nel sequestro Moro, che peraltro fu evocato già all'epoca dei fatti. Se infatti gli spostamenti di De Vuono - allora latitante - tra l'Italia e l'America del Sud sono compatibili con una sua presenza in Italia nel periodo del sequestro, non sono stati rinvenuti elementi certi a sostegno di una sua diretta partecipazione al sequestro Moro. La Commissione ha inoltre accertato - delegando specifiche attività all'Arma dei Carabinieri - che, contrariamente a quanto affermato in sede giornalistica, risulta accertato che De Vuono morì nel penitenziario di Carinola nel 1994.
Rimane tuttavia l'interrogativo rappresentato dall'appunto del Centro informativo della Guardia di finanza di Roma consegnato al Ministro dell'interno la sera del 17 marzo 1978. Nell'appunto, si relazionavano le notizie acquisite da una "fonte confidenziale degna di fede" che aveva riferito sulla presenza di Giustino De Vuono (insieme a Lauro Azzolini e Rocco Micaletto) nella capitale e della probabile presenza del sequestrato in una prima prigione munita di un garage collocata a breve distanza dai via Fani. Una zona che, nei due appunti successivi originati dalla stessa fonte, veniva circoscritta alla zona Monte Mario e cioè la zona ove si trovano via Licinio Calvo e via Massimi.
Il lavoro della Commissione si è quindi appuntato, visti i riferimenti sia a De Vuono sia alla zona di via Massimi, sul tentativo di individuare la fonte che aveva contattato il Centro informativo della Guardia di finanza.
Purtroppo l'ufficiale che aveva avuto il contatto, individuato nel capitano Renato Mancusi, è da tempo deceduto.
L'audizione dei suoi colleghi che è stato possibile rintracciare ha tuttavia fornito elementi significativi. Le notizie erano state effettivamente acquisite dal capitano Mancusi pochissime ore dopo il sequestro, forse già la stessa mattina del 16 marzo, la fonte era già conosciuta dal sottufficiale, vi erano stati più incontri uno dei quali nei pressi dell'abitazione del capitano Mancusi. La fonte era probabilmente una persona gravitante in un ambiente vicino a quello brigatista.
Restano quindi aperte domande in merito alla presenza di De Vuono in quei giorni Roma e in merito al primo rifugio nei pressi di via Fani in cui Moro potrebbe essere stato portato, ricerca oggetto di un complesso lavoro di indagine della Commissione.
9.5. La visita di un sacerdote ad Aldo Moro durante la prigionia e le affermazioni di Michele Galati
Un altro tema che ha posto interrogativi mai risolti è quello che concerne i rapporti, nei giorni del sequestro, tra la famiglia Moro e i suoi carcerieri, l'esistenza cioè di un "canale di ritorno" che consentisse a Moro di ricevere lettere dalla famiglia e al prigioniero di rispondere coinvolgendo anche altri interlocutori e anche la possibilità che durante la prigionia l'onorevole Moro avesse ricevuto una visita di conforto da parte di un sacerdote appartenente all'ambiente ecclesiastico che egli frequentava.
Senza qui ripercorre il considerevole numero di atti giudiziari e la vasta pubblicistica(23) che ha cercato di rispondere a questi interrogativi, può affermarsi che il lavoro della Commissione ha consentito, forse per la prima volta, di acquisire un apporto dichiarativo concreto in merito alla visita ricevuta dal prigioniero, già evocata - come personale riflessione - da Francesco Cossiga in più dichiarazioni.
Fonte di tale apporto conoscitivo è Michele Galati già appartenente all'area della Controinformazione di Verona e poi al comitato regionale Veneto delle Brigate rosse, coinvolto in numerosi gravi episodi tra cui l'omicidio del dirigente della DIGOS di Venezia Alfredo Albanese e il sequestro del generale Dozier e divenuto dopo il suo arresto, all'inizio degli anni '80, collaboratore di giustizia.
Michele Galati sia nel periodo della detenzione in carcere in sezioni adibite ai collaboratori di giustizia sia dopo la sua scarcerazione, aveva intrattenuto rapporti piuttosto intensi con Valerio Morucci, condividendo con lui anche una parte del percorso di reinserimento e lavorativo.
Nel corso di un colloquio intervenuto con un consulente della Commissione in data 28 dicembre 2016(24), Michele Galati ha fatto sul tema della visita a Moro esplicite affermazioni che qui si riportano in sintesi.
L'onorevole Moro aveva effettivamente ricevuto la visita di un sacerdote nel periodo della sua prigionia. Dopo contatti tra il dottor Freato, rappresentante della famiglia, ed emissari dei brigatisti, il sacerdote era stato prelevato dai brigatisti in un luogo convenuto e portato nel covo, dopo che gli erano stati fatti indossare occhiali con lenti schermate affinché non vedesse ove veniva portato ma nel contempo sembrasse un comune sacerdote in visita. Si era trattenuto con l'ostaggio per circa un quarto d'ora e lo aveva confessato. La visita era avvenuta in una fase del sequestro in cui vi erano ancora speranze che Moro fosse liberato e quindi era stato di conforto ma non era l'ultima visita ad un morituro. Era stato Mario Moretti a decidere autonomamente che tale incontro potesse avvenire, senza coinvolgere nella decisione la direzione strategica La famiglia Moro era pienamente al corrente di quanto avvenuto, essendo stata anche informata da
Morucci e Faranda, ma non ha mai voluto rivelarlo.
Galati ha inoltre affermato che esisteva un secondo covo pronto il giorno del sequestro qualora il primo covo per qualsiasi incidente o ragione non fosse stato immediatamente utilizzabile. Questo rifugio era gestito da una ragazza.
Le esatte e complete circostanze di questo episodio, che era rimasto sinora nel campo delle "dicerie" e delle ipotesi, devono essere ancora approfondite e costituiscono uno dei temi su cui proseguirà, pur nei tempi ristretti disponibili, il lavoro della Commissione.
9.6. La proposta di grazia in favore di Paola Besuschio
Un altro tema già parso meritevole di approfondimento è quello, più volte emerso ma mai completamente esplorato, del progetto, originato dal Presidente della Repubblica Leone, di concedere la grazia ad una brigatista detenuta non di altissimo livello, Paola Besuschio, confidando che tale gesto autonomo di clemenza da parte dello Stato potesse favorire la liberazione dell'ostaggio. Tale progetto sarebbe stato bloccato, proprio mentre era in via di perfezionamento, poche ore prima dell'assassinio di Aldo Moro
Un importante contributo su tale tema è pervenuto dal giornalista Francesco Damato, direttore per alcuni anni del quotidiano "Il Giorno" e tuttora collaboratore di vari quotidiani tra cui "Il Dubbio", quotidiano quest'ultimo per il quale l'8 aprile 2017 ha pubblicato un articolo dedicato proprio al progetto di grazia in favore di Paola Besuschio.
Sentito da collaboratori della Commissione il 3 maggio 2017, il giornalista ha fornito la seguente ricostruzione: «Nel 20º anniversario della strage di via Fani, telefonai al senatore Giovanni Leone chiedendogli un'intervista. Preciso che con l'ex Presidente avevo un rapporto di amicizia di lunga data. Fui ricevuto a casa sua in zona Cassia località Le Rughe in presenza della moglie. Stetti con lui oltre due ore e rispose a tutte le mie domande, consultando ripetutamente fogli dattiloscritti ed un'agenda per ricordare meglio le circostanze che mi andava riferendo.
Per prima cosa mi riferì di aver convocato il giorno dopo il sequestro Moro, l'allora segretario della DC Zaccagnini, con cui non aveva rapporti da tempo, per manifestargli tutto il suo dissenso di uomo, penalista e Presidente della Repubblica, dalla linea della fermezza annunciata in un comunicato del partito quasi contemporaneamente con un analogo del Partito Comunista.
Zaccagnini non ebbe alcuna reazione. Si limitò a prenderne atto e si accomiatò. Leone mi raccontò che nei giorni successivi notò un cambiamento di clima attorno lui, spesso non gli venivano recapitatiti gli abituali "mattinali" dei Servizi che ricevono solitamente il Capo dello Stato, il Capo del Governo e il Ministro dell'Interno.
Ogni tanto riceveva telefonate di rassicurazioni dal Presidente del Consiglio Andreotti e dal Ministro dell'Interno Cossiga, sull'espletamento di tutti i tentativi necessari per scoprire il luogo ove Moro fosse rinchiuso».
In seguito Leone fu chiamato dall'ex Capo di gabinetto di Moro, consigliere di Stato Manzari, che lo supplicò di fare qualcosa per salvare la vita del comune amico Aldo Moro e si incaricò, di fronte alla sua disponibilità, a promuovere una riunione con Giuliano Vassalli per studiare le posizioni processuali dei 13 detenuti con i quali le Brigate Rosse avevano proposto uno scambio con l'ostaggio. Le riunioni furono più d'una. Alla fine con perfetta identità di vedute tra Vassalli e Leone si individuò la posizione di Paola Besuschio, compresa nell'elenco degli appartenenti al nucleo storico delle Brigate rosse, perché condannata in via definitiva per terrorismo ma non per reati di sangue ed in cattive condizioni di salute.
Leone avrebbe inoltre precisato a Damato che il suo interlocutore in tema di grazia non era Andreotti, ma il suo ex allievo e amico Francesco Paolo Bonifacio, Ministro di grazia e giustizia, motivo per cui contava sulla sua piena disponibilità. Leone avrebbe riferito di avere chiesto, tramite i Carabinieri, l'individuazione del luogo di detenzione della Besuschio e di averne conosciuta la località solo dopo due o tre giorni. Il Guardasigilli oppose alla disponibilità di Leone la mancanza di una richiesta di grazia dell'interessata per cui fu predisposto un contatto con la Besuschio, mandando un Carabiniere o un appartenente alle Forze dell'ordine. La detenuta oppose un netto rifiuto, di fronte al quale Leone non volle arrendersi, comunicando al Guardasigilli il proposito di cambiare la prassi e di concedere la grazia motu proprio.
A quel punto Leone avrebbe raccontato di avere disposto la materiale preparazione del provvedimento, preoccupandosi solo di aver ottenuto prima un minimo di copertura politica.Tale suo scrupolo fu condiviso da Vassalli che si offrì di chiedere all'amico e segretario del partito socialista, Bettino Craxi. Craxi non ritenne opportuno, proprio a causa della posizione da lui assunta, che gli aveva procurato molte polemiche, di muoversi direttamente, girando pertanto la richiesta di Leone al presidente del Senato, Amintore Fanfani.
L'incontro tra Craxi e Fanfani avvenne nell'abitazione romana di Ettore Bernabei. Fanfani aderì alla richiesta, preannunciando che alla riunione della Direzione nazionale della Democrazia cristiana, già programmata per la mattina del 9 maggio, avrebbe svolto un intervento in cui, senza contraddire in generale la linea della fermezza, anzi approvandola, avrebbe esposto l'opportunità di adeguarsi a una qualsiasi iniziativa che il capo dello Stato avesse ritenuto di dover prendere.
Forte di questo sostegno, Leone fissò con il ministro Bonifacio un appuntamento per le 12 del 9 maggio e cioè dopo la conclusione prevista dell'intervento di Fanfani, nonché della riunione. Leone concluse l'intervista esprimendo tutto il suo dolore per non aver potuto fare in tempo a salvare la vita di Moro ed esprimendo il dubbio, da lungo tempo maturato, che ci fosse qualcuno "troppo ben informato" di quanto gli stesse preparando.
Damato ha riferito che era presente al colloquio con Leone la moglie Vittoria per tutta la durata dello stesso e che avrebbe potuto avere riscontri di quanto appreso in quel colloquio se non avessi compiuto l'errore di sottrarmi all'invito della moglie, uscendo dalla villa, di aiutare l'ex Presidente a riordinare le sue carte e i suoi diari.
Questo il racconto di Francesco Damato. Esiste peraltro un'altra testimonianza in merito al difficoltoso progetto di grazia avviato dal presidente Leone. Si tratta dell'intervista resa il 5 aprile 2008 al giornalista Paolo Cucchiarelli dal regista Pasquale Squitieri(25). Il regista, recentemente deceduto, aveva raccontato al giornalista una versione analoga, anche se molto più sintetica, in merito al progetto di grazia in favore di Paola Besuschio. In particolare Leone aveva raccontato al regista, la sera stessa delle sue dimissioni dal Quirinale, che la grazia in favore di Paolo Besuschio gli era "stata strappata dalle mani" da due alti esponenti politici uno dei quali era Zaccagnini.
Sul tale circostanza è stata posta una domanda anche a Francesco Damato il quale ha dichiarato: «Non ero a conoscenza delle dichiarazioni di Pasquale Squitieri pur avendo conosciuto la persona negli anni in cui fu parlamentare. Squitieri era originario di Napoli e credo quindi che fosse in buoni rapporti di conoscenza con Leone.
Letto l'articolo a firma di Paolo Cucchiarelli con il racconto di Squitieri, faccio notare che l'espressione da lui usata sulla "grazia strappata dalle mani" ad opera di Zaccagnini e Berlinguer è la traduzione metaforica del racconto fattomi (da Leone) sul percorso della grazia: lungo e accidentato a causa delle difficoltà politiche frapposte dai segretari dei due maggiori partiti ad una gestione più umanitaria della linea della fermezza. D'altronde i giornali di quell'epoca riferirono di minacce di crisi di governo espresse da Berlinguer nel caso in cui la linea della fermezza non fosse stata eseguita alla lettera».
Paola Besuschio dal canto suo ha negato di aver ricevuto una visita in carcere di carabinieri o poliziotti inviati dal Ministero di grazia e giustizia e di essere stata informata in qualsiasi modo del progetto di grazia nei suoi confronti(26).
Tuttavia la percepibile mancanza da parte sua di un completo distacco dalle esperienze di quell'epoca - ella era del resto strettamente legata sul piano ideologico e personale a Mario Moretti - induce a ritenere che la sua deposizione sia stata in larga parte elusiva.
La Besuschio era reduce da operazioni chirurgiche che si erano rese necessarie a seguito del colpo di arma da fuoco che l'aveva raggiunta in occasione del suo arresto e quindi le sue condizioni di salute, come ricordato dal testimone Damato, potevano contribuire a giustificare in qualche modo, sotto il profilo delle motivazioni della grazia, l'adozione di un atto di clemenza anche se ovviamente ben diverse sarebbero state le reali motivazioni del provvedimento. In conclusione può ritenersi accertato che nei giorni immediatamente precedenti l'assassinio dell'onorevole Moro fosse incorso una autonoma e concreta iniziativa condotta, con una certa riservatezza, da parte del Presidente della Repubblica Leone volta ad aprire una strada per ottenere la liberazione del compagno di partito, iniziativa che tuttavia si è infranta contro l'atteggiamento delle maggiori forze politiche che non intendevano in nessun modo veniva meno alla scelta della linea
della fermezza.
10. I covi e la morte di Moro
Nell'ambito dell'inchiesta la Commissione ha svolto alcuni accertamenti su due dei covi più importanti del sequestro Moro, quello di via Gradoli e quello di via Montalcini, giudiziariamente riconosciuto come "prigione di Moro". In questo ambito è anche emersa la possibile esistenza di un ulteriore, non conosciuto, covo localizzato in zona Eur, che avrebbe potuto svolgere la funzione di "covo di riserva" rispetto a quello di via Montalcini.
10.1. Accertamenti sul covo di via Gradoli
Facendo seguito alle ulteriori indagini già indicate nelle precedenti relazioni, il 2 maggio 2017 la Commissione ha audito il dottor Elio Cioppa, all'epoca dei fatti funzionario della Squadra mobile di Roma, il quale, seppur non fu interessato direttamente alle indagini, rimase coinvolto nella vicenda della mancata perquisizione del covo di via Gradoli del 18 marzo 1978 poiché una sua confidente, Lucia Mokbel, indirizzò a lui un biglietto relativo agli strani rumori che provenivano dall'appartamento di via Gradoli 96 interno 11, vicino al suo.
La vicenda può essere riassunta in questi termini: la Polizia, in occasione dei controlli effettuati sulle abitazioni dopo il sequestro Moro, il 18 marzo 1978, due giorni dopo la strage di via Fani, si recò in via Gradoli, come in altre strade del quartiere. Solo dopo la scoperta del covo, in via Gradoli 96 interno 11, il 18 aprile 1978, si apprende del mancato controllo dell'appartamento. Infatti in quello stesso 18 aprile 1978, la Polizia giudiziaria raccolse le dichiarazioni degli inquilini e tra queste quelle di Lucia Mokbel e Gianni Diana, affittuario dell'appartamento ove anche la donna si recava saltuariamente. In quella sede, emerse che una squadra del Commissariato Flaminio Nuovo, guidata dal brigadiere Domenico Merola, aveva in precedenza effettuato un controllo dello stabile di via Gradoli 96. In quella occasione il covo brigatista, però, non fu perquisito, perché i suoi inquilini erano assenti e perché gli
operanti non ravvisarono dagli altri condomini motivi di sospettare una presenza brigatista.
La circostanza fu approfondita nel 1979 in occasione del primo processo Moro. All'epoca la Mokbel dichiarò che nella notte precedente il controllo del 18 marzo 1978 da parte della Polizia aveva sentito degli strani rumori simili a segnali Morse, e aveva quindi svegliato il Diana. Dichiarò inoltre che la mattina successiva aveva riferito la circostanza agli agenti che fecero i controlli e di aveva scritto i contenuti in un biglietto da far recapitare al dottor Cioppa in Questura. Le dichiarazioni vennero riprese anche nel settembre 1982, quando venne anche effettuato un confronto tra la Mokbel e gli operanti che furono riconosciuti dalla stessa. La donna però dichiarò non ricordare a quale degli agenti avesse consegnato il biglietto.
In merito il dottor Cioppa, nell'audizione del 2 maggio 2017, ha riferito: «Durante la perquisizione la Mokbel dice al brigadiere Merola, a quanto mi risulta anche dagli atti: "Guardi, questi due ingegneri" - Borghi si chiamavano, lui e la moglie - "che necessità hanno di battere a macchina con l'alfabeto Morse durante la notte? Stanno tutto il giorno in ufficio e non capisco il perché...". In definitiva, era un'intuizione. Peraltro, poi si dimostrò che non era l'alfabeto morse, ma la testina rotante della macchina da scrivere IBM. Comunque la Mokbel, siccome voleva fare la poliziotta, aveva dato comunque un indizio o quantomeno un sospetto.
Merola, a quanto mi risulta, le disse: "Vabbè, vada lei dal dottor Cioppa" e leirispose: "No, io non ci posso andare, perché se no perdo tutta una giornata. Io lavoro". Non gli volle dire che aveva paura di venire alla Squadra Mobile, questo è il succo. E pare che questo Merola si fece dare anche un biglietto in cui la donna si rivolgeva a me dicendo di fare accertamenti su questo ingegner Borghi...».
In merito ad un incontro che ebbe con la Mokbel successivo alla segnalazione di costei, Il dottor Cioppa ha riferito: «Io incontrai nel settembre del 1978 - tenga presente che Moro era morto a maggio - in un locale, un ristorante, nei pressi di via Aurora - via Veneto, la Mokbel, che non vedevo da tempo. Mi disse: "Elio, ma tu hai mai ricevuto da me una lettera?". Io rimasi molto sorpreso e risposi: "Ma scusa, ma quale lettera? Io non ho ricevuto niente". Notai che impallidì e mi disse: "Come, non hai mai ricevuto niente?". Replicai: "Guarda, io non ho mai ricevuto nulla". Ma ritenni che si trattasse di quello che normalmente può chiedere un confidente, cioè praticamente un passaporto o...». 
Ancora sulle modalità di recapito alla sua persona del biglietto della Mokbel, Cioppa ha precisato che il brigadiere Merola avrebbe dovuto riferire a lui o almeno al proprio dirigente la segnalazione fatta dalla Mokbel e consegnare il biglietto, soggiungendo che «...sta di fatto che sull'episodio - che è stato poi strumentalizzato, veramente strumentalizzato in malo modo, mi perdoni - io sono stato da Santiapichi, perché nel processo del 1983 venne messo in dubbio anche quello che era successo, addossandomi anche delle responsabilità sulla materia. Santiapichi, che mi disse: "Guardi, io non la voglio interrogare, né perseguirò i quattro agenti, perché io devo fare il processo ai brigatisti"».
Quanto già noto e quanto riferito in tale ultima audizione, emerge con chiarezza anche dalla escussione di Lucia Mokbel, che è stata svolta da collaboratori della Commissione. L'escussione ha fornito ulteriori dettagli sia sull'incontro occasionale avuto con il dottor Cioppa successivamente alla scoperta del covo, sia sulla circostanza che la stessa nel periodo in cui rilasciava dichiarazioni e testimonianze, veniva fatta oggetto di pressioni finalizzate ad una sua ritrattazione. In tale contesto la Mokbel ha riferito anche di una offerta di denaro. La donna ha riferito di non avere mai inteso denunciare le minacce e l'offerta di denaro: «Non mi sono mai sentita di farlo perché non mi sentivo difesa. Se sono le forze dell'ordine a farmi ciò non mi sono sentita di denunciare. Tra l'altro non sapevo nenche chi fosse la persona che mi aveva offerto soldi...».
Circa il noto episodio della percezione di segnali morse in via Gradoli, la Mokbel ha dichiarato: «Io all'epoca vivevo con la mia famiglia, occasionalmente andavo a dormire dal mio fidanzato Diana Gianni [...]. Con riferimento alla notte precedente il controllo di cui mi chiedete, non ricordo la data precisa, ma rammento che era primavera. Ricordo che, poiché ho il sonno leggero, sentii durante la notte dei rumori, credevo fosse il rumore dell'acqua sulla grondaia. Dopo un po' mi resi conto che quei rumori erano a me familiari in quanto mi ricordavano il segnale dell'alfabeto morse che mio padre ascoltava alla radio per non perdere l'abitudine nel riconoscerlo. Mio padre era stato comandante in seconda come militare nella Marina egiziana e poi nella Marina Mercantile, sempre egiziana. Durante quella notte in cui percepii i rumori detti, svegliai Gianni Diana e lo stesso, anche se dapprima non riuscì a identificare il rumore, poi convenne
che si trattava di alfabeto morse. Dissi a Gianni che la mattina seguente sarei andata in via Genova, in Questura, per riferire ciò che avevo sentito a un funzionario di mia conoscenza, il dottor Cioppa. Quella stessa mattina, tuttavia, arrivarono due poliziotti in divisa che bussarono alla mia porta, ricordo che il Diana era già uscito. I due poliziotti mi chiesero se nascondessi qualcuno. Io dissi ovviamente di no, anzi chiesi ai due poliziotti se potevano riferire al dottor Cioppa che durante la notte avevo sentito dei rumori strani che a me ricordavano l'alfabeto morse, così mi sarei risparmiata di andare in Questura. Tali fatti li ho scritti su di un foglio di carta, scrissi io a mano e la penna me la prestarono i poliziotti stessi, i quali mi dissero anche come indirizzare la nota. Dissi loro di portare il foglio al dottor Cioppa, loro mi confermarono che avrebbero provveduto a consegnarlo...».
La donna ha anche riferito di essere convinta che nell'appartamento in vai Gradoli nella disponibilità del Diana, dove lei si recava, fossero stati fatti degli strani accessi. A proposito del foglietto e dell'incontro con Cioppa, la teste ha riferito: «Dopo circa venti giorni dal fatto ho casualmente incontrato il dottor Cioppa in occasione di una cena tra amici comuni in un ristorante di cui non ricordo il nome, ma ubicato in centro città, e gli ho chiesto informazioni circa il messaggio che gli avevo inviato attraverso gli agenti chiedendo se vi fossero stati sviluppi. Lui si meravigliò della richiesta spiegandomi che non gli era giunto alcun messaggio e io mi lamentai dicendo "come mai correte per le telefonate anonime e su un biglietto con resoconto di quello che era accaduto la notte e da me firmato non avete fatto nulla?". Ciò avvenne fuori dal ristorante, e da lì il dottor Cioppa mi chiese di seguirlo in
via Genova, in Questura, per comprendere ciò che fosse accaduto. In Questura lui capì che i poliziotti che avevano preso il mio foglio manoscritto erano del "Flaminio" e si era meravigliato del perché non l'avessero recapitato».
Infine, la Mokbel ha dichiarato di aver ricevuto, dopo il sequestro Moro, da una persona che non conosceva, «la proposta di prendere trenta milioni di lire per ritrattare quanto avevo detto; avrei dovuto dire che mi ero sbagliata su quello che avevo detto circa i rumori per me riconducibili al linguaggio morse e sugli accessi nell'appartamento».
In tale occasione l'interlocutore avrebbe aggiunto alla proposta anche alcune allusioni e velate minacce.
Le recenti dichiarazioni rese dal dottor Cioppa e dalla Mokbel, nel confermare quanto già noto circa i rumori sentiti dalla donna la notte precedente il controllo della polizia del 18 marzo 1978, aggiungono due elementi di interesse.
In primo luogo emerge che il dottor Cioppa non è mai stato informato dal personale del commissariato delle indicazioni scritte dalla Mokbel circa i rumori sentiti quella notte. Questo conferma un'evidente lacuna investigativa, peraltro già evidenziata nell'ambito del primo processo Moro.
In secondo luogo, emerge una mancanza di uniformità tra le due versioni, in quanto esse collocano l'incontro tra Cioppa e Mokbel in due momenti diversi, in un caso nel corso del sequestro Moro, nell'altro in periodo molto successivo. Naturalmente, la significatività dell'informazione ai fini investigativi dell'informazione non è la medesima nei due casi. Se effettivamente la Mokbel si rivolse a Cioppa in corso di sequestro Moro sarebbero ben due le segnalazioni che avrebbero potuto condurre al covo di via Gradoli.
Infine, la Mokbel, nel confermare le sue dichiarazioni, ha inteso aggiungere di aver subito pressioni e tentativi di induzione a correggere le proprie asserzioni anche con somme di denaro, mai esposti in precedenza e allo stato non verificabili.
10.2.Accertamenti sul covo di via Montalcini
L'identificazione del covo di via Montalcini come "prigione" di Moro si definì progressivamente e con una certa lentezza, fino ad essere "consacrata" nella sentenza della Corte d'Assise al processo Moro-ter, le cui motivazioni furono depositate il 12 ottobre 1988.
La sentenza riconosceva che «è una verità processuale quella che lo statista sia stato tenuto in cattività nell'appartamento di via Montalcini n. 8». In questo caso si operava esclusivamente su un piano logico-deduttivo. Si trattava, come riportava la sentenza, di «una ricostruzione ex post, sia pure sillogistica, ed è in fondo la ricostruzione che fanno Savasta, Libera, Morucci e Faranda anche attraverso notizie indirette e fatti oggetto di rivelazioni da parte della stessa Braghetti e di altri. Il sillogismo è il seguente: Gallinari e Braghetti convivono dal 1977. Gallinari ed una donna gestiscono la "prigione del popolo"
dove è custodito Moro ed il primo esegue anche la condanna a morte dello statista. Ergo, la casa dove è tenuto in cattività Moro è l'appartamento di via Montalcini, preso in locazione per l'Organizzazione dalla Braghetti, estremamente compartimentato a tutti gli altri brigatisti che ne vengono a conoscenza soltanto dopo la scoperta».
Tale verità processuale rimarrà sostanzialmente invariata, arricchendosi solo di alcuni particolari ulteriori sul "quarto uomo" dell'appartamento, identificato in Germano Maccari.
Il percorso di individuazione del covo di via Montalcini fu in realtà estremamente tortuoso. Esso emerse poco dopo l'arresto della Braghetti, avvenuto il 27 maggio 1980, in un articolo di stampa del giornalista Luca Villoresi, ma il riconoscimento giudiziario è molto più tardo e avvenne solo a partire dalla sentenza-ordinanza Imposimato nel processo Metropoli (8 febbraio 1984) e dalla sentenza-ordinanza Priore nel processo Moro-ter (13 agosto 1984).
Decisivo fu, nel riconoscimento del covo di via Montalcini, il ruolo di Morucci, che ha costantemente asserito di non conoscerlo, per ragioni di compartimentazione. Colpisce tuttavia la sicurezza con cui Morucci si mosse nel corso del sopralluogo compiuto con Imposimato e Priore il 17 giugno 1985. In quell'occasione, recita il verbale, «dopo attento esame dei diversi vani, anche sulla base dei rilievi foto-planimetrici già eseguiti, l'attenzione dell'Ufficio veniva richiamata da Morucci su una delle due stanze attualmente adibite a camera da letto» e in particolare su «una striscia di colore più scuro rispetto a quello del legno residuo». Su questa base «Morucci fa rilevare che il vano in questione deve essere quello utilizzato come "prigione"», fornendo ulteriori indicazioni tecniche specifiche.
Va segnalato, per completezza, che nel 1993 Casimirri dichiarò a due agenti del SISDE che quella di via Montalcini era l'unica prigione di Moro e di aver raccolto confidenze di Morucci sul fatto che lui stesso aveva predisposto l'appartamento costruendo la falsa parete. Informazione che non fu adeguatamente valorizzata, ma che il rapporto SISDE riteneva fondata anche alla luce dello stretto rapporto che legava Morucci e Maccari.
Peraltro, come ha riconfermato la recente escussione del giornalista Luca Villoresi, anche nel caso di via Montalcini furono svolte nel luglio 1978 delle attività di polizia, sviluppatesi a partire dalla segnalazione da parte di un condomino della presenza di una Rénault 4 al Ministro Gaspari e da questi al Ministro dell'interno Rognoni.
Le attività di polizia però non compresero una perquisizione dell'appartamento della Braghetti che, a quella data, ancora vi viveva, forse con Gallinari. Anche l'escussione dell'ex ispettrice di polizia Paola Carraresi, che fu impegnata nei pedinamenti della Braghetti, evidenzia le criticità di un'operazione di polizia mal progettata e mal gestita.
Risulta infatti in atti che già nel luglio 1978 il questore De Francisci fu incaricato oralmente dal capo di gabinetto del Ministro dell'interno, Coronas, di indagare sulla segnalazione che una Rénault 4 rossa era stata notata in via Montalcini. I successivi accertamenti e pedinamenti consentirono l'identificazione della Braghetti e del sedicente Altobelli. Non fu però realizzata una perquisizione e gli operanti si limitarono a interloquire - collettivamente - con alcuni condomini, anche mostrando alcune foto di terroristi. Le informazioni furono ritenute irrilevanti e le attività cessarono non più tardi dell'ottobre 1978, dando modo alla Braghetti di proseguire la sua carriera criminale.
Rispetto a questo quadro, già consolidato, le escussioni di Paola Carraresi e di Luca Villoresi hanno portato a riconsiderare l'importanza di queste lacune investigative. In particolare emergono alcune incertezze sulla datazione delle attività, anche se non ci sono elementi certi che consentano di antedatarle a prima del luglio 1978, e non ha trovato allo stato, riscontro documentale, l'affermazione di Villoresi, secondo il quale «ho tra l'altro appreso in occasione degli accertamenti da me effettuati in via Montalcini che qualcuno, durante il sequestro Moro, avrebbe chiamato la Questura per fare una segnalazione circa i suoi sospetti sull'appartamento in questione». Affermazione che potrebbe riferirsi a una segnalazione relativa a un contrasto condominiale che avrebbe coinvolto la Braghetti e un condomino o a una segnalazione di tale Maria Agata Tombellini. In entrambi casi, peraltro, un appunto del 3 ottobre 1978 riferiva che non
risultavano agli atti del Commissariato "San Paolo" evidenze in merito.
10.3.Gli esami tecnici del RIS
La ricostruzione dell'omicidio di Aldo Moro si basa soprattutto su due elementi: la perizia tecnico-balistica-merceologica realizzata tra il 1978 e il 1979, che recepisce anche le conclusioni della perizia medico-legale del 10 maggio 1978, e le dichiarazioni rese in sede giudiziaria, parlamentare e pubblicistica, soprattutto negli anni '90, dai brigatisti, in particolare da Germano Maccari - a cui si deve la ricostruzione più completa - e da Mario Moretti, che si è attribuito la responsabilità materiale dell'uccisione di Moro, ma sostanzialmente non ha fornito particolari sulle modalità in cui fu realizzata. Più specificamente la ricostruzione dell'omicidio Moro si è basata essenzialmente sulle dichiarazioni - contraddittorie in numerosi punti - che furono rese tra il 1993 e il 1996 in sede giudiziaria da Laura Braghetti e Germano Maccari, in un libro-intervista, da Mario Moretti e in un libro, di molto
successivo, di Gallinari, edito nel 2006).
Sintetizzando molto si può così riassumere la ricostruzione fornita dai brigatisti: Moretti e Maccari sarebbero stati gli unici a partecipare direttamente all'esecuzione (con la Braghetti che faceva da "palo"), mentre, a detta dei brigatisti, Gallinari - in realtà già condannato per l'omicidio Moro - sarebbe rimasto in casa - secondo quanto scritto da Moretti - perché era un ricercato noto. In proposito va rilevato che l'attribuzione dell'omicidio a Moretti, piuttosto che a Maccari o a Gallinari, non presenta alcuna forma di certezza, essendo legata alla testimonianza - talora non resa in sede giudiziaria - degli interessati che, per i motivi più vari, incluse forme di solidarietà personale, poterono indirizzarsi su una versione piuttosto che su un'altra.
Moro sarebbe stato trasferito dall'appartamento di via Montalcini al garage sottostante all'interno di una cesta. Sarebbe stato fatto poi rannicchiare nel portabagagli della Rénault 4 e gli sarebbe stata coperta la testa con un lembo della coperta.
Moretti avrebbe sparato dapprima con la pistola Walther, che però si sarebbe inceppata dopo uno o due colpi. Allora Maccari gli avrebbe passato la Skorpion con la quale furono sparati gli altri colpi. Conseguentemente, il solo Moretti avrebbe sparato.
Entrambe le armi sarebbero state silenziate e i colpi sarebbero stati esplosi da posizione ravvicinata o, in alcuni casi, a contatto.
Le dichiarazioni dei brigatisti affermano che Moro sarebbe stato ucciso nella posizione in cui il suo corpo fu ritrovato. Anche la perizia del 1978/1979 giunse alla medesima conclusione.
Le attività di indagine della Commissione hanno preso le mosse dalla sentenza di primo grado del Moro quinquies del 17 luglio 1996.
Questa rilevava, a proposito della verosimiglianza del trasporto di Moro nella cesta e dell'esecuzione, che «non si comprende come i brigatisti abbiano accettato un simile e gratuito rischio, quando avrebbero potuto facilmente evitarlo, ad esempio uccidendo l'on. Moro nella sua stessa prigione e trasportandolo poi da morto; ed incredibile sembra il fatto che si sia programmata l'esplosione di una serie di colpi, quanti risultano dalle perizie, in un box che si apriva nel garage comune agli abitanti dello stabile, essendo noto che anche i colpi delle armi silenziate producono rumori apprezzabili, che potevano essere facilmente percepiti da persone che si trovassero a passare, cosi come furono distintamente percepiti dalla Braghetti».
Allo scopo di meglio chiarire la dinamica omicidiaria, la Commissione ha delegato al RIS dei Carabinieri di Roma una serie di attività tecniche, che contengono diverse importanti novità e, soprattutto, colmano un vuoto di indagine.
La Commissione ha delegato al RIS dei Carabinieri di Roma le seguenti attività, relative alla Rénault 4 in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro: ricerca di eventuali segni d'impatto dei bossoli sulle superfici dell'abitacolo; campionamento con stub del cielo dell'autovettura per la ricerca di residui dello sparo e della loro distribuzione sulla superficie interessata; esame merceologico del bottone rinvenuto sul sedile posteriore dell'autovettura e comparazione con quelli relativi agli indumenti indossati da Aldo Moro; confronto tra bossoli e proiettili repertati sia all'interno della Renault 4 sia in sede autoptica con le armi utilizzate, in ipotesi, nell'esecuzione materiale dell'omicidio di Aldo Moro; ricerca di eventuali tracce ematiche o di altro materiale organico - anche latenti - all'interno dell'autovettura e, in caso di esito positivo, estrazione del profilo del DNA; identificazione della natura delle macchie ematiche e delle
striature scure presenti nell'imbottitura interna (specialmente nella parte posteriore) del tetto del veicolo
Sulla base delle attività compiute dal RIS in relazione alla ricostruzione della dinamica delittuosa, questa può essere così riassunta.
L'ipotesi ritenuta più probabile è che in un primo momento la vittima sia stata attinta anteriormente al torace sinistro da almeno tre colpi sparati con la mitraglietta Skorpion. L'inclinazione di tali traiettorie è pressoché ortogonale alla superficie corporea attinta e la postura della vittima è, verosimilmente, con il busto eretto e seduta, come dimostrato dalle colature di sangue sulla maglia a carne unitamente alle proiezioni e colature di fluido biologico sui pantaloni. È altresì probabile che, in quel momento, la vittima sia stata ferita anche al pollice della mano sinistra, protesa in avanti in un istintivo gesto di autodifesa ed il medesimo proiettile abbia poi proseguito la sua traiettoria attingendo il torace anteriormente.
Tale fase iniziale della dinamica delittuosa potrebbe esser avvenuta supponendo Aldo Moro seduto sul pianale del portabagagli della Renault 4, sopra la coperta, con il busto eretto e le spalle rivolte verso l'interno dell'abitacolo. Non si può tuttavia escludere che la vittima abbia assunto una postura seduta con il busto eretto in un qualsiasi altro ambiente.
In base a quest'ultimo ragionamento e su un piano esclusivamente logico, si potrebbe giustificare anche il ritrovamento durante l'ispezione cadaverica di quei fazzoletti di carta - mai più rinvenuti - inseriti tra la camicia ed il gilet. Infatti essi potrebbero aver avuto lo scopo di tamponare le prime ferite al torace, durante il trasporto della vittima dal luogo dei primi colpi esplosi fin dentro il vano portabagagli.
Sparando almeno tre colpi è verosimile che i rispettivi proiettili calibro 7,65mm siano stati ritenuti nel corpo ed i relativi bossoli esplosi siano stati espulsi dalla Skorpion, andando dispersi nell'ambiente. Secondo questa ipotesi i tre bossoli calibro 32 Auto mai repertati si aggiungerebbero agli altri otto di pari calibro ed a quello calibro 9mm corto, per un totale di dodici colpi esplosi.
In un successivo momento, la vittima deve aver assunto una posizione supina nel vano portabagagli, adagiata sulla coperta sottostante distesa sul pianale e con il capo verso la parte sinistra dell'auto.
Ciò può esser accaduto, dopo i primi colpi pressoché ortogonali al torace sinistro, perché Aldo Moro si è naturalmente accasciato con il busto all'indietro e sul suo lato destro, in quanto era già seduto sul pianale del portabagagli come supposto sopra, ovvero, nell'ipotesi che i primi colpi siano avvenuti in un altro luogo, perché egli veniva trasportato nel portabagagli e adagiato supino sopra la coperta distesa sul pianale.
In entrambi i casi la postura supina sul pianale, assunta dalla vittima è tale da esporre la sinistra del torace anteriore a uno o più ipotetici sparatori collocati all'esterno della Renault 4, nella sua parte posteriore (ovviamente il portellone del portabagagli deve essere aperto).
In tale quadro è verosimile che siano stati esplosi, con direzione da destra verso sinistra del portabagagli (visto da dietro) e con inclinazione dall'alto verso il basso, i rimanenti colpi d'arma da fuoco, tra cui quello calibro 9mm corto sparato dalla pistola semiautomatica Walther.
Tali traiettorie giustificherebbero, in modo complementare, le direzioni dall'avanti all'indietro e dal basso verso l'alto, nonché da sinistra verso destra, di alcuni tramiti intracorporei individuati durante gli accertamenti autoptici.
Tale morfologia, infatti, è verosimilmente riferibile alla pressione esercitata dalla parte apicale di un silenziatore sull'indumento all'atto dello sparo. Confrontando la forma circolare in questione con quella apicale del silenziatore, abbinato alla Skorpion, non sembrerebbe che vi sia compatibilità sia per le dimensioni del diametro, sia per la presenza di nastro isolante sporgente dalla parte superiore. Infatti quest'ultimo, in una ipotetica azione di pressione sull'indumento, impedirebbe la formazione "a stampo" di una corona circolare ben definita come quella osservata sul gilè.
Al riguardo va ricordato che gli accertamenti balistici comparativi non hanno consentito di accertare se i proiettili calibro 7,65mm in reperto siano stati sparati con o senza il silenziatore montato sulla Skorpion (e nemmeno si può escludere che un altro silenziatore fosse inserito sulla Walther, al momento in cui tale pistola ha sparato il proiettile calibro 9mm corto). In ogni caso l'abbondanza di residui dello sparo sugli indumenti di Aldo Moro indica un'estrema vicinanza della vittima all'arma o delle armi durante l'azione di fuoco.
Inoltre, impugnando la Skorpion in modo tale da orientare la bocchetta di espulsione verso destra con un angolo di 45°, è stato sperimentato che i bossoli esplosi vengono espulsi con una traiettoria parabolica di oltre 4 metri e ciò potrebbe giustificare il ritrovamento di almeno cinque di essi nella parte anteriore dell'abitacolo.
Al termine dell'azione delittuosa è immaginabile che la vittima sia stata sistemata a forza nel vano portabagagli con le gambe flesse all'indietro e anche facendole compiere una rotazione antioraria del busto.
Si ritiene meno probabile l'ipotesi alternativa secondo la quale, in un primo momento, la vittima è stata attinta anteriormente al torace mentre era seduta all'interno della Renaut4 (plausibilmente) mentre lo sparatore occupava la posizione del passeggero anteriore. Tale ipotesi potrebbe essere supportata dal ritrovamento di cinque bossoli calibro 32 Auto nella parte anteriore dell'abitacolo che sarebbero stati esplosi ed espulsi dalla mitraglietta Skorpion usata da dentro l'autovettura. In tale quadro deve supporsi un successivo trasferimento di Aldo Moro nel vano portabagagli, per poi esser disteso all'incirca supino sul pianale con parte della coperta sotto il corpo e con il capo verso la sinistra del portabagagli.
A questo punto l'azione criminosa sarebbe proseguita come anzidetto nella precedente ipotesi, senza necessariamente supporre che la Skorpion fosse impugnata con la bocchetta d'espulsione ruotata verso destra, in quanto il ritrovamento dei bossoli nell'abitacolo sarebbe giustificato da un primo utilizzo dell'arma dentro l'autovettura.
Proprio alla luce degli accertamenti condotti sulla dinamica omicidiaria, la Commissione ha richiesto di disporre di elementi di valutazione sulla reale praticabilità dell'omicidio di Moro, così come ricostruito dai brigatisti, nel garage di via Montalcini 8.
Il 4 maggio 2017, su delega della Commissione, il RIS ha effettuato delle reali prove d'ingombro nel box -garage di Via Montalcini 8 in Roma con una Renault 4 e, nello stesso locale, delle vere prove di sparo con le armi usate nella commissione dell'omicidio (la pistola semiautomatica Walther cal.9mm corto e la mitraglietta Skorpion cal.7,65mm e relativo silenziatore), per verificare l'effettivo fragore dell'esplosione dei colpi.
Le attività tecniche effettuate il 4 maggio 2017 in Via Montalcini 8 in Roma hanno insinuato il dubbio che il box d'interesse nel corso del tempo avesse subito importanti modiche strutturali volte al suo ampliamento. Di ciò si è avuta conferma mediante il confronto tra lo stato dei luoghi e le immagini dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia giudiziaria il 19 aprile 1983.
In base alle prove d'ingombro (reali, collocando fisicamente una Renault 4 all'interno del box, e virtuali, elaborando i dati acquisiti con il Laser Scanner 3D) sono state formulate diverse conclusioni possibili.
Se la porta basculante fosse stata completamente chiusa, pur posizionando la Renault 4 a retromarcia fino a far toccare con la sua parte anteriore quella interna della basculante, sarebbe stato molto improbabile aprire / chiudere il portellone senza che quest'ultimo urtasse sulla parete in fondo (e tutto ciò appare verosimile a prescindere dal modo più o meno obliquo, con cui può esser parcheggiata a retromarcia l'auto nel box).
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box con il portellone posteriore già aperto, allora è probabile che la porta basculante (dopo tale manovra) si potesse chiudere completamente. In tale ipotesi lo spazio di manovra sul retro della Renault 4 sarebbe stato poco superiore a 0,40m.
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box ad una distanza dal fondo della parete superiore a 0,51m, allora molto probabilmente la sua parte anteriore sarebbe sporta oltre l'ingresso del box e la porta basculante non si sarebbe potuta chiudere del tutto. In tale ipotesi, però, il portellone posteriore si sarebbe potuto chiudere /aprire liberamente (cioè senza urtare sulla parete in fondo al box).
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box, accostandola a destra, lo spazio residuo sul suo lato sinistro sarebbe stato variabile all'incirca tra 1,0m e 1,6m. Inoltre la distanza tra la sua parte anteriore sinistra e la "spalletta" dell'ingresso del box sarebbe statadi circa 0,70m.
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box, accostandola a sinistra, lo spazio residuo sul suo lato destro sarebbe stato variabile all'incirca tra 1,0m e 1,5m.
Anche se alcune delle ipotesi formulate sono astrattamente compatibili con l'effettuazione dell'omicidio nel box, nel complesso esse rafforzano i dubbi che, su un piano logico, si evidenziano rispetto alla praticabilità, in quel luogo, dell'azione omicidiaria.
Il RIS ha anche condotto reali test di sparo con entrambe le armi usate nella commissione dell'omicidio Moro, utilizzando munizionamento del campionario di laboratorio del RIS di Roma.
Il valore della sperimentazione volta a determinare in vari punti dello stabile di Via Montalcini la percezione sonora dei colpi esplosi è fortemente discutibile, se inserito nel contesto delittuoso in esame. Infatti il fragore dei colpi d'arma da fuoco nel box è stato di gran lunga superiore rispetto a quello ipoteticamente avvenuto nello svolgimento dei fatti, poiché sulla pistola Walther non è stato applicato alcun silenziatore e quello montato sulla mitraglietta Skorpion non si è rivelato particolarmente performante. Inoltre, per motivi di sicurezza, si è reso necessario esplodere i colpi d'arma da fuoco a distanza dal retro della Renault 4, al punto che la sua parte anteriore sporgeva oltre l'ingresso del box. Di conseguenza la saracinesca è rimasta completamente sollevata per tutti i test di sparo favorendo la propagazione delle onde sonore nello stabile.
All'esito della sperimentazione effettuata il 4 maggio 2017 in Via Montalcini e seppur con i limiti della stessa, non si può in modo assoluto escludere - anche alla luce degli esami balistici - un'azione di fuoco nel box in questione contro Aldo Moro, anche se essa appare poco probabile sul piano dei rischi e della rapidità dell'azione.
Anche le prove reali e virtuali d'ingombro con la Renault 4 non escludono che la vittima sia stata attinta nel bagagliaio mentre l'auto era parcheggiata a retromarcia nel box, con il portellone già aperto e con la porta basculante chiusa. Se infatti in ipotesi il davanti della Renault 4 fosse stato a contatto con l'interno della basculante chiusa, probabilmente lo spazio tra il paraurti posteriore e la parete con l'intercapedine sarebbe stato di almeno 0,40m circa. Questo spazio, sebbene contenuto, in linea teorica non avrebbe impedito alla vittima di sedersi sul pianale del portabagagli e di collocare di fronte ad essa almeno un ipotetico sparatore. Inoltre, se in ipotesi l'auto fosse stata accostata nel box sul suo lato destro, probabilmente lo spazio di manovra sul fianco sinistro della Renault 4 sarebbe stato variabile tra circa 1,00 e 1.60m per tutta la lunghezza del box.
A maggior ragione, se in ipotesi la porta basculante fosse stata socchiusa, lo spazio a disposizione sul retro della Renault 4 sarebbe aumentato ulteriormente.
Uno spazio sul retro potrebbe esser compatibile con l'azione delittuosa già descritta in atti, secondo cui lo/gli sparatore/i (almeno nelle ultime fasi dell'esplosione dei colpi) si collocherebbero sul retro della Renault 4. Del resto questa estrema vicinanza alla parte posteriore dell'autovettura sarebbe compatibile anche con l'espulsione dei bossoli nel bagagliaio e all'interno dell'abitacolo (nella sperimentazione del 4 maggio 2017 è stato anche osservato come il bossolo espulso dalla Skorpion sia in grado di raggiungere la parte anteriore dell'abitacolo).
In conclusione dunque, le attività tecniche non escludono la possibilità di realizzare l'omicidio nel box, ma confermano gli elementi di criticità e macchinosità segnalati.
11. Il covo di via Fracchia e la possibile presenza di carte di Moro a Genova
Già nel corso della precedente relazione, l'attenzione della Commissione si era focalizzata su un possibile ruolo della colonna genovese delle BR nella vicenda Moro. Ciò sia per alcuni elementi logici - quali il fatto che all'operazione di via Fani parteciparono diversi militanti delle colonne del Nord Italia, il particolare rapporto di Moretti con la Colonna genovese, la presenza nella colonna genovese di personaggi di qualche rilievo militare, come Dura - sia anche sulla base di alcuni elementi testimoniali o di riflessioni coeve agli eventi.
Già il 4 maggio 1979 in un articolo su "Critica sociale" si affermava che «la diffusione del "comunicato n. 9" — che gli esegeti del lessico brigatista sostengono scritto dai "genovesi", mentre quelli precedenti erano scritti dai "romani" che tenevano prigioniero Moro — sarebbe coincisa col cambio della guardia nel "carcere del popolo": carcerieri "genovesi" col compito di boia, al posto dei romani». Anche in corso di sequestro Moro, Mario Scialoja, in un articolo apparso su "L'Espresso" del 23 aprile 1978, che avrebbe potuto essere "ispirato" dall'interno delle BR, evocava i contrasti tra la "colonna romana" e "colonna genovese" sulla sorte di Moro.
Né vanno trascurate le dichiarazioni rese da Enrico Fenzi al primo processo Moro, il 4 novembre 1982. In quell'occasione Fenzi, pur dichiarando di non avere conoscenza diretta di particolari sulla vicenda Moro, affermò: «Io sono convinto che in via Fani ci fossero Nicolotti e Dura, però, se lei mi chiede su che base, io non glielo saprei dire, perché queste cose non si dicono, si possono interpretare magari da un accenno o da un modo con cui uno sorride quando parla di queste cose». Nel corso dell'audizione del 13 giugno 2017 Fenzi non ha aggiunto ulteriori particolari sul punto, ma ha richiamato discussioni svoltesi nel carcere di Palmi dopo la morte di Dura.
Ulteriori spunti sono poi derivati da un memorandum che Morucci stese per il SISDE il 3 novembre 1990, relativo al secondo ritrovamento delle carte di Moro in via Monte Nevoso, avvenuto il 9 ottobre 1990. In questo testo Morucci affermò di non essere sicuro che Gallinari avesse distrutto gli originali delle lettere e che solo Moretti, Azzolini, Bonisoli e Micaletto potevano avere una simile notizia. Affermò infine di non vedere ragioni per distruggere gli originali del memoriale Moro. Ipotizzava - come riflessione e non per conoscenza diretta - che gli originali stessi fossero nella disponibilità di Moretti o, più probabilmente, di Micaletto, che "governava" sia la colonna genovese che quella torinese. Ciò anche perché la Liguria - e in particolare Genova - costituiva per le Br un retroterra sicuro.
Il complesso di questi elementi ha indotto a compiere una serie di accertamenti sulla vicenda del covo brigatista di via Fracchia e sulla possibile presenza, in questo, di documentazione riconducibile a Moro.
11.1 Il covo di via Fracchia
In un saggio dedicato al rapimento e la morte Aldo Moro(27), si sottolinea che «il giornalista Massimo Caprara scriverà più volte, in date diverse: «Disse a caldo il procuratore della Repubblica di Genova, Antonio Squadrito: "La verità è che abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale di armi... Soprattutto una trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro alla Dc, al Paese"». Il riferimento è a due articoli pubblicati nel numero 1 di "Pagina", del 25 febbraio 1982, e nel periodico "Illustrazione Italiana", n. 32, luglio 1986.
Come è stato rilevato anche in altre riflessioni sul tema, la rivelazione di Caprara, ex segretario di Palmiro Togliatti, precisa e circostanziata, fa ritenere difficile credere che «un procuratore della Repubblica abbia deciso di astrologare su temi tanto delicati; appare del tutto più verosimile che egli, a botta calda, abbia dichiarato ai giornalisti cosa aveva visto con i suoi occhi o saputo e poi era stato chiamato all'ordine e alla tutela del segreto»(28).
I fatti di via Fracchia, occorsi in piena notte il 28 marzo 1980, rappresentano una delle vicende più complesse del terrorismo brigatista e delle azioni che lo contrastarono. Quattro morti tra gli occupanti di quella base logistica delle Brigate Rosse, un sottufficiale dei Carabinieri ferito da un colpo d'arma da fuoco, la fine dell'inviolabilità dei siti della colonna genovese, strategici per l'organizzazione. E molti interrogativi sul reale svolgimento dell'irruzione, divenuto poi evento simbolico della lotta armata, con la costituzione di un gruppo terroristico milanese, denominato XXVIII marzo.
Ma di quelle trenta cartelle "meticolosamente scritte da Aldo Moro", indicate dal magistrato che nel 1980 era al vertice della Procura di Genova, non è stata rinvenuta alcuna traccia agli atti del processo.
Come si vedrà la base ubicata nel quartiere genovese dell'Oregina, tenuta dall' "irregolare" Annamaria Ludmann, al tempo dell'irruzione fatta dai carabinieri di Dalla Chiesa ospitava ben tre latitanti e in particolare, da molto tempo, Riccardo Dura, uomo di punta dell'organizzazione. In quell'appartamento si era tenuta una riunione della direzione strategica alla quale aveva partecipato il capo colonna torinese Patrizio Peci, che poi ne rivelò l'esistenza.
Escussa da collaboratori della Commissione, l'ex brigatista Anna Maria Massa ha ricordato che fino al 28 marzo del 1980 «Genova era un territorio inviolato per quanto riguarda le strutture dell'organizzazione. Genova era impermeabile». Ed ha aggiunto che «nell'ambito della compartimentazione ogni colonna aveva un proprio archivio. Per quanto attiene alle cose ricordate dal giudice Carli, voglio precisare che non ho avuto conoscenze di carte di Moro in via Fracchia. Premetto che le Brigate rosse erano organizzate su più sedi logistiche dove venivano conservati i documento delle varie colonne. Ricordo che a casa mia a Torino erano conservati pochi documenti, solo schede e informazioni locali e non veniva conservato alcun archivio di colonna, quindi la mia abitazione non era una base logistica. È noto che in via Fracchia vi erano tre latitanti, ciò rende possibile che vi fosse conservata documentazione di colonna. È
noto altresì che Dura era un componente storico della colonna, latitante da molti anni, e ritengo conseguentemente che potrebbe aere conservato documentazione della direzione strategica».
In effetti quella dell'Oregina fu una base logistica di primo piano, deposito di armamenti, esplosivi e munizioni, utilizzata per la custodia dell'archivio di colonna e dei documenti che Dura, in qualità di elemento apicale delle BR, doveva detenere.
La quantità e l'importanza del materiale sequestrato in via Fracchia si desumono esaminando il verbale di perquisizione e sequestro (acquisito agli atti della Commissione) che reca un impressionante elenco di 753 reperti, che certamente dal punto di vista investigativo poteva essere considerato un "tesoro", stante la pregressa assoluta inviolabilità della rete logistica genovese dell'organizzazione.
Non a caso il 13 febbraio 1981 nel rapporto giudiziario numero 15/6-19 del Nucleo operativo dei Carabinieri del Gruppo di Genova si legge che «l'esame della raccolta dei volantini e risoluzioni strategiche, confermava l'ipotesi di aver rinvenuto un archivio completo nazionale delle ‘B.R.' consistente dalla loro prima pubblicazione in originale, sino alla minuta manoscritta del volantino rivendicante la ‘gambizzazione' del Prof. Moretti, in data 24 marzo 1980, compiuta pochi giorni prima dell'irruzione nel covo».
Tenuto conto delle questioni connesse ai parziali ritrovamenti documentali avvenuti nel covo di via Monte Nevoso, la citata esternazione del Procuratore della Repubblica di Genova, Antonio Squadrito, è apparsa meritevole di adeguato approfondimento, anche alla luce delle indicazioni su un ruolo della Colonna genovese nel sequestro Moro espresse su un articolo di "Critica sociale" e di quanto già esposto nelle precedenti relazioni sulle audiocassette contenenti le registrazioni di una conversazione del 2 novembre 1978 tra un uomo e una giovane donna, indicata con il nome in codice «Camillo», alla quale vengono rivolte domande sull'ambiente dell'estrema sinistra dell'area genovese.
Prima ancora dell'acquisizione di notizie e informazioni da fonti dichiarative, il lavoro della Commissione ha riguardato l'analisi dell'ampia pubblicistica relativa alla vicende brigatiste a Genova e in Liguria e, in particolare, la ricostruzione degli accadimenti di quella notte del marzo 1980.
Per una sintetica rivisitazione della vicenda di via Fracchia, è risultata particolarmente utile l'ampia ricostruzione effettuata da Sandro Provvisionato, alla quale, per esigenza di sintesi, si rinvia(29).
Del ritrovamento di qualcosa che potrebbe essere definito un "tesoro" di documenti vi è traccia fin dal lancio dell'agenzia Ansa delle ore 7,42 del 28 marzo 1980, in cui su legge: «È trapelato che nell'appartamento di via Fracchia sono stati trovati numerosi documenti che potrebbero essere di notevole interesse». Questo è il secondo tempestivo flash dell'agenzia che già alle 6,53 aveva battuto per prima poche righe, segnalando che nel conflitto a fuoco erano morti tre uomini e una donna ed era stato ferito un sottufficiale dell'Arma.
L'inviato del "Corriere della Sera" Antonio Ferrari, il 30 marzo 1980 scrive che «quando fuori dal condominio di via Fracchia giungono le auto della Digos sono costrette a rientrare in Questura. A dieci metri dalla casa c'è un cordone insuperabile». Il quotidiano milanese già il 2 aprile 1980 aggiunge altri particolari: sarebbe stata trovata nel covo di via Fracchia una cartellina con un appunto "materiale da decentrare sotto terra".
Marcello Zinola, all'epoca dei fatti cronista del "Secolo XIX" addetto alla redazione di Savona, escusso da collaboratori della Commissione(30), ha riferito di aver avuto modo di verificare che, «nell'immediatezza, la stampa raccolse notizia circa riferimenti desumibili da investigazioni svolte in Piemonte (verosimilmente intercettazioni telefoniche) circa la conservazione nel covo di via Fracchia di materiale documentale di rilevante interesse, ovviamente delle Brigate Rosse» aggiungendo che «sempre nell'immediatezza la stampa genovese prese in in considerazione l'ipotesi che fossero stati effettuati "carotaggi" in giardino. Dell'effettività e degli eventuali esiti del carotaggio nulla trapelò, nemmeno tra i residenti del condominio».
Nel già citato contributo Sandro Provvisionato ha evidenziato che con le quattro bare vengono visti uscire dal condominio "pacchi e grossi sacchi neri" caricati su due pulmini dei carabinieri, e aggiunge che il giorno successivo all'irruzione «si diffonde la voce [...] che i carabinieri, dopo aver catalogato tutto il materiale sequestrato nell'appartamento, stiano scavando in giardino [...] È evidentemente grande l'interesse per qualcosa che resterà misterioso e che doveva trovarsi in via Fracchia. Forse, chissà, magari proprio seppellito in giardino».
Occorre domandarsi se tra il presunto "tesoro" evocato dal procuratore Squadrito e il «materiale da decentrare sotto terra» possa esservi qualche relazione.
La questione degli scavi in giardino ha trovato un'ampia eco anche nel materiale dell'inchiesta giornalistica curata dal 12 al 15 febbraio 2004 da Andrea Ferro ed altri cronisti sulle pagine del "Corriere mercantile", storico quotidiano genovese.
Nel pezzo intitolato Via Fracchia, ricordi indelebili. Quella donna in giardino, l'uomo con il piccone, pubblicato venerdì 13 febbraio 2004, a firma di Simone Traverso, vengono riportati i ricordi raccolti della "gente del civico 12", tra cui quello di «un uomo misterioso, forse Dura, che scavava con un piccone nell'erba alta delle aiuole».
Tale ricordo evoca una caratteristica peculiare del covo che disponeva anche di un giardino pertinenziale, a cui si accedeva dalla cucina e dalla sala da pranzo, che conduceva alla parte posteriore dell'edificio. Un giardino che, incredibilmente, non trova esplicita menzione negli atti processuali, né viene evidenziato nella ricostruzione della planimetria dell'appartamento.(31)
La questione del "tesoro" è posta in termini espliciti il 25 febbraio 1982, su "Pagina". In quella sede, Massimo Caprara riferisce dell'esistenza di quella trentina di cartelle scritte da Aldo Moro "meticolosamente" e aggiunge che «qualcosa in particolare impegna il generale Dalla Chiesa nell'inverno del 1980. La lunga serie delle lettere del presidente incarcerato non è completa [...] In via Monte Nevoso è conservato un testo manoscritto del presidente della DC mai fatto circolare». Particolare, questo, che emergerà solo otto anni dopo, quando questo documento emergerà quasi per caso, nascosto dietro ad un tramezzo. Questo particolare potrebbe significare che quel documento, in realtà, era già noto.
Invero, sul tema della "delocalizzazione" di materiale documentale vanno ricordati alcuni passi dell'audizione del colonnello Nicolò Bozzo dinanzi la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, svolta il 21 gennaio 1998.
Secondo l'ufficiale, stretto collaboratore del generale Dalla Chiesa, «le Brigate rosse avevano l'abitudine di fotocopiare e di suddividere il materiale, di nasconderlo. Addirittura in un giardino vicino a Via Fracchia a Genova pochi giorni fa è stato rinvenuto un plico di volantini sepolto. Agivano così perché mettevano sempre in conto la scoperta "della base", con la quale però non doveva finire l'attività di studio e di propaganda. Pertanto avevano bisogno di frazionare il materiale documentale fra più basi o anche, all'interno della stessa base, in posti diversi».
Questa considerazione del colonnello Bozzo evidenzia due punti rilevanti.
In primo luogo le Brigate rosse procedevano alla duplicazione e alla suddivisione del materiale. E siffatta suddivisione poteva ragionevolmente riguardare o i componenti della direzione strategica, in quanto singoli, o le colonne dell'organizzazione.
In secondo luogo, il frazionamento poteva riguardare anche la stessa base. Sul punto l'esempio proposto dall'ufficiale sintomaticamente richiamava (nel gennaio 1998) un recente ritrovamento nel giardino della Ludmannn di un plico di volantini sepolto (altro rispetto a quanto reperito all'atto dell'irruzione nell'appartamente e dopo il contestuale scavo nel giardino).
11.2 I tempi e i modi del rinvenimento della documentazione in via Fracchia
L'analisi dei tempi e dei modi del rinvenimento di materiale documentale in via Fracchia implica l'esatta ricostruzione della cronologia dell'avvenimento.
In particolare l'attenzione deve partire dall'effettuazione dello scavo nel giardino pertinenziale, confermata ai consulenti della Commissione dal dottor Maffeo, intervenuto sul posto in qualità di pubblico ministero di turno. Il magistrato ha indicato con certezza il particolare che in giardino del terreno appariva smosso da poco tempo, precisando le rilevanti dimensioni dello scavo, tale, a suo avviso, da avere il volume di tre valigie medie.
Uno scavo immediato e verosimilmente mirato non poteva che scaturire dalla disponibilità di informazioni adeguate. Quell'operazione dovette impegnare il personale operante per un tempo non esiguo e terminare prima dell'arrivo del magistrato di turno.
Ma l'istruttoria condotta ha consentito di verificare che un altro magistrato giunse a via Fracchia prima del Pubblico ministero Maffeo: il sostituto procuratore Luciano Di Noto. Costui sarebbe giunto tanto presto da suscitare perfino l'incredulità dell'ufficiale che aveva guidato l'irruzione, l'allora capitano Michele Riccio.
L'ex uffciale, escusso da collaboratori della Commissione, il 16 novembre 2017 ha riferito che: «Mi sorpresi nel notare Di Noto nel salone, intento a rovistare tra le carte. Forse ci salutammo ma non ho neanche questo ricordo esattamente collocato nella mente. Con la battuta "Di Noto-Servizi", posso sinteticamente dire che Di Noto era molto vicino ai servizi. Avevo notato amichevoli rapporti tra lui ed ex colleghi transitati nei servizi, per esempio Luciano Seno. Io non so dire né chi abbia avvisato Di Noto né chi abbia accompagnato lo stesso a via Fracchia. Nemmeno so spiegarmi perché Di Noto sia arrivato tanto presto».
Secondo la versione ufficiale l'operazione ha inizio alle ore 4,00 circa del 28 marzo.
Già alle 9 circa del 28 marzo 1980 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri può diffondere un comunicato del seguente tenore: «L'operazione antiterrorismo condotta stamane in Italia settentrionale e coordinata dal Comando generale dei carabinieri, dopo laboriose indagini che avevano consentito la localizzazione di covi e basi logistiche di formazioni eversive a Genova, Torino e Biella - afferma il comunicato - eÌ€ scattata simultaneamente poco dopo le quattro di stamane con largo spiegamento di mezzi e militari dell'Arma dei gruppi di Genova, Torino e Vercelli e delle sezioni anticrimine, che nella circostanza indossavano giubbotti e caschi protettivi. A Genova i carabinieri, fatti segno a colpi di arma da fuoco, hanno reagito prontamente, sostenendo un violento conflitto nel corso del quale i quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono rimasti uccisi, mentre un sottufficiale dell'Arma eÌ€ rimasto ferito. A
Torino e Biella sono state localizzate due basi logistiche ed arrestati sei presunti brigatisti e fiancheggiatori. Sono stati rinvenuti esplosivi, armi, materiale e documenti che sono tuttora al vaglio dei carabinieri. Il comandante generale dell'Arma, generale Umberto Cappuzzo, ha fatto pervenire ai militari operanti il suo vivissimo elogio. L'operazione eÌ€ tuttora in corso».
Dal primo comunicato del Comando generale dell'Arma emerge che l'irruzione in via Fracchia è dunque parte di una più vasta operazione avviata in Piemonte, «con il coinvolgimento dei gruppi di Torino e Vercelli», secondo un piano operativo del generale Dalla Chiesa, che aveva preso le mosse dalle informazioni acquisite da Patrizio Peci.
Il Rapporto giudiziario 16/6 del Nucleo operativo dei Carabinieri di Genova, datato 3 aprile 1980, relativo alla scoperta di un « "covo" delle "Brigate Rosse" in Genova, via Fracchia n. 12/1 con conseguente decesso - a seguito di conflitto a fuoco - dei sottonotati terroristi [...]» indica i fatti avvenuti alle ore 4,30 circa della notte del 28 marzo.
Il Pubblico ministero di turno Filippo Maffeo, accompagnato sul posto dal maresciallo Calzetta, firmò un verbale di sopralluogo alle ore 6,55. Ma, nell'intervista resa il 14 febbraio 2004 al cronista Ferro, pubblicata sul "Corriere Mercantile", Michele Riccio precisa che «già in mattinata il dottor Di Noto e un altro pubblico ministero entrarono nel covo».
11.3 La ricerca dei documenti
Sempre Michele Riccio ha ricordato al cronista del "Corriere Mercantile" un particolare rilevante: «Il telefono [del covo di via Fracchia] squillò ancora. Questa volta era Dalla Chiesa. "So tutto, sto arrivando, dimmi cosa c'è". Voleva sapere quali documenti avevamo trovato. Mirava a quelli, obiettivo primario dell'operazione era acquisire nuove informazioni. Gli risposi che dentro la casa c'erano dei morti, che dovevamo ancora fare la perquisizione [...]. Entrai in cucina e cominciai a stilare il primo inventario del materiale che i miei uomini di volta in volta mi portavano dalle stanze. Ordinai che in casa non entrasse più nessuno [...]. Il sopralluogo dei magistrati non avvenne quattro giorni dopo. Già in mattinata il dottor Di Noto...».
L'analisi degli atti processuali - parzialmente acquisiti a causa della non disponibilità di parte di essi - e gli esiti dell'istruzione delegata a ufficiali di polizia giudiziaria e magistrati consulenti ha consentito di verificare quale Pubblio ministero effettuò il sopralluogo e quando ciò esattamente avvenne. E quale fu la sequenza della repertazione, anche in riferimento allo scavo effettuato dai carabinieri nel giardino pertinenziale.
Per quanto attiene alla cronologia degli eventi, dal complesso delle notizie di stampa circolate nell'imminenza degli avvenimenti risulta che il sottufficiale dei carabinieri rimasto ferito sarebbe stato ricoverato alle ore 6,00 del mattino, quindi circa sessanta minuti più tardi dell'orario riportato dalla versione ufficiale delle autorità. Il chirurgo di turno sarebbe stato svegliato alle ore 5,30 e chiamato in servizio per visitare il ferito e sottoporlo a intervento chirurgico, che poi sarebbe stato effettuato fra le otto e mezzogiorno.
La ricostruzione degli atti processuali acquisiti dal comando provinciale dei Carabinieri di Genova, parziale a causa del mancato reperimento del fascicolo negli archivi giudiziari, ha consentito di constatare che secondo il rapporto giudiziario prima citato l'irruzione sarebbe avvenuta alle ore 4 circa.
Tuttavia l'allegato referto siglato dal medico di guardia dell'ospedale San Martino di Genova attesta che il maresciallo Benà venne visitato alle ore 6,00. Il testo del fonogramma inviato dall'appuntato Di Pietro, in servizio presso il posto di Polizia del pronto soccorso del nosocomio, conferma che il sottufficiale venne ricoverato alle ore 6 per «ferita arma da fuoco in regione orbicolare destra» e ricoverato in prognosi riservata dal dottor Abbondati, evidenziando che «verso le ore 4,30 odierne nel perquisire un'abitazione di via Fracchia unitamente ad altri militari [...] aveva conflitto a fuoco con gli occupanti». Conseguentemente deve ritenersi che la mobilitazione del chirurgo reperibile sia da collegare alla richiesta di intervento dell'ambulanza ed alla segnalazione della natura della ferita al volto del Benà.
Tutti questi particolari evidenziano criticità nella rappresentazione della cronologia degli eventi, rilevanti ai fini dell'esatta ricostruzione delle fasi temporali dello scavo di un'ampia buca nel giardino del covo, non riferito in atti ma esplicitamente rievocato nel corso dell'esame del magistrato sostituto di turno recatosi sul posto, Filippo Maffeo, esaminato dai consulenti il 15 marzo 2017.
Infine, nell'editoriale dal titolo Quella telefonata nel cuore della notte pubblicato dal "Corriere mercantile" il 12 febbraio 2004, a firma del direttore Mimmo Angeli, si legge che «la telefonata arrivò nel cuore della notte. L'apparecchio di casa squillò alle tre. Una voce chiara dall'altra parte del filo disse: "Direttore c'è stata una strage di brigatisti in via Fracchia"».
Premesso che esula dall'economia della presente trattazione la rivisitazione della dinamica, è apparsa indispensabile l'esatta ricostruzione delle modalità e dei tempi della repertazione del materiale rinvenuto nel covo brigatista e, in particolare, della consistenza di quel tesoro colà asseritamente rinvenuto. Con queste finalità è stata condotta un'ampia attività istruttoria di cui di seguito sono evidenziati i risultati più significativi.
11.4. La telefonata notturna al "Corriere mercantile"
L'istruttoria delegata ha preso le mosse dall'esame del direttore del "Corriere Mercantile" Mimmo Angeli che, come già evidenziato, aveva svelato di essere stato raggiunto da una telefonata alle tre della notte del 28 marzo 1980, con la quale gli era stata rivelata l'avvenuta strage di brigatisti in via Fracchia..
Il particolare assume specifico interesse in quanto, se veritiero, costituisce un primo punto di riferimento nella ricostruzione degli accadimenti e, conseguentemente, ne definisce la sequenza temporale.
Nel corso dell'esame del 15 marzo 2017, il direttore Angeli ha confermato i contenuti di quell'editoriale e ha ribadito che la telefonata lo raggiunse nella propria abitazione: una voce femminile dal tono emozionato gli riferì laconicamente di una strage di brigatisti avvenuta in via Fracchia («in via Fracchia c'è stata una strage di brigatisti»). Si trattò di un telefonata proveniente da una persona in palese stato emotivo, una comunicazione del tutto diversa dagli annunzi dei comunicati delle Brigate rosse, che gli erano in precedenza giunti anche all'apparecchio di casa. Il direttore ritenne subito necessaria una verifica e chiamò il cronista di giudiziaria Attilio Lugli e il fotografo Luciano Zeggio, inviandoli in via Fracchia.
La ricostruzione di Angeli attesterebbe dunque che l'irruzione nell'appartamento brigatista avvenne poco prima delle tre della notte e risulta coerente con quanto scritto il 12 febbraio 2004 sul "Corriere Mercantile" da Andrea Ferro nell'articolo Il mistero della bomba a mano, sottotitolato L'orologio fermo alle 2,42, l'ora del conflitto a fuoco. L'articolo riferiva che «c'è un altro elemento molto importante per la ricostruzione "storica" dei fatti [...] Annamaria Ludmann portava un orologio con il cinghino di acciaio. Da un semplice ingrandimento della foto si vede, chiaramente, che le lancette sono ferme alle due e quarantadue. È la prova inequivocabile che il blitz scattò in quegli istanti. Nella scarna ricostruzione ufficiale non fu mai specificata l'ora esatta dell'intervento».
11.5. Le dichiarazioni del Pubblico ministero Maffeo
Il Pubblico ministero di turno della Procura genovese, Filippo Maffeo, nel ricordare di essere stato avvertito della situazione di via Fracchia dal maresciallo dei carabinieri Calzetta e di essere giunto sul posto all'incirca alle 6,45, ha precisato di aver notato il capitano Riccio su una sedia, a lungo ricurvo con le mani sulla testa. Altri carabinieri che non conosceva prima che gli avevano riferito di aver trovato subito dopo l'irruzione un piccolo arsenale dissotterrandolo dal giardino, dopo aver notato del terreno rimosso di recente.
Maffeo non ricorda segni evidenti di forzatura della porta di ingresso ma ricorda la presenza - già al momento del suo arrivo - all'interno dell'appartamento del suo collega Di Noto, intento a consultare documentazione che si trovava su di un tavolo. E precisa di aver avuto contezza solo delle armi, perché «le carte erano di là e le aveva viste solo il collega Di Noto».
Maffeo aggiunge che al suo arrivo nemmeno un saluto venne scambiato con il collega e ha precisato di avere visto in giardino uno scavo largo oltre un metro, "non molto profondo", tale da poter consentire l'interramento di alcune valigie. La buca era circondata da terreno smosso di recente.
Quanto alla repertazione, Maffeo ribadisce di essersi occupato solo del sequestro delle armi ritrovate nel covo, non del materiale documentale. E dichiara di non avere avuto mai notizia di documenti riferibili ad Aldo Moro nel covo di via Fracchia. Ma descrive di aver percepito un clima di tensione, riferendo anche di aver appreso subito che Dalla Chiesa era atteso a Genova. Infine, Maffeo indica come fatto notorio che Di Noto avesse un rapporto molto stretto con i Carabinieri.
La narrazione del Pubblico ministero di turno risulta compatibile con l'episodio accaduto in quel giardino in precedenza e riportato nel citato articolo pubblicato sul "Corriere Mercantile" di venerdì 13 febbraio 2014. Nell'articolo si riporta la ricostruzione dei fatti operata da una signora che abitava in un appartamento sovrastante alla base dellei BR, e, in particolare il suo ricordo di uno scavo in giardino fatto da un ospite della Ludmann.
Gli elementi qui evidenziati appaiono almeno in parte compatibili anche con quanto riferito ai consulenti dal magistrato Di Noto, che tra le sei e le sette del mattino dell'irruzione ricevuta una telefonata da un ufficiale dei carabinieri (non ricorda se Bozzo o Riccio) si recò nell'appartamento di via Fracchia con un'auto dei carabinieri e giunto sul posto vide «dei sacchi di nylon nero contenenti copiosa documentazione», ricordando il particolare che su taluni di essi vi era la scritta «da sotterrare». Quanto allo scavo in giardino, Di Noto ha precisato che nessuno gliene aveva parlato e di non aver alcun ricordo di una buca larga e circondata da terreno recentemente rimosso.
Lo stesso Di Noto ha poi evidenziato che tutto il materiale sequestrato nel covo di via Fracchia era stato messo a disposizione del collega Luigi Carli, mentre il sottufficiale dei carabinieri Chessa coadiuvava l'ufficio del Pubblico Ministero nella raccolta del materiale.
11.6. Le dichiarazioni di Luigi Carli e i successivi approfondimenti
All'epoca dei fatti di via Fracchia (marzo 1980) il sostituto Carli non era ancora titolare di deleghe in tema di BR. Lo diverrà successivamente subentrando ai colleghi Di Noto e Marchesiello.
Secondo Carli, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva caldeggiato, presso il procuratore Squadrito, la sostituzione di Marchesiello criticando la sua conduzione dell'istruttoria preliminare relativa al suicidio dell'avvocato Arnaldi, dopo che quel Pubblico ministero aveva escluso dalle indagini i Carabinieri (com'è noto, Eduardo Arnaldi muore suicida a Genova il 19 aprile 1980, circa un mese dopo l'irruzione in via Fracchia, quando i carabinieri vanno a casa sua per arrestarlo).
Carli ha dichiarato di non aver visto alcun documento riferibile ad Aldo Moro, precisando che i reperti formati in occasione dell'operazione nell'abitazione genovese di Annamaria Ludmann non erano stati mai a sua disposizione. Conseguentemente non aveva mai avuto notizia delle modalità di trasmissione all'Autorità giudiziaria degli atti sequestrati dai Carabinieri in via Fracchia. A specifica domanda, ha precisato di non essere stato mai informato di scavi nel giardino pertinenziale dell'appartamento occupato da Annamaria Ludmannn, eseguiti dai Carabinieri dopo l'irruzione, e nemmeno del rinvenimento in quel covo di sacchi di plastica scura con la scritta "da interrare".
Avuta lettura delle dichiarazioni verbalizzate da Di Noto in ordine al materiale sequestrato in via Fracchia, Carli ha ribadito - smentendo quindi l'assunto di Di Noto - di non averlo mai avuto a disposizione, ma di aver lavorato esclusivamente sul fascicolo degli atti istruttori relativi alla dinamica dell'azione, pervenutogli perché era stato delegato dal procuratore Squadrito a formulare le conclusioni scritte del Pubblico ministero.
Carli ha aggiunto di aver sentito parlare «per la prima volta di appunti manoscritti di Moro trovati in via Fracchia» nel corso di una o due riunioni con colleghi di altre sedi giudiziarie, nell'ambito del coordinamento informale stabilitosi in riferimento alle indagini sul terrorismo. A tale coordinamento partecipava avendo assunto la conduzione delle istruttorie genovesi.
In particolare, ha riferito di aver appreso l'esistenza di tali scritti dai colleghi torinesi Caselli, Laudi (giudici istruttori), Maddalena e Miletto (pubblici ministeri) ed ha pure evidenziato che «l'importanza del covo di via Fracchia era ben nota ai [suoi] colleghi di Torino che avevano gestito la collaborazione di Patrizio Peci, fonte dichiarativa che condusse i Carabinieri in via Fracchia».
Viceversa né il procurare titolare di Genova, Squadrito, né il suo aggiunto, Meloni, né Di Noto gli avevano mai mostrato siffatti manoscritti.
Il dottor Meloni - escusso sul punto -, dopo aver premesso di ricordare "ben poco del fatto di via Fracchia", si è limitato a non escludere commenti o confidenze del dottor Squadrito riguardanti un rinvenimento nella base logistica di via Fracchia di manoscritti di Aldo Moro, precisando di non conservare ricordo di ciò. In particolare ha affermato: «Con Squadrito non parlavamo di quello che avevano trovato, forse Luciano Di Noto sapeva qualcosa di più, non abbiamo parlato della storia di via Fracchia, se ne abbiamo parlato non ne ho ricordo".
In contrasto con questa dichiarazione, Carli ha evidenziato che dopo avere appreso una così rilevante circostanza aveva interloquito con Squadrito e Meloni, che vide insieme, senza ricevere alcuna risposta nel merito: in tale frangente gli venne solo detto che di quel materiale se ne occupavano ‘altri', senza ulteriori precisazioni. Ad avviso di Carli, Squadrito e Meloni erano certamente a conoscenza della consistenza, del contenuto e dell'allocazione fisica dei reperti sequestrati.
Carli ha poi ricordato che, all'atto di domandargli la stesura delle richieste conclusive del Pubblico ministero per il fascicolo relativo all'irruzione in via Fracchia, lo Squadrito gli disse: «Stia attento è scottante, perché molti sono interessati a questa vicenda» Frase che Carli interpretò come riferimento ad ambienti dei servizi segreti militari, poiché gli stessi già si erano fatti vivi nel corso delle indagini.
Carli ha inoltre ricordato che il giudice istruttore titolare del fascicolo relativo ai fatti di via Fracchia era il dottor Bonetto e ha spontaneamente aggiunto di aver appreso da uno dei sottufficiali che parteciparono all'irruzione, il maresciallo Elio Di Sabatino, che prima che i carabinieri entrassero nell'appartamento della Ludmannn, partì una raffica di PM12 e vari proiettili si conficcarono nella parete del pianerottolo del primo piano, proprio nei pressi della porta d'ingresso dell'appartamento di Annamaria Ludmann.
La rilevanza delle dichiarazioni istruttorie rese da Carli, dalle quali è emersa la consapevolezza dell'esistenza di manoscritti di Aldo Moro nel covo genovese di via Fracchia da parte dei magistrati di Torino che si occuparono della collaborazione di Patrizio Peci e anche un esplicito confronto sulla questione tra i capi della Procura genovese e lo stesso Carli ha indotto la Commissione ad audirlo, il 19 giugno 2017.
In quell'occasione, Carli ha ribadito che all'epoca dei fatti di via Fracchia non era ancora titolare di deleghe in tema di BR e di avere appreso dell'esistenza di scritti di Moro in via Fracchia da colleghi torinesi. Ha inoltre aggiunto: «Io sentii parlare di queste cose vagamente da Maria Giovanna Massa, che era la donna di Peci e che fece qualche accenno, che io però non approfondii, pure su questa cosa e su via Fracchia. Maria Giovanna Massa disse: "Sì, quell'uomo fece varie cose e portò al covo e trovarono materiale eccezionale"».
Con una nota del 19 giugno 2017 il dottor Caselli, all'epoca dei fatti giudice istruttore presso il tribunale di Torino e, ha smentito le dichiarazioni di Carli, precisando che «non mi risulta niente di niente di quel che viene attribuito al dott. Luigi Carli a seguito di dichiarazioni che egli avrebbe reso alla Commissione parlamentare Moro. Del resto, è fuori di ogni logica che la magistratura torinese possa aver 'deciso l'irruzione nel covo Br di via Fracchia' o possa essersene in qualche altro modo occupata. E ciò per la semplice ragione che la collaborazione di Patrizio Peci coi magistrati di Torino ebbe inizio soltanto il 1 aprile 1980. Prima di allora egli (in veste di semplice 'confidente' dei CC e non ancora di 'collaboratore di giustizia'), nel pieno rispetto della legge aveva avuto rapporti esclusivamente con il Nucleo speciale Antiterrorismo diretto dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono autorizzato dal collega
Marcello Maddalena a precisare (confermandolo a mia volta) che di Patrizio Peci in pratica egli non ebbe mai ad occuparsi. Mi è invece impossibile aggiungere anche la smentita di Maurizio Laudi (altro magistrato torinese che Carli avrebbe menzionato), essendo Laudi, com'è noto, deceduto da tempo».
Il punto dell'inizio della collaborazione di Peci è in effetti complesso ed è opportuno dare conto di questo delicato passaggio.
Peci era stato già sentito da collaboratori della Commissione il 29 ottobre 2016 e, in quella sede, aveva ricordato, senza fornire però precise scansioni cronologiche, che dopo aver manifestato la sua volontà collaborativa al maresciallo Angelo Incandela, fu messo in contatto con il capitano Santantonio e poi con il generale Dalla Chiesa e che «fu organizzato il mio trasferimento che prevedeva una sosta in una caserma piemontese, dove, come concordato, sarei stato raggiunto dai magistrati di Torino». Questa dichiarazione di Peci sembra riferirsi al primo verbale reso ai giudici Caselli e Griffey il 1 aprile 1980, che recita «Addì 1 aprile 1980 in Cambiano Caserma dei CC alle ore 8,30, dinanzi ai GG.III del Tribunale di Torino Giancarlo Caselli e Mario Griffey, con l'intervento del PM nella persona del sost. proc.Rep.dr.Alberto Bernardi [...] compare l'imputato infrascritto. Si attesta preliminarmente che il
G.I. Caselli alle ore 7,05 odierne ha ricevuto comunicazione telefonica secondo cui Peci Patrizio, durante la traduzione dalla casa circondariale di Torino ad altra ha chiesto di conferire con il caposcorta, facendogli presente di volere urgentemente e improrogabilmente parlare con un magistrato, come risulta dal verbale che si allega al presente atto».
Nel volume Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia (Milano, 2009), lo stesso dottor Caselli ha rievocato la vicenda, fornendo ulteriori particolari, sulla collaborazione di Peci(32), sviluppatasi a partire dall'attività investigativa di Dalla Chiesa, che riuscì a cogliere, grazie al maresciallo Incandela, i segni di una disponibilità di Peci.
Un elemento importante per valutare le contrastanti dichiarazioni è che gli uomini del generale Dalla Chiesa alle prime ore del 28 marzo del 1980 realizzarono in Piemonte una grande operazione volta a disarticolare la colonna delle BR, e ciò proprio grazie alle dichiarazioni raccolte da Patrizio Peci che ne era al vertice. Ed anche l'irruzione in via Fracchia venne coordinata con le operazioni condotte dai gruppi dei carabinieri di Torino e Vercelli.
In proposito, nelle dichiarazioni rese a collaboratori della Commissione, Michele Riccio ha ribadito che «l'operazione di via Fracchia nasce da un'iniziativa del generale Dalla Chiesa» che lo mise subito al corrente dell'«inizio della collaborazione con un pentito importante, ai vertici delle brigate rosse torinesi, Patrizio Peci». Conseguentemente su disposizione del generale, Riccio aveva incontrato il Peci nel carcere di Cuneo dove c'era il maresciallo Incandela, con un accesso legittimo sia pure connotato da cautele per non esporre il dichiarante. Riccio ha precisato: «Mai mi fu fatto presente che la magistratura non era stata informata».
Dalla Chiesa informò Riccio che «l'operazione doveva essere concomitante con quella di Torino», in quanto «avrebbe investito l'intera colonna torinese e, pertanto, avrebbe condotto immediatamente al dichiarante [Patrizio Peci]», sicchè «se non fosse stato effettuato un intervento in contemporanea avremmo perso la base genovese» (in quanto quella base era nota a Peci perché vi si era svolta una riunione della direzione strategica delle BR con la sua partecipazione).
Quanto alle modalità della pianificazione operativa del blitz, Riccio ha ricordato che «il colonello Bozzo ebbe il compito di informare preventivamente il dott. Castellano, consigliere istruttore, e lo stesso Prefetto di Genova» e che «il profilo e la natura del coordinamento» lo inducevano a ritenere che «la stessa partecipazione avvenne a Torino. Ovviamente i magistrati di Torino dovevano sapere che si sarebbe intervenuti anche a Genova. A parlare con i magistrati era sempre il colonello Bozzo, sia a Genova sia a Torino, in quanto lo stesso aveva la responsabilità operativa per l'Italia nordÂoccidentale».
12. Le indagini su un possibile covo nell'area della Balduina
È noto che, sin dall'inizio delle indagini la zona della Balduina fu oggetto di particolare attenzione. Si trattava del resto di un'area prossima a via Fani, nella quale furono abbandonate le auto usate dai terroristi.
La Commissione ha puntualmente verificato che furono compiuti una pluralità di accertamenti su stabili della zona a partire dal 17 marzo, da parte della Polizia, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo dei vigili urbani. Tali accertamenti sembrano tuttavia non aver riguardato uno degli edifici che, per le sue caratteristiche e per le indicazioni dei testimoni, presentava elementi di particolare interesse.
Di qui si è sviluppato un consistente filone di indagine, che ha cercato di rispondere alla questione, già posta nell'imminenza degli avvenimenti, se esistesse un edificio che poté servire da punto di appoggio ai brigatisti o, addirittura, da prigione di Moro.
12.1 L'abbandono delle auto dei brigatisti
Uno degli elementi di maggiore criticità che emergono nel "memoriale" Morucci è la ricostruzione dell'abbandono delle auto usate in via Fani. Queste, come è noto, furono ritrovate in momenti diversi.
In particolare, sulla base dei verbali di reperimento e delle testimonianze raccolte a suo tempo e presenti agli atti della prima Commissione Moro, risulta che l'autovettura Fiat 132 di colore blu con applicata la targa Roma P79560 dovette essere parcheggiata tra le 9.15 e le 9.23; l'autovettura Fiat 128 di colore bianco, con applicata la targa Roma M53955, fu reperita il 17 marzo 1978, alle 4.10, all'altezza del civico 23 di via Licinio Calvo, sul lato destro della strada; l'autovettura Fiat 128 di colore blu, telaio nr. 1390208, con applicata la targa Roma L55850, fu reperita il 19 marzo 1978, alle 21, tra i civici 25 e 27 di via Licinio Calvo, sul lato destro della strada.
Nella versione brigatista condensata nel "memoriale Morucci" si afferma invece: «Tutte e tre le auto sono state parcheggiate in via Licinio Calvo la stessa mattina del 16 marzo, nello spazio di tempo di circa venti minuti dopo l'azione di via Fani (e cioè tra le 9.10 e le 9.30). La 132 è stata parcheggiata da Fiore subito dopo che era stato effettuato il trasbordo di Moro sul furgone 850 in piazza Madonna del Cenacolo».
Tale assunto appare problematico alla luce delle intense ricerche che venivano condotte nell'area, specialmente dopo il reperimento della prima auto, ed è in contraddizione con numerose testimonianze.
In particolare, la testimone Maria Assunta Perugini afferma di aver visto a bordo della Fiat 132, parcheggiata in Via Licinio Calvo, due uomini euna donna, mentre, secondo il Morucci, l'autovettura sarebbe dovuta provenire da Piazza Madonna del Cenacolo con il solo Raffaele Fiore a bordo. Anche un altro ignoto teste, riporta la presenza di una donna. Ciò si rileva dal registro delle comunicazioni della Questura in cui, alle 9.27, è annotato: «Sq4. Da Via Licinio Calvo si sono allontanati due giovani a piedi, una donna ed un uomo armati». Affinchè a bordo della 132 vi sia una donna, sia che questa sia la Balzerani, che Morucci pone in partenza da Via Fani sulla 128 blu, sia che si tratti di un'altra donna ignota, l'autovettura più importante del "commando", quella che trasporta l'ostaggio, deve essersi fermata in un luogo diverso rispetto a quanto noto.
Di particolare rilievo è poi la testimonianza Elsa Maria Stocco, abitante in via Bitossi, che venne sentita il 17 marzo 1978. La Stocco affermò che alle 9.25 del 16 marzo, dopo essere scesa dalla propria autovettura e aver fatto un tratto di marciapiede, aveva notato un'autovettura di grossa cilindrata giungere da via Massimi a forte velocità e fermarsi proprio davanti al suo civico, il 26. Da questa era sceso un uomo di aspetto giovanile con abito da pilota civile e impermeabile blu, privo di berretto, che prima aveva trasferito in un furgone di colore chiaro, alla cui guida era posto un giovane, una valigia e, dopo essere tornato all'auto, un borsone scuro.
Il 14 giugno 1978 la Stocco precisò che quanto osservato era accaduto tra le 9.20 e le 9.25, poiché alle 9.30 aveva già potuto ascoltare il radiogiornale con la notizia della strage di via Fani. Un'autovettura "ministeriale" - la Fiat 132 - fu vista provenire da via Massimi e fermarsi in via Bitossi, affiancata quasi trasversalmente alla destra di un furgoncino. Dall'auto uscì un giovane vestito da steward con una 24 ore e un borsone che caricò sul furgoncino, senza scambiare alcuna parola con il giovane alla guida di quest'ultimo. L'autovettura si allontanò in velocità verso via Pietro Bernardini. Il furgoncino, invece, imboccò la medesima strada, ma a normale andatura. Morucci, dalla narrazione, lascia intendere di essere sceso da un mezzo parte di un drappello di tre auto in fuga. Ma questo drappello non viene affatto visto dalla Stocco e non c'è alcuna ragione di ritenere
che la teste fosse in errore.
Paolo Nava - presentatosi spontaneamente il 20 marzo 1978 presso gli uffici del commissariato di polizia di Monte Mario - che risiedeva in via Lucilio 37 (cioè a poche decine di metri da via Licinio Calvo), dichiarò: «Stamane dalla stampa quotidiana, ho appreso che ieri sera [19 marzo] è stata rivenuta l'auto Fiat 128 di colore blu, targata Roma L5 - non ricordo gli altri numeri - che ha attinenza con il sequestro dell'onorevole Aldo Moro. In proposito posso affermare quanto segue: Sabato 18 corrente, all'incirca verso le ore 18, insieme a mia moglie sono transitato per via Licinio Calvo, strada per me d'obbligo che percorro diverse volte al giorno [...] non ho notato in sosta alcuna 128 blu ed in particolare dove in seguito ho visto posteggiata l'auto Fiat 128 blu [...] rinvenuta dalla polizia. Preciso che tale auto l'ho notata alle 0,30 circa del 19 marzo 1978. Faccio presente che, nel pomeriggio del 18 corrente, sono passato
per via Licinio Calvo almeno tre volte e non ho mai notato la predetta auto. Quindi è da escludere che detta auto poteva essere parcheggiata nel punto in cui è stata rinvenuta, prima delle ore 18 di detto giorno 18 marzo 1978 [...] Ripeto che la predetta auto l'ho vista in sosta nel punto in cui è stata rinvenuta solo alle ore 0,30 del 19 marzo 1978».
Va poi ricordato che Morucci sostiene che in Via Bitossi era parcheggiato un autofurgone grigio chiaro presso il quale egli si sarebbe recato a piedi dopo essere sceso dalla Fiat 128 blu, caricandovi sopra le borse prelevate dall'auto dello statista. Lui stesso si sarebbe posto alla guida del medesimo per portarsi in Piazza Madonna del Cenacolo ove Moro sarebbe stato trasbordato dalla Fiat 132 al furgone. Si tratta di un automezzo mai recuperato e che sarebbe stato lasciato incustodito, a rischio di compromettere l'intera operazione.
Conclusivamente, all'atto del rinvenimento della 132 erano trascorsi circa 20 minuti dall'inizio dell'azione. Si può ritenere che solo dopo, in tempi diversi e con sensibili intervalli di tempo, vennero abbandonati gli altri due veicoli adoperati dalle BR per allontanarsi dall'incrocio via Fani-via Stresa.
Già la prima Commissione Moro, nel ricostruire le modalità dell'allontanamento degli attentatori dalla scena del crimine, aveva ritenuto «presumibile che essi abbiano [...] utilizzato qualche base di appoggio nelle vicinanze di via Licinio Calvo per trasbordare il prigioniero, abbandonando le auto dell'agguato».
In questo quadro ha particolare rilievo il tema del trasbordo - accreditato da Morucci - di Moro dalla Fiat 132 a un furgone in piazza Madonna del Cenacolo. Tale punto di snodo tra la prima fase della fuga da via Fani e il definitivo allontanamento dalla scena del crimine presenta numerosi elementi di illogicità, già evidenziati nella precedenti relazioni. Di qui l'ipotesi, che il passaggio delle auto utilizzate in via Fani da via Casale De Bustis sia servito in realtà a depositarle nella zona - eventualmente anche con il rapito - per poi gestirne il rilascio progressivo. Ciò pone ovviamente il tema dell'identificazione dell'edificio che potrebbe essere stato utilizzato per tale operazione.
La Commissione ha compiuto molti accertamenti in proposito, anche attraverso una complessiva rilettura delle indagini a suo tempo compiute, di cui si forniscono i primi esiti. Poiché questi sono oggetto di valutazione della Procura di Roma, saranno indicati solo una parte degli elementi emersi nell'inchiesta.
12.2 Le indagini in area e la fonte della Guardia di finanza
Secondo un appunto del 17 marzo 1978, acquisito agli atti della Commissione, «fonte confidenziale degna di fede» della Guardia di finanza aveva segnalato che lo statista era detenuto nella zona «Balduina-Trionfale-Boccea-Cassia», con un solo carceriere. Lo stesso segnalava anche che «i brigatisti Lauro Azzolini, Rocco Micaletto e Giustino De Vuono sicuramente sono nella Capitale». Tale fonte, mai identificata, opera sin dalla fase iniziale del rapimento e, non risultando retribuita, può identificarsi in persona di qualche caratura, ben nota ai gestori della stessa. Il valore delle informazioni fornite appare notevole ed essa non può essere confusa con le molteplici e spesso incongrue segnalazioni che giunsero alle Forze di polizia durante tutto il sequestro Moro.
Nei giorni successivi furono forniti altre indicazioni. Il 21 marzo 1978, la stessa fonte della Guardia di finanza di cui all'appunto del 17 marzo 1978, come è comprensibile dal riferimento alla zona già segnalata, riferì che quanto prima lo statista sarebbe stato trasferito nella "prigione del popolo". Dagli atti risulta che la fonte non fu in grado di delimitare meglio la zona che aveva indicato, esprimendo solo un suo parere riguardo a un raggio di circa due chilometri da via Fani. La notizia venne fornita dal Comandante generale della Guardia di finanza al questore Fariello, direttore dell'UCIGOS.
Il 22 marzo 1978, così almeno sembra dall'annotazione manoscritta in calce all'atto, la Guardia di finanza produce un terzo appunto relativo a una notizia confidenziale originata dalla medesima fonte. L'appunto questa volta prende spunto dal ritrovamento della Fiat 128 blu. A a detta della fonte, immediatamente dopo il rapimento, frase che risulta cancellata con tratto irregolare manoscritto, la 128 blu sarebbe stata parcheggiata in un garage o in un box ubicato nella zona segnalata con il primo appunto. La fonte prosegue poi con la notizia più importante, tanto è vero che i gestori della fonte stessa la sottolineano: la presenza di un covo brigatista nella zona suddetta, ubicato ad un piano elevato, 5°, 6° o 7°. A questo appartamento/covo sarebbe possibile accedere dall'ingresso principale con un ascensore prendibile anche dal garage interrato.
Il 19 marzo 1978, come risulta dagli atti acquisiti dalla Commissione presso il commissariato Monte Mario, il brigadiere Pasquale D'Annunzio informò il suo superiore, il commissario Marinelli, degli esiti negativi delle verifiche da lui stesso effettuate nella zona della Balduina mediante perquisizioni, unitamente all'equipaggio dell'auto radiocollegata "Monte Mario" e al pattuglione operante in quella circoscrizione con sigla radio "Roma Narni 108", sulla base segnalazioni fornite dalla DIGOS e dalla Questura.
Tra queste se ne nota una di interesse: infatti, alle 15.15 dello stesso giorno, la Sala operativa della Questura di Roma comunicò che un anonimo aveva riferito che in via Massimi, via Anneo Lucano, via Licinio Calvo «sarebbero nascoste le Brigate rosse e lui ci avrebbe indicato l'appartamento che [sic!] si accede attraverso un garage».
Come si può notare, nella sostanza le due notizie, quella dell'anonimo segnalatore alla Sala operativa della Questura e quella della fonte della Guardia di finanza, sono sovrapponibili: c'è un legame garage-covo.
Riscontri dell'attività della Fonte si hanno nei cosiddetti "appunti Lettieri" relativi alle riunioni del comitato politico-tecnico-operativo istituito presso il gabinetto del Ministero dell'interno, che non danno conto di riunioni avvenute tra il 18 e il pomeriggio del 21 marzo 1978. Nella riunione delle ore 17.30 del 21 marzo, in relazione all'intervento del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Raffaele Giudice, è riportato: «Riferisce che fonti riservate hanno confermato la presenza dell'On. Moro in Roma nella zona Trionfale, Balduina, ecc. Nei prossimi giorni verrebbe trasferito in altra località per essere processato dal tribunale del popolo».
Ancora, nella riunione delle ore 19.30 del 22 marzo, il generale Giudice tornò chiaramente sull'argomento: «Una fonte sosterrebbe che il rapito si trova nella zona di Monte Mario e che finora non è stato trovato in quanto le perquisizioni non sono state fatte a tappeto». Si noti come il generale Giudice si sia avvalso di un'espressione in parte simile a quella usata dalla fonte. Il 28 marzo, nella riunione delle 19.30, Giudice riferì: «Continueranno i pattugliamenti nella zona di Monte Mario». Ciò sembrerebbe confermare l'elevato grado di attendibilità che la Guardia di finanza riponeva nella propria fonte.
Le attività di riscontro appaiono tuttavia carenti sotto molteplici profili. Nonostante molti edifici della zona siano stati controllati, anche nei mesi successivi, non si rileva una puntuale valorizzazione delle indicazioni della fonte.
12.3 Le palazzine di via Massimi 91
Gli accertamenti sviluppati hanno dimostrato che mai, dal 1978 ad oggi, era stato svolto un serio lavoro accertativo sui condomini di Via Massimi 91.
Le palazzine in questione appartenevano all'Istituto per le opere di religione. Furono realizzate dalla s.r.l. Prato Verde, Via della Conciliazione 10, riconducibile allo I.O.R, di cui era amministratore unico Luigi Mennini, padre di don Antonello Mennini, che, come noto, ebbe un ruolo importante nella vicenda Moro.
Nel 1978 il complesso edilizio in Via Massimi 91 - successivamente frazionato - aveva accessi non solo dalla stessa Via Massimi, ma anche da Via della Balduina, precisamente tramite un cancello contrassegnato dal civico 315 e da un'autorimessa di cui al civico 323 di quest'ultima strada. Nel tempo, ma dopo il 1978, furono eseguite alcune variazione di accessi, assegnazioni di nuovi civici, nonché sostituzioni di cancelli.
Gli accertamenti condotti hanno evidenziato la presenza nel complesso di un milieu abbastanza elevato e di alcuni cardinali e prelati, come il cardinale Egidio Vagnozzi, già delegato apostolico negli Stati Uniti e, dal 1968, Presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede, e il cardinale Alfredo Ottaviani. Risulta inoltre, da alcune testimonianze, un'assidua frequentazione del complesso da parte di monsignor Paul Marcinkus. Alcune testimonianze indicano anche una frequentazione dei prelati in questioni da parte dell'onorevole Moro e dell'onorevole Piccoli.
All'interno del complesso si riscontrano tuttavia anche presenze di altro genere, che potrebbero aver avuto una funzione specifica in relazione al sequestro Moro.
Si è in particolare riscontrato che in quelle palazzine abitava la giornalista tedesca Birgit Kraatz, già attiva nel movimento estremista "Due giugno" e compagna di Franco Piperno. Secondo la testimonianza di più condomini Piperno frequentava quell'abitazione e, secondo una testimonianza che l'interessato ha dichiarato di aver appreso dal portiere dello stabile, lo stesso Piperno avrebbe da lì osservato i movimenti di Moro e della scorta. La stessa Kraatz ha ricordato la sua relazione con il Piperno, ma ha escluso che si trattenesse nel condominio.
In proposito, altri testi, escussi da collaboratori della Commissione, hanno aggiunto ulteriori particolari di interesse, sebbene allo stato non riscontrati. In particolare una teste ha dichiarato che uno dei condomini, il generale del Genio Renato D'Ascia «disse a mio marito [...] diversi anni fa, ma comunque molti anni dopo il sequestro Moro, che nella Palazzina B c'era un covo delle Brigate Rosse legato al sequestro dello statista e che proprio nei giorni dell'eccidio di Via Fani ci fu movimento tra il garage seminterrato della Palazzina ed il covo. Cioè qualcuno era passato dal garage. Posso solo dedurre, non essendo la diretta recettrice della confidenza, che l'ingresso si realizzò a mezzo auto. Purtroppo non sono in grado di dare nessuna indicazione relativa al piano cui si sarebbe situato, ma posso aggiungere che egli disse a mio marito della cittadina tedesca del piano terra, che ricordo chiamarsi Birgitte. Io sono convinta che
il D'Ascia, avendolo ben conosciuto, fece presente questa cosa a chi di dovere, non se la sarebbe mai tenuta...».
Il generale D'Ascia era un ufficiale del Genio, che operò anche in ambito SISMI, e che, come confermato dal figlio, manteneva rapporti di lavoro con la Guardia di finanza. È ipotizzabile che egli possa essere stato un possibile informatore della Guardia di finanza circa la localizzazione della "prigione" di Moro.
Accanto a queste presenze legate al mondo dell'Autonomia operaia romana, i condomini in oggetto presentano altre e diverse emergenze investigative. Oltre ad una serie di personaggi legati alla finanza e a traffici tra Italia, Libia e Medio Oriente va sottolineata la presenza di una società statunitense, la Tumpane company, cessata in data 30 giugno 1982, con attività "servizi vari", sede legale negli Stati Uniti d'America e domicilio fiscale in Via Massimi 91 a Roma.
La Tumpane si identificava con la TUMCO, compagnia americana che nel 1969 forniva assistenza alla presenza NATO e statunitense in Turchia.
La Tumpane ha cessato le proprie attività l'11 novembre 1982. Quale titolare di cariche viene indicato Alberto Colombini, nato a Livorno il 26 giugno 1930. Il Colombini è un dirigente d'azienda che all'atto della dichiarazione notarile specifica che la Tumpane opera anche per la «riparazione, ricostruzione, manutenzione, commercio e collaudo di qualsiasi tipo di velivolo ed attrezzatura aerea e missili ed attrezzature connesse (comprese le elettroniche); costruzione, riparazione, collaudo, commercio di qualsiasi tipo di attrezzatura per il collaudo, immagazzinaggio, lancio, manutenzione e puntamento di missili»; a seguire, si noti: «svolgere servizi alimentari». È stato tuttavia possibile accertare testimonialmente che la Tumco svolgeva attività di intelligence a beneficio di organo informativo militare statunitense la cui sede era in edificio di Via Veneto a Roma, gergalmente noto come "The
Annexe". Come ipotizzato sulla base dei siti presenti in Italia della Tumpane Company, essa svolgeva ufficialmente compiti di supporto alla rete statunitense di rilevamento radar, in appoggio alla NATO, denominata Troposcatter/NADGE. Nonostante ciò, nulla era stato comunicato alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri competenti per territorio.
Risulta inoltre che i titolari statunitensi della Tumpane appartenessero ad ambienti del cattolicesimo tradizionalista statunitense. In particolare, il fondatore, John J. Tumpane era Presidente distrettuale della Society of the Holy Name, una organizzazione laicale legata ai domenicani.
Tra le altre presenze significative nel complesso c'è poi quella di Omar Yahia (1931-2003), finanziere libico, legato all'intelligence libica e statunitense, e in rapporti anche con gli occupanti dell'appartamento di cui all'interno 4 della Palazzina 3A del civico 96 di Via Massimi. Yahia collaborò lungamente con i Servizi italiani, in particolare col colonnello Sasso. Come ricordato in altra sezione della relazione, il ruolo dello Yahia, ampiamente trattato nella sentenza-ordinanza "Abu Ayad", emerse nelle nelle indagini sulla vicenda dei terroristi palestinesi arrestati a Ostia nel 1973 e consegnati alla Libia. Oltre a collaborare con il SID Yahia assunse nella sua società il colonnello Giovanni Battista Minerva, già Capo ufficio amministrazione del SIFAR e poi del SID, dopo che questi lasciò il Servizio segreto italiano. Yahia fu molto probabilmente la persona che mise in contatto la fonte "Damiano", che
fornì qualificate informazioni sulle Brigate rosse, con i Servizi italiani. La presenza dei suoi uffici in via Massimi 91 conferma la densità delle presenze di intelligence che caratterizzò quel condominio.
12.4. La pubblicazione di Di Donato
Nell'autunno 1978 comparve, il 15 novembre 1978, sul quotidiano "Il Tempo", di un articolo dal titolo Uno scrittore americano "ricostruisce" il caso Moro, redatto dal giornalista Giuseppe Longo. Longo commentava il lavoro Christ in plastic di uno scrittore italo-americano, Pietro Di Donato, pubblicato sul numero di dicembre 1978 della rivista "Penthouse".
L'autore spiega che l'allora sessantassettenne scrittore sarebbe stato amico di un senatore del PCI il quale da tempo lo aveva messo in contatto con un personaggio chiamato R1, uomo d'affari di successo, ma rivoluzionario e implicato in azioni contro il potere costituito. Il primo maggio 1978 Di Donato sarebbe venuto a Roma e avrebbe incontrato R1. Costui gli avrebbe spiegato come entrare in contatto con R2, personaggio che aveva accesso alla cellula principale che aveva portato a termine il sequestro Moro. Di Donato avrebbe asserito di aver potuto ricostruire la situazione «con due brigatisti amici della famiglia Moro». Longo riferisce anche che, secondo Di Donato, Moro sarebbe sempre rimasto nella stessa prigione, dalla quale si poteva accedere da un garage con ingresso su via della Balduina, fino alla vigilia della morte, quando, per ragioni di sicurezza, sarebbe stato portato in una località di mare nei pressi di Roma.
Gli accertamenti compiuti, trasfusi in una nota del 17 novembre 1978 del commissario Marinelli al questore di Roma, si indirizzarono però - sulla base di ipotesi investigative non note - soprattutto «nella parte alta di Via della Balduina [...] ove esisterebbe un garage attraverso il quale i rapitori dell'On. Moro lo avrebbero condotto nel luogo di prigionia», non dunque nella parte "bassa" dove si trova l'edificio individuato.
Allo stesso tempo, Marinelli segnalò che in via della Balduina 323 esisteva l'accesso al garage privato di due palazzine con ingresso principale in via Massimi 91 di proprietà dello IOR, riportando che l'ingresso del garage era isolato ed era stato ricavato entro un muro di cinta alto tre metri e lungo un centinaio di metri e che, quindi, «potrebbe essere quello indicato nell'artico(lo) definito "mimetizzato"». Questa intuizione investigativa non sembra però aver prodotto esiti. Marinelli riferì infatti che «anche tale autorimessa è stata ispezionata ma nessun elemento è emerso a conferma di quanto riferito nell'articolo»
In proposito va segnalato che tra gli atti acquisiti dalla Commissione presso il commissariato Monte Mario si trova la relazione di servizio del 16 novembre 1978, dalla quale risulta che i marescialli Saverio Abbondandolo e Ippolito Salvatore e la guardia Giovambattista Mazzarella, del commissariato Monte Mario, riferirono di aver «eseguito un controllo ai garage privati (non sussistono autorimesse pubbliche) esistenti in Via della Balduina, tratto - Piazza omonima - Via Massimi», con esito negativo.
I tre operanti di polizia giudiziaria riportano inoltre una interessante osservazione: «Tuttavia, facciamo presente che il garage descritto nell'articolo cui si fa riferimento, potrebbe essere quello esistente in Via della Balduina n. 323. Detto garage fa parte del complesso edilizio composto da due palazzine con ingresso principale da Via Massimi n. 91 di proprietà dell'Istituto Opere Religiose con sede in Roma - Via della Conciliazione n. 10. L'ingresso del garage si trova al centro di un muro alto circa tre metri e lungo oltre 100 metri. L'interno del garage è composto da un lungo corridoio sul quale si affacciano i box privati muniti di porte ed inferriate. Alle spalle dei box esistono le cantine. Le intercapedini di entrambe le palazzine sono larghe circa 60-70 cm. e sono praticabili e prendono luce dalla parte superiore lungo i marciapiedi mediante feritoie e vetro-cemento».
Nell'autunno del 1978 fu dunque individuato un complesso immobiliare che potrebbe essere quello trattato nel "pezzo" dello scrittore italoamericano. Si tratta appunto delle due palazzine dello IOR che hanno l'ingresso principale in Via Massimi 91, con garage privato dal quale si accede da Via della Balduina 323. Il Commissario riferisce di avere fatto ispezionare l'autorimessa, ma che già a suo tempo erano stati fatti accertamenti nella parte alta di Via della Balduina, come peraltro scrive Di Donato.
Stando invece al resoconto delle operazioni coordinate dalla Questura di Roma in relazione all'eccidio di Via Fani ed al sequestro dell'onorevole Aldo Moro, sino al 7 maggio 1978, i due civici che individuavano il verosimile complesso cui avrebbe alluso Di Donato non vennero toccati. Dal complesso delle attività coordinate dalla Questura di Roma, queste si rivolsero verso le abitazioni poste lungo il tragitto del convoglio brigatista indicato dai testimoni, verso luoghi abbandonati o diroccati o che potevano prestarsi a ricoveri di fortuna, verso abitazioni evidenziatesi nelle attività investigative. Vennero inoltre talvolta realizzati veri e propri controlli intensivi di determinate vie o zone della Capitale e della provincia.
L'ipotesi che il garage fosse localizzato in quella zona è rafforzata dal secondo verbale di rinvenimento del 16 marzo 1978, redatto da personale del gabinetto regionale della Polizia scientifica della Questura di Roma, inerente la nota Fiat 132 targata Roma P79560, nel quale si legge: «Sull'alloggiamento del mandante del congegno di chiusura dello sportello posteriore destro, poggia uno stelo di infiorescenza arborea, contrassegnata con la lettera "Y" [...] In prossimità dell'angolo posteriore destro del canaletto della sede del bordo del coperchio del portabagagli, si rinvengono altre infiorescenze arboree ed alcuni peli, contrassegnati con la lettera "O"».
La zona presentava all'epoca ancora caratteristiche semiurbane. Da via Massimi era possibile accedere a piedi o in auto da via della Balduina, per giungere al civico 323. Il tratto era però disagevole, con fessurazioni dell'asfalto ed erbacce, nonché stretto tra il muro di cinta del comprensorio ed una macchia di sambuchi, frequentata da animali randagi.
Va pure segnalata la presenza, nel complesso, di modifiche abitative oggetto di approfondimenti. In particolare risulta che, presso l'attico della Palazzina B, fu realizzata una sorta di camera compartimentata, un piccolo vano nel quale poteva tranquillamente stare una persona, costruito sul terrazzo dell'attico e appoggiato ad uno dei muri dell'appartamento di modo da far risultare una delle pareti in muratura. Il locale è situato nella parte di servizio dell'appartamento, cosicché, isolandola con cartongesso da quella padronale, un eventuale soggetto temporaneamente custodito nella "cameretta" poteva poi avere a sua disposizione lo spazio e i servizi di un miniappartamento.
12.5. La latitanza di Gallinari in via Massimi
Le indagini compiute hanno consentito di identificare due persone, allora conviventi in via Massimi 91, che hanno riconosciuto di aver ospitato, per diverse settimane, nell'autunno 1978, Prospero Gallinari in un'abitazione sita nel complesso. Tale affermazione è stata oggetto di verifiche con l'escussione di Carlo Brogi e Norma Andriani, nonché nell'audizione di Adriana Faranda.
Le due persone in oggetto partecipavano, in vario modo, alla mobilitazione che caratterizzò molti ambienti della sinistra extraparlamentare nel periodo del sequestro Moro. In particolare, dal complesso delle escussioni e audizioni svolte, è risultato che la donna, con trascorsi nel femminismo militante e attiva nel collettivo di via del Governo Vecchio, strinse una relazione piuttosto stretta con una brigatista della colonna romana, Norma Andriani, e forse col compagno di quest'ultima, Carlo Brogi, mentre l'uomo, anche se appartenente alle Forze armate, frequentava ambienti extraparlamentari.
Questa rapporto indusse la Andriani a proporre di ospitare un compagno, che - secondo quanto dichiarato dagli interessati - solo successivamente i due identificarono in Prospero Gallinari.
Fu dunque procurato un appuntamento alla donna con Adriana Faranda, mentre l'uomo, nel rispetto delle regole di compartimentazione della clandestinità, si incontrava separatamente con Valerio Morucci. Ad entrambi, fu richiesto supporto logistico al fine di ospitare brigatista rosso ricercato, dopo che Faranda e Morucci li ebbero sottoposti a una valutazione politica simile a quella in uso per il reclutamento di militanti irregolari. In una prima fase ci fu un impegno a ricercare un alloggio per Gallinari, ma poi si ritenne preferibile ospitarlo in via Massimi 91, dove Gallinari rimase per alcuni mesi dell'autunno 1978, prima di un successivo trasferimento avvenuto prima del Natale di quell'anno.
I due testimoni non hanno fornito molte indicazioni sul periodo in cui Gallinari stette a casa loro. È emerso che furono custodite armi in cantina e che fu fornito supporto al brigatista nel trasporto di una borsa, verosimilmente contenente armi, che fu data a una persona a piazza Madonna del Cenacolo.
Stando alle dichiarazioni degli interessati, la crescita della pressione e l'insorgere di timori indussero a chiedere a Gallinari di trovare un altro rifugio.
L'episodio della latitanza di Gallinari in via Massimi suscita una pluralità di questioni. Certamente l'indagine ha consentito di scoprire un ulteriore tassello di quell'ara di contiguità, talora propensa a trasformarsi in militanza attiva, seppure "irregolare", che favorì lo sviluppo del terrorismo brigatista.
Allo stesso tempo, però, è emersa la sicurezza offerta dall'abitazione di via Massimi, sia per la sua caratteristica di avere un doppio ingresso sia anche per il carattere riservato del condominio. Non a caso, Gallinari dovette ricercare una nuova abitazione in quel periodo, in cui la caduta di via Monte Nevoso e di altri covi brigatisti dovette indurre a ricercare sistemazioni sicure. Il passaggio a via Massimi potrebbe coincidere temporalmente con l'abbandono del covo di via Montalcini.
Emerge pure la contemporaneità della presenza di Gallinari in via Massimi con i noti articoli di Longo e Di Donato, che potrebbero essere stati redatti proprio a partire da informazioni di cui gli autori poterono entrare in possesso su quel complesso edilizio, riservato eppure, per sua natura, permeabile in quanto abitato anche da personaggi che si muovevano sul terreno di relazioni internazionali e di intelligence.
Allo stato, non è stato possibile accertare, per il periodo del sequestro Moro, l'operatività brigatista delle due persone che favorirono la latitanza di Gallinari. Colpiscono tuttavia una serie di assonanze tra le informazioni veicolate dagli articoli di Longo e Di Donato e dal noto fumetto sulla vicenda Moro apparso in "Metropoli" e la presenza di due fiancheggiatori che presentano alcune caratteristiche comuni con i brigatisti che, secondo Di Donato, vigilavano sul garage. Analoghe assonanze si rilevano pure tra il riferimento a una perquisizione infruttuosa di polizia e quanto accadde in via Massimi, dove, come ha ricordato una delle due persone che ospitarono Gallinari, alcuni giorni dopo il sequestro Moro si presentarono forze di polizia non meglio identificate che il teste vide parlare con il portiere.
Va infine considerato il carattere strategico della palazzina di via Massimi che, come ricordato da più testimoni, disponeva di un doppio ingresso, quello su via Massimi e quello, del garage, su via della Balduina. Proprio una delle persone escusse in relazione alla latitanza di Gallinari ha precisato che questi «dava la sensazione di trovarsi comunque a suo agio lì. Il motivo era molto semplice: si usciva dalla porta, si scendeva nel garage e nessuno vedeva né l'ingresso né l'uscita».
Si può dunque ritenere probabile che la palazzina in questione abbia avuto un ruolo, quanto meno in relazione allo scambio delle auto. Tale ipotesi è rafforzata anche dagli accertamenti condotti in relazione alla presenza di tracce ematiche riscontrate sul deflettore sinistro, sul vetro e sul rivestimento interno sopra la spalliera anteriore sinistra della 128 blu, come se il conducente avesse avuto difficoltà, per lo spazio esiguo, ad accedere nell'autovettura, dovendosi contorcere e poi dover regolare lo specchietto laterale per migliorare la visuale nell'angusto spazio di uscita. Questo rafforzerebbe la tesi del parcheggio in un luogo chiuso del mezzo per effettuare poi il trasbordo dell'onorevole Moro e abbandonare solo in un secondo tempo l'auto in Via Licinio Calvo.
13. Considerazioni conclusive
La legge istitutiva della Commissione (Legge 30 maggio 2014, n. 82) ha assegnato come mandato all'inchiesta parlamentare quello di «accertare eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro; eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute».
Presupposto dell'inchiesta è dunque il fatto che, nonostante i tanti anni trascorsi dai tragici avvenimenti che videro la morte di Aldo Moro e dei cinque agenti di scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Salvatore Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, permanga una "mancanza di verità" rispetto a aspetti importanti della vicenda.
Tale presupposto è stato peraltro criticato da alcuni dei protagonisti di quella stagione, magistrati, giornalisti e personalità politiche, sulla base dell'assunto che sul "caso Moro" tutto fosse conosciuto e che, quanto non noto, fosse residuale e minimale.
In realtà, è proprio dalla rilettura sistematica dei cinque processi e dell'attività delle precedenti Commissioni che si sono occupate in tutto o in parte della vicenda Moro - la prima Commissione Moro, la Commissione P2, la Commissione stragi, attiva per quattro legislature, e la Commissione Mitrokhin - che emerge il fatto che la ricostruzione storico-politica e giudiziaria di uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana è ancora fortemente condizionata da una "verità" affermatasi tra gli anni '80 e i primi anni '90, che ha poi trovato un parziale accoglimento in sede giudiziaria. Una "verità" fortemente legata alle interazioni tra le culture politiche all'epoca prevalenti e ad una diffusa volontà di voltare rapidamente pagina rispetto alla stagione del terrorismo. Ciò, peraltro, risulta di palmare evidenza dalle pagine dedicate in questa relazione all'analisi del percorso
dissociativo di Valerio Morucci e Adriana Faranda e alla influenza che questo esercitò sui giudicati penali.
In questo, come in altri ambiti, la Commissione ha potuto compiere passi avanti in quanto ha potuto acquisire, anche grazie alle declassifiche di documenti seguite alla "direttiva Renzi", un'ingente documentazione e ha potuto individuare fonti dimenticate o occultate, che sono state lette alla luce delle audizioni e delle attività di indagine delegate ai collaboratori e alle Forze di polizia.
Proprio seguendo la logica della legge istitutiva, la Commissione non ha inteso proporre una lettura complessiva del caso Moro, quasi cimentandosi in una sorta di storiografia parlamentare, ma ha focalizzato la sua attenzione sugli aspetti che più di altri fanno emergere nuovi elementi e specifiche responsabilità. Anche se solo alcuni aspetti della vicenda Moro sono specificamente trattati in questa e nelle precedenti relazioni, dal complesso degli elementi acquisiti emerge un'analisi complessivamente nuova di molte questioni centrali di questa vicenda, che potranno eventualmente essere approfonditi sia dall'Autorità giudiziaria, con la quale la Commissione ha proceduto in un'ottica di leale, reciproca collaborazione, sia dagli studiosi.
Un primo elemento che emerge con chiarezza è che una semplice lettura combinata dei documenti programmatici delle Brigate rosse e delle informative che provenivano dal Medio Oriente avrebbe consentito di individuare una specifica necessità di tutelare la persona dell'onorevole Moro con le massime misure di sicurezza. Ove queste fossero state attuate, non solo la vita di Aldo Moro e degli uomini della scorta, ma l'intera vicenda del terrorismo brigatista avrebbe assunto una piega ben diversa da quella che si realizzò. L'inefficace protezione non è dunque imputabile solo a carenze degli apparati di polizia, ma ad una più generale incapacità politica di cogliere il rischio prodotto dalle Brigate rosse, alla quale non furono estranee ambiguità di singoli esponenti della politica, della magistratura e degli apparati.
Tra i principali elementi indagati c'è anche la ricostruzione della dinamica di via Fani, a partire dall'individuazione delle lacune della ricostruzione condensata nel "memoriale Morucci". Dopo le indagini compiute è possibile affermare che la dinamica deve essere profondamente riesaminata anche alla luce degli accertamenti sul bar Olivetti e sulla sua funzione nell'operazione delittuosa.
Altrettanto significativa è l'individuazione, nella zona della Balduina, di un complesso, di proprietà IOR, che ospitò nella seconda metà del 1978 Prospero Gallinari e che era caratterizzato dalla presenza di prelati, società statunitensi, esponenti tedeschi dell'autonomia, finanzieri libici e di due persone contigue alle Brigate rosse. Complesso che, anche alla luce della posizione, potrebbe essere stato utilizzato per spostare Aldo Moro dalle auto utilizzate in via Fani a quelle con cui fu successivamente trasferito oppure potrebbe aver addirittura svolto la funzione di prigione dello statista.
Anche le attività tecniche delegate al RIS di Roma introducono diversi elementi di novità rispetto alla ricostruzione dell'uccisione di Moro che è stata proposta dai brigatisti in sede giudiziaria e ancor più in sede pubblicistica, evidenziando le criticità della ipotizzata uccisione di Moro nel pianale del vano portabagagli della Rénault 4 all'interno del garage di via Montalcini 8.
Un altro elemento che si evidenzia con chiarezza è che non si intravede una regia unica tra i protagonisti attivi o omissivi della vicenda Moro. Emerge, al contrario, come si sia innestata sull'operazione militare delle Brigate rosse l'azione di una pluralità di soggetti, che per ragioni diverse, influirono sulla gestione e tragica conclusione della vicenda.
In questo ambito può collocarsi certo la presenza di persone legate alla P2 in diversi ambiti istituzionali, dai Comitati di crisi istituiti presso il Ministero dell'interno, ai vertici dei Servizi e della Forze di Polizia, alla Magistratura, come pure l'evidente permanere, all'interno degli apparati, di appartenenti a strutture che in alcuni casi, come evidenziato dal lavoro delle Commissione Stragi, rispondevano a plurime fedeltà.
Allo stesso modo emerge la presenza, in diversi snodi del sequestro Moro, di personaggi legati alle organizzazioni criminali, o perché interessati direttamente da esponenti politici, o in quanto fornitori di supporto logistico e armi, o semplicemente come "spettatori" della vicenda. In questo ambito, il riconoscimento del coinvolgimento del bar Olivetti di via Fani in dinamiche criminali ‘ndranghetiste e di traffico di armi e i contatti con la malavita settentrionale e romana ampiamente documentati nella Relazione costituiscono una importante acquisizione, che va oltre la vexata quaestio di una presunta eterodirezione delle Brigate rosse, ma disegna uno sfondo di compromissioni a vari livelli. Dentro tale sfondo si collocano anche le infiltrazioni nelle Brigate rosse che si verificarono sin dai primi anni '70 e che sono state pure documentate dalle indagini.
Ancora più importante è il riconoscimento del ruolo di quell'area grigia e invisibile costituita dai rapporti fra varie entità, anche criminali o terroristiche, e i vari servizi segreti. In questo ambito una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione "mediterranea" della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio Oriente, della Libia e della questione israelo-palestinese.
Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro SISMI di Beirut hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale. È stato inoltre possibile inquadrare l'azione delle Brigate rosse all'interno di un più vasto "partito armato", composto da diverse formazioni terroristiche italiane, che faceva parte a pieno titolo del terrorismo internazionale di sinistra e non si riduceva a una dimensione puramente nazionale.
Ma le acquisizioni hanno riguardato anche altri ambiti centrali per la ricostruzione della vicenda Moro, dal ruolo del Superclan e della scuola Hypérion alla possibile protezione accordata a latitanti come Alessio Casimirri. La stessa vicenda dell'arresto di Morucci e Faranda in casa di Giuliana Conforto è stata oggetto di una completa rilettura, che ha consentito di mettere finalmente alcuni punti fermi sulla scoperta del rifugio di Viale Giulio Cesare n. 47, ma anche di evidenziare uno scenario più complesso, che chiama in causa la possibilità che l'arresto di Morucci e Faranda sia stato negoziato.
Alla luce delle indagini compiute, dunque, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro non appaiono affatto come una pagina puramente interna dell'eversione di sinistra, ma acquisiscono una rilevante dimensione internazionale.
Al di là dell'accertamento materiale dei nomi e dei ruoli dei brigatisti impegnati nell'azione di fuoco di via Fani e poi nel sequestro e nell'omicidio di Moro, emerge infatti un più vasto tessuto di forze che, a seconda dei casi, operarono per una conclusione felice o tragica del sequestro, talora interagendo direttamente con i brigatisti, più spesso condizionando la dinamica degli eventi, anche grazie alla presenza di molteplici aree grigie, permeabili alle influenze più diverse.
Si pensi, ad esempio, al ruolo degli ambienti dell'Autonomia operaia romana, protagonisti dei colloqui con esponenti socialisti e allo stesso tempo impegnati in un'autonoma esperienza di partito armato, oppure al ruolo dei Servizi esteri, di cui, grazie alla documentazione declassificata, si cominciano a intravedere specifiche attività.
Molte e significative sono state anche le acquisizioni in relazione alle trattative tentate da più attori per garantire la salvezza di Moro. Il quadro delle iniziative socialiste è stato arricchito con l'individuazione di una filiera lombarda, che forse poté fungere da canale diretto con Moro. Si è inoltre approfondita la vicenda delle iniziative della Santa Sede, chiarendo il ruolo di monsignor Curioni, e, come già detto, quella dei movimenti palestinesi e di esponenti della criminalità ai quali fu richiesto di fornire un ausilio.
Connesso a questo è il tema della circolazione delle carte di Moro. Le attività condotte in relazione alla vicenda del covo brigatista di via Fracchia, a Genova, e all'esistenza di un canale di ritorno confermano la centralità di questo tema, ma restituiscono anche a Moro un grande spessore politico e intellettuale e fanno emergere il suo "martirio laico", nel quale si evidenziarono le sue qualità di statista e di cristiano.
In tutti gli ambiti sommariamente enunciati, la Commissione ritiene di aver fatto significativi passi in direzione della verità e utilizzerà il tempo residuo per portare a termine tutte le possibili indagini. La Commissione consegna dunque al Parlamento e al Paese un lavoro che non è esaustivo, ma che corrisponde alla logica della legge istitutiva e che rende molto più chiaro uno degli eventi più drammatici della storia della Repubblica italiana.
(1) Atti acquisiti dalla Commissione Mitrokhin, n. 136.5.
(2) Informativa del 14 gennaio 1972 del Raggruppamento Centri Cs al Reparto D del SID.
(3) F. Imposimato - S. Provvisionato, Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il giudice dell'inchiesta racconta, Roma, 2008, p. 269.
(4) A. C. Valle, Teresilla. La suora degli anni di piombo, Roma, Ed. Paoline, 2006, p. 39. In realtà, nelle dichiarazioni rese in udienza dibattimentale al processo 2625/91, suor Teresilla Barillà riferisce al 1985 la sua conoscenza con Morucci, datazione che però appare eccessivamente tarda.
(5) Intervista di S.Lorenzetto a M. Puddu, in "Il Giornale", 28 gennaio 2007.
(6) F. Imposimato - S. Provvisionato, Doveva morire...cit., p. 46
(7) Giornalista dell'Agenzia giornalistica Italia.
(8) Bassam Abu Sharif sembra fare qui riferimento alla data del sequestro Moro. Il riferimento all'infiltrazione delle Brigate rosse ad opera di CIA e Mossad fu, a suo tempo, evocato da Giovanni Galloni in una intervista rilasciata alla trasmissione "Next" di RaiNews il 5 luglio 2005.
(9) Il riferimento a "attendibilità tre" va inteso, secondo le prassi in uso, come "attendibilità media".
(10) Nota SID con intestazione C.S. IV e parte iniziale testo: "Argo: riunione segreta in Beyrouth aut Damasco capi estremisti guerriglia palestinese".
(11) Articolo apparso su "Il Resto del Carlino" del 24 febbraio 1975. Lo stesso articolo è stato pubblicato anche su "La Nazione".
(12) Minuta di appunto indirizzato al Ministro della difesa, «Ministro dell'interno informato» del 28 aprile 1978. Documento declassificato.
(13) L'errore nel cognome è presente nella lettera.
(14) C. Granata, Curcio e i BR in carcere a Torino accettano uno scambio con Moro, in "La Stampa", 25 aprile 1978.
(15) Minuta di appunto, datato 28 aprile 1978.
(16) Archivio della Commissione Stragi, doc. 6.b.3.19.
(17) La rete di informatori costituita dal sottufficiale aveva consentito il rinvenimento nel carcere di Cuneo di armi ed esplosivi e la neutralizzazione di progetti di evasione nonché l'individuazione di agenti di Polizia penitenziaria infedeli. In seguito il maresciallo proseguì la medesima attività presso il carcere di Pianosa ove era stato trasferito.
(18) Durante alcuni colloqui con il maresciallo Incandela il detenuto Patrizio Peci aveva infatti manifestato segni di "cedimento" e, una volta maturata definitivamente la scelta di collaborare, d'intesa con il maresciallo era stato organizzato un finto trasferimento durante il quale il detenuto era stato portato in una caserma dei Carabinieri del Piemonte ove aveva incontrato il dottor Caselli e iniziato la sua collaborazione. Sembra pertanto non avere alcun fondamento l'ipotesi più volte avanzata secondo cui Patrizio Peci sarebbe stato "arrestato due volte" e la prima volta rilasciato dopo aver promesso di collaborare rientrando come infiltrato nella colonna torinese.
Dopo il pentimento di Peci inoltre, sempre con la collaborazione del maresciallo Incandela e con le medesime modalità usate per Peci, era seguita la collaborazione di Fabrizio Giai, importante esponente di Prima Linea.
(19) Deposizione dinanzi al Presidente Giuseppe Fioroni e al consulente dottor Guido Salvini svoltasi presso la Questura di Torino
(20) Non si condivide quindi il giudizio negativo sul racconto del maresciallo Incandela espresso dal dottor Armando Spataro, già Procuratore aggiunto a Milano, nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione il 7 luglio 2015.
(21) Lello Liguori, insieme a Giorgio Borletti, è stato anche coinvolto alla fine degli anni '80 nell'indagine San Martino condotta dalla Procura di Milano e riguardante la "scalata" al Casinò di Sanremo.
(22) C. Granata, Curcio e i BR in carcere a Torino accettano uno scambio con Moro, in "La Stampa", 25 aprile 1978.
Si cita fra tutte la lettera, diretta alla moglie Eleonora, non recapitata e rinvenuta in copia in via Monte Nevoso solo nell'ottobre 1990, che contiene allusioni alla possibilità di un contatto fisico o molto più probabilmente di un nuovo contatto fisico con don Mennini (o un suo emissario) cui potrebbe essere dato il "pacchetto" costituito dalle lettere dirette alla famiglia (che l'on. Moro aveva riscritto essendo andate perdute le precedenti) evitando così controlli. La consegna prospettata sembra infatti presupporre che un contatto di tal genere in precedenza fosse già avvenuto.La lettera è in sintonia con il racconto da Michele Galati di cui si parla in questo paragrafo. Questi infatti ha dichiarato che la prima visita all'onorevole Moro sarebbe avvenuta in una fase in cui le trattative erano aperte e con ragionevole speranza di un esito positivo e la lettera, con il riferimento al messaggio del Papa, è stata scritta certamente alla fine di aprile 1978, appunto in quella fase.
(24) Con il dottor Salvini presso il Commissariato di Mestre.
(25) L'articolo contenente le dichiarazioni di Pasquale Squitieri è stato pubblicato da "La Provincia Pavese".
(26) Deposizione dinanzi al consulente dottor Salvini in data 25 marzo 2017.
(27) S. Flamigni, La tela del ragno, Milano, 1993, p. 369.
(28) M. Gotor, Il memoriale della Repubblica, Torino, 2011, p. 373.
(29) Cfr. A. Baldoni - S. Provvisionato, Anni di piombo, Milano, 2009.
(30) Le dichiarazioni del giornalista Marcello Zinola hanno fatto ampi riferimenti ad un'intervista telefonica a Michele Riccio effettuata dalla redazione del Secolo XIX (della quale lo stesso Zinola non ha però rinvenuto l'evidenza archivistica), parzialmente trasfusa in un articolo pubblicato dal quotidiano venti anni dopo i fatti di via Fracchia, con il titolo L'ex capitano Riccio racconta "Una vecchietta ci aprì il portone". In tale intervista, ricorda Zinola, «chiesi anche di parlare sul particolare dell'orologio della Ludmann che era fermo su un'ora della notte che non corrispondeva all'ora ufficiale dell'operazione. Sulla ipotizzata discrasia Riccio ribadì di essere entrato in azione poco dopo le 4 richiamandosi al contenuto degli atti. Chiesi a Riccio ulteriori delucidazioni sul soccorso prestato al Benà, del ricovero in ospedale e dell'intervento chirurgico. Riccio disse che Benà aveva esploso due colpi in aria cadendo o dopo essere caduto. Esplose i due colpi per farsi riconoscere, per segnalare la propria posizione [...]Per ulteriori particolari ritengo opportuno richiamare anche i contenuti dell'intervista rilasciata da Benà alla mia collega Patrizia Albanese».
Il riferimento è all'intervista dell'8 luglio 1997 rilasciata dal maresciallo Benà al "Secolo XIX", in cui il sottufficiale ricorda che «hanno urlato che si arrendevano. Io ho tirato su la visiera. Era appannata. Ma ero abbastanza tranquillo dopo l'irruzione avevano urlato che si arrendevano. Quella certezza mi ha fregato. [...] Ricordo di aver fatto pochi passi. Ricordo un arco che forse dava su un corridoio. Poi ho sentito sparare. Quanti colpi? Uno. Mi sembra di averne sentito uno. Qualche frazione di secondo e sono caduto [...] Poi mi hanno caricato sull'ambulanza. Quando? Non so. Potevano essere passate due ore o dieci minuti». Considerato che l'irruzione avvenne probabilmente in orario di poco anteriore alle tre di notte, l'ingresso di Benà all'ospedale San Martino sancito alle ore 6 dal referto del drappello ospedaliero della polizia e da quello del medico di guardia contrasta con le richiamate ricostruzioni degli eventi. Marcello Zinola ha prodotto alla Commissione 11 fotografie, delle quali due evidenziano quattro fori verosimilmente cagionati da colpi d'arma da fuoco nella parete del pianerottolo antistante la porta d'ingresso del pianerottolo dell'appartamento della Ludmann.
Il dottor Carli ha riferito in audizione: «Un collega del maresciallo Elio Di Sabatino [...], preso dall'agitazione del momento, rischiò di far saltare per aria l'operazione - così mi disse lui, dovreste sentire lui - perché gli partì una raffica che finì contro il muro. Poi entrarono dentro. A me risulta che entrò per primo il maresciallo Benà. Mi risulta che si prese un colpo di pistola in un occhio e, con le sue urla terrificanti, tutti cominciarono a sparare, finché vuotarono i caricatori. Questo a me risulta». Di tali colpi contro il muro la Commissione ha acquisito un riscontro, costituito da due fotografie depositate dal giornalista Zinola che evidenziano quattro buchi nell'intonaco, con andamento curvilineo, compatibili con l'esplosione accidentale di una raffica di mitra.
(31) Un'ampia descrizione del covo e delle operazioni compiute è contenuta in una serie di articoli che Gad Lerner scrisse all'epoca per "Lotta continua". Cfr. in particolare "Quattro vittime della barbarie. Poi si parla solo del "covo", in "Lotta continua", 29 marzo 1980.
(32) «In pieno Carnevale [...] finirono in manette Patrizio Peci e Rocco Micaletto. Peci era il capo della colonna torinese delle Brigate Rosse. Ma poi Peci entrò in crisi. Umana, politica. I segni del disagio li colse per primo il maresciallo Angelo Incandela, comandante della polizia penitenziaria di Cuneo. Incandela avvisò immediatamente un po' tutti, servizi, polizia, carabinieri. Come si mossero gli altri non lo so, posso solo immaginarlo. Tentarono di avvicinare Peci in maniera, come dire, informale. Il generale Dalla Chiesa, invece, fu l'unico a fare la cosa giusta. Si presentò nel mio ufficio, mi disse che Peci avrebbe potuto collaborare e chiese di essere autorizzato a parlargli. È nei poteri del giudice istruttore titolare dell'inchiesta concedere tale autorizzazione. Così, infilai un foglietto di carta intestata all'ufficio nella mia Olivetti "Studio 44" e in pochi minuti scrissi parole che conservo ancora a memoria: "si autorizza il latore della presente, generale Carlo Alberto dalla Chiesa, o altro ufficiale dell'Arma dal medesimo delegato, ad avere colloqui con il detenuto Peci Patrizio, detenuto nel carcere di Cuneo, senza limitazione alcuna di orari e numero di colloqui. Firmato Bruno Caccia, procuratore della Repubblica e Mario Carassi, capo dell'ufficio istrizione di Torino". [...] all'inizio Peci parlò in qualità di confidente dei carabinieri, non ancora collaboratore di giustizia. Vale a dire che i carabinieri non stendevano verbali ufficiali ma prendevano appunti informali (riempiendo, uno dopo l'altro, decine e decine di quadernetti di scuola) per accertamenti e indagini. Dalla Chiesa e i suoi collaboratori ci tenevano al corrente di ogni cosa.
[...] La collaborazione di Peci, intanto, si costellava di eventi drammatici. La notte del 28 marzo 1980 i carabinieri irruppero in un appartamento di via Fracchia 12 a Genova, quartiere Oregina. Era un covo delle br, cui si arrivava seguendo le precise indicazioni di Peci. Ne nacque una violenta sparatoria [...]. Patrizio Peci alla notizia delle conseguenze del conflitto a fuoco a Genova entrò in crisi. Mario Griffey e io lo incontrammo nel carcere di Torino e faticammo non poco per convincerlo a non cedere. E siamo al primo aprile del 1980. Era in corso il trasferimento di Peci da Torino a Pescara quando - alle primissime ore dell'alba - ricevetti una telefonata. Peci era fermo nella caserma di Cambiano, voleva parlare con un magistrato e verbalizzare tutto. Avvertii i colleghi. Mario Carassi designò me e Griffey come giudici istruttori, Bruno Caccia e Alberto Bernardi come pm. Ci precipitammo a Cambiano».