Doc. XXIII, N. 6
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)
(composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Dorina Bianchi, Bossa, Bruno Bossio, Carbone, Carfagna, Dadone, Di Lello, Segretario, D'Uva, Fava, Vicepresidente, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Occhiuto, Piccolo, Piepoli, Sarti, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori: Albano, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Falanga, Fazzone, Gaetti, Vicepresidente, Giarrusso, Giovanardi, Lumia, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Torrisi, Vaccari e Zizza)
RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMAZIONE E SULLA CONDIZIONE DEI GIORNALISTI MINACCIATI DALLE MAFIE
(Relatore: On. Claudio Fava)
Approvata dalla Commissione nella seduta del 5 agosto 2015
Comunicata alle Presidenze il 5 agosto 2015
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 19 luglio 2013, n. 87
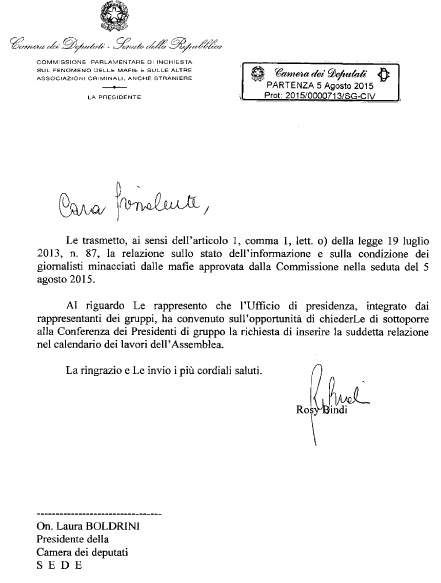

INDICE
| 1) Attività del Comitato e obiettivo dell'inchiesta | Pag. | 7 |
| 2) Il giornalismo offeso | » | 10 |
| 2.1) Violenza e sottocultura | » | 10 |
| 2.2) I felpati avvertimenti, le nuove mafie, l'offensiva della ’ndrangheta al nord | » | 11 |
| 2.3) Pagato per non scrivere | » | 15 |
| 2.4) La «normalizzazione» dell'emittente siciliana Telecolor | » | 18 |
| 2.5) La mafia nel litorale romano | » | 22 |
| 2.6) La solitudine dei cronisti minacciati | » | 24 |
| 3) Gli elementi di fragilità del mestiere di giornalista | » | 26 |
| 3.1) La sottovalutazione del fenomeno delle minacce | » | 26 |
| 3.2) L'informazione precaria: freelance, sommersi, marginali | » | 27 |
| 3.3) Le «persuasioni legali» | » | 28 |
| 4) I condizionamenti all'informazione | » | 33 |
| 4.1) Il giornalismo in terra di camorra | » | 33 |
| 4.2) L'informazione in Sicilia | » | 39 |
| 4.2.1) Mario Ciancio e il sistema di potere mafioso a Catania | » | 40 |
| 4.2.2) Il Giornale di Sicilia | » | 48 |
| 4.3) L'informazione in Calabria e il caso di Calabria Ora | » | 58 |
| 5) Deontologia, contratti, freelance | » | 73 |
| 5.1) L'Ordine dei giornalisti | » | 73 |
| 5.2) La Federazione nazionale della stampa | » | 76 |
| 6) La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati | » | 78 |
| 6.1) L'articolo 21 della Costituzione | » | 78 |
| 6.2) La legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) | » | 79 |
| 6.3) Il delitto di diffamazione a mezzo stampa | » | 80 |
| 6.4) L'articolo 57 del codice penale | » | 81 |
| Pag. 6 | ||
| 6.5) Le azioni a tutela dell'offeso e l'abuso del loro esercizio | Pag. | 82 |
| 6.6) La tutela contrattuale dei giornalisti e i freelance | » | 10 |
| 7) Il percorso di riforma legislativa in Italia | » | 84 |
| 7.1) La posizione della Corte europea per i diritti dell'uomo | » | 84 |
| 7.2) Il progetto di legge n. 925 | » | 86 |
| 7.3) I rimedi legislativi auspicati nel corso dell'inchiesta parlamentare | » | 87 |
| 8) Le prospettive di riforma | » | 89 |
| 8.1) Il delitto di diffamazione come possibile limite alla libertà di informazione | » | 89 |
| 8.2) La tutela del diritto di informare | » | 97 |
| 8.3) La tutela del diritto ad essere informati | » | 98 |
| 9) Conclusioni | » | 100 |
1) Attività del Comitato e obiettivo dell'inchiesta.
Per le mafie controllare i propri territori, garantirsi impunità, costruire consenso e legittimità sociale vuol dire anche sottomettere la libera informazione, pretendere rispetto, costringerla al silenzio.
L'osservatorio Ossigeno per l'informazione ha censito in questi anni un vasto e drammatico repertorio di minacce, attentati, avvertimenti ai danni di migliaia di giornalisti: 2060 dal 2006 al 31 ottobre 2014, con un costante incremento che ha registrato il suo picco nei primi dieci mesi del 2014: 421 atti di violenza o di intimidazione, quasi tre ogni due giorni.
Molti – più di trenta – anche i giornalisti sottoposti a misure di tutela dal Ministero dell'Interno: l'ultimo, Sandro Ruotolo, inviato della trasmissione televisiva Servizio pubblico, costretto alla scorta dopo le pesanti e dirette minacce che gli sono state rivolte dal boss della camorra Michele Zagaria.
Il repertorio spazia dagli avvertimenti nel tipico linguaggio criminale (pallottole recapitate a casa, bombe inesplose, lettere e telefonate minatorie, linciaggi mediatici sui social network) alle violenze vere e proprie (aggressioni fisiche e danneggiamenti) fino agli abusi del diritto (centinaia di querele e di azioni legali di risarcimento pretestuose, esercitate o semplicemente minacciate, che hanno un solo obiettivo: intimidire, indurre al silenzio e all'autocensura il giornalista o la testata).
Non esistono zone franche: lo scorso anno solo Val d'Aosta e Molise non hanno registrato aggressioni o intimidazioni contro l'informazione. Il vecchio paradigma di una violenza mafiosa concentrata nelle regioni meridionali è ormai superato da una realtà che indica nel Lazio la regione in cui si registra la maggior parte di episodi di minacce ai danni dei giornalisti, 26 dall'inizio del 2015 (seguono la Campania con 20 episodi, la Puglia e la Lombardia con 18). E non è una coincidenza se due tra i casi più recenti (l'attentato sventato ai danni di Giovanni Tizian e le ripetute gravi minacce nei confronti della giovanissima cronista Ester Castano) vanno collocati rispettivamente in Emilia Romagna e in Lombardia.
Probabilmente queste cifre sono la punta dell’iceberg perché tengono conto solo degli episodi conosciuti o denunciati: che restano minima parte rispetto ai veri ordini di grandezza della violenza mafiosa contro i giornalisti. Se assumiamo l'indice proposto dall'osservatorio Ossigeno per l'informazione, che suggerisce di moltiplicare per dieci i casi noti, superiamo ogni anno le quattromila vittime dirette e indirette su una popolazione complessiva di 110 mila giornalisti iscritti all'ordine. Storie e numeri più che sufficienti per legittimare, nell'opinione pubblica straniera e nei rilevamenti di alcune grandi organizzazioni internazionali (dall'OCSE a Reporters Pag. 8Sans Frontiéres all'IPI di Vienna), l'urgenza di un «caso Italia». Al quale va aggiunto, come suggello storico, il numero tragicamente alto di giornalisti uccisi dalle mafie
e dal terrorismo: ben undici. Troppi, in un Paese democratico che dovrebbe avere nella libertà di informare e di essere informati uno dei capisaldi della propria cultura democratica.
Partendo da queste considerazioni, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, ha costituito uno specifico Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione che trae previsione dall'articolo 13 del proprio Regolamento interno («la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. [...] La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. [...] Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione»).
Tale Comitato è stato investito del compito di conoscere, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione. Il piano di lavoro del Comitato ha inteso mettere a fuoco soprattutto alcuni profili:
le diverse modalità in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti;
la molteplicità di cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o legate ad altri soggetti (esponenti delle comunità politiche, gruppi di potere economico o finanziario), che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi;
le conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione (l'isolamento dei giornalisti minacciati, l'autocensura delle vittime, le censure imposte dagli editori o dai direttori);
la diffusione geografica del fenomeno, con un'attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze (silenzi, isolamento, censure e autocensure) si manifestano in modo più evidente;
la sostanziale invisibilità di questa violenza, diffusa ma spesso ignorata o minimizzata dagli stessi organi di informazione (per distrazione, per rimozione o per convenienza);
il caporalato giornalistico e la marginalità professionale della maggior parte delle vittime (freelance, lavoro nero, pagamenti a cottimo a tariffe indecorose) che le rende particolarmente deboli di fronte agli atti di intimidazione. E che rappresenta il più sottile tra i tentativi di condizionamento;
i rimedi a una legislazione sulla stampa, che andrebbe riformata e allineata agli standard europei sulla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto/dovere di informare (favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato, fermare le querele temerarie, garantire la copertura delle spese legali, limitare le richieste di risarcimento dei danni...).
Il Comitato è stato chiamato a indagare anche l'altro aspetto del problema: l'informazione contigua, compiacente o persino collusa con le mafie. Perché se è vero che gli episodi di compiacenza a volte sono il prodotto delle minacce subite, è pur vero che esiste un reticolo di interessi criminali che ha trovato in alcuni mezzi d'informazione e in alcuni editori un punto di saldatura e di reciproca tutela.
In entrambi i casi – giornalisti minacciati e giornali dalla posizione deontologicamente non corretta – a patirne le conseguenze è la libertà dell'informazione: chi intimidisce un giornale o corrompe un giornalista procura un immediato e rilevante danno sociale all'intera comunità civile.
Naturalmente l'obiettivo di questa relazione non è una storia del giornalismo italiano – che è complessa, generosa e ricca di passione professionale e civile – ma un'indagine sui tentativi di condizionamento che ha subito e subisce la stampa da parte delle organizzazioni criminali.
È una premessa d'obbligo soprattutto pensando al giornalismo siciliano. La relazione documenta anche significativi episodi di opacità: ai quali va però idealmente affiancata la vitalità di una tradizione giornalistica che ha avuto proprio in Sicilia autorevoli interpreti. Non è un caso se otto dei nove giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa siano caduti nell'isola: segno della qualità di un mestiere e di una vocazione che non sono mai stati piegati, nemmeno dalla follia omicida di cosa nostra.
Il 18 luglio 2014 è iniziata l'attività di inchiesta parlamentare del Comitato, coordinato dal vicepresidente Claudio Fava. Sono state svolte trentaquattro audizioni – sia in Comitato che in seduta plenaria – di giornalisti, direttori di quotidiani, presidenti regionali dell'Ordine dei giornalisti, nonché del presidente nazionale dell'Ordine e del segretario della Federazione nazionale della stampa. Sono stati altresì auditi magistrati che, a vario titolo, potevano fornire un contributo sulla materia oggetto di analisi.
In particolare sono stati sentiti: i giornalisti del quotidiano la Repubblica Carlo Bonini (14.10.14), Enrico Bellavia (18.07.14) e Federica Angeli (23.09.14), Lucio Musolino de Il Fatto Quotidiano (14.10.14), Giovanni Tizian e Lirio Abbate del settimanale l'Espresso (25.07.14); la senatrice Rosaria Capacchione, giornalista de Il Mattino (21.10.14); la responsabile del programma televisivo Report, Milena Gabanelli; i giornalisti Michele Albanese (07.10.14), Roberto Rossi (01.08.14), Franco Castaldo (09.09.14), Domenico Valter Rizzo (09.09.14), Gaspare Giacalone (16.09.14), Giuseppe Maniaci (16.09.14), Luigi Centore (23.09.14), Milena Gabanelli (10.03.15); la direttrice di Radio Siani, Amalia de Simone e il presidente della Cooperativa Giancarlo Siani, Giuseppe Scognamiglio (30.09.14), il direttore del quotidiano Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito e il direttore del quotidiano Il
Mattino, Alessandro Barbano (Commissione plenaria del 19.11.14), il direttore del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni (31.10.14), il direttore della Gazzetta del Sud, Alessandro Notarstefano (04.11.14), il direttore del quotidiano Il Garantista, Piero Sansonetti (09.12.14), il condirettore del Giornale di Sicilia, Giovanni Pepi (12.02.15); l'ex direttore de La Sicilia Nino Milazzo (20.07.2015); l'ex direttore di Telecolor Michela Giuffrida (28.07.15); il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi (Commissione plenaria del 15.01.15); il sostituto procuratore presso la procura della Pag. 10Repubblica di Roma, Giovanni Musarò (commissione plenaria del 21.04.15), il direttore dell'osservatorio Ossigeno per l'informazione, Alberto Spampinato (10.03.15), il presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, Vincenzo Iacopino (Commissione plenaria del 17.03.15), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli (20.11.14), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia, Riccardo Arena. (27.11.14), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri (17.12.14), il presidente della Federazione nazionale della stampa, Santo Della Volpe e il segretario della Federazione nazionale della stampa, Raffaele Lorusso (Commissione plenaria del 26.03.15).
Il giornalista Roberto Saviano, pur invitato, non ha ritenuto di accettare l'invito a essere audito.
L'editore Mario Ciancio, in qualità di imputato per i medesimi fatti su cui sarebbe stato ascoltato dal Comitato, non è stato audito avendo preannunciato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.
Durante i dieci mesi di attività del Comitato, la Commissione ha inoltre acquisito documentazione per l'approfondimento dei temi trattati, depositata dagli stessi auditi o acquisita d'ufficio. Altri atti utili all'indagine del comitato sono stati acquisiti presso gli uffici giudiziari competenti.
2) Il giornalismo offeso.
2.1) Violenza e sottocultura.
L'audizione del giornalista Roberto Rossi (1) – autore con Roberta Mani del libro “Avamposto nella Calabria dei giornalisti infami” (2) – ha fornito al Comitato un approfondito e attento spaccato sulle vicende del giornalisti minacciati, soprattutto in una terra di frontiera particolarmente esposta come la Calabria.
«Lettere minatorie, pallottole imbustate, incursioni in casa, cartucce abbandonate davanti alla porta della redazione, macchine incendiate, aggressioni a colpi di bastone, botte al giornalista e ai suoi familiari, sequestri di persona, danneggiamenti alle auto, bombe molotov lanciate contro il portone di casa, taniche di benzina adagiate sul tavolo della veranda, proiettili messi in fila sul davanzale di casa, convocazioni nella casa del boss, irruzioni in redazione, colpi di pistola contro l'autovettura nel cuore della notte: tantissime le tipologie dei messaggi intimidatori, in alcuni casi chiaramente riconducibili a precisi articoli, che colpivano per lo più gli interessi economici degli imprenditori mafiosi, talvolta svelavano i legami con la politica o semplicemente raccontavano di un arrestato il cui familiare era particolarmente suscettibile. In molti casi, però, è stato difficile da parte nostra individuare il pezzo che
aveva dato fastidio, a volte perché nemmeno il cronista minacciato lo sapeva, a volte perché si è preferito non fare ipotesi che avrebbero potuto compromettere le indagini in corso».Pag. 11
Traendo spunto dall'inchiesta condotta per il suo libro, Rossi ha provato a ricostruire anche il contesto sociale e umano, non solo professionale, in cui si trova a operare la maggior parte dei giornalisti che ha subito minacce dalle mafie. Ne emerge un dato di grande e preoccupante solitudine, tanto più esplicita quanto più ci si muove verso le periferie del Paese.
«Sicuramente un dato accomuna tutte queste storie, quello esistenziale: l'isolamento al quale sono costretti loro e le loro famiglie. Sono spesso corrispondenti, vivono in piccoli centri nei quali sono l'unica voce informativa. Le ostilità sono all'ordine del giorno: gli sguardi maligni, le mezze parole, gli incontri per strada. Il termine “infame”, quello col quale vengono apostrofati questi giornalisti, dice chiaramente della schizofrenia ambientale cui sono costretti: abitano quel territorio, ne sono parte integrante per cultura e abitudini, eppure sono considerati, per il lavoro che fanno, un corpo estraneo, qualcosa da espellere, un cancro. Gli infami sono quelli che svelano un segreto. È come se tradissero quel territorio svelandone il retroscena. Una delle accuse che viene spesso mossa a questi giornalisti, da parte della gente comune come da parte dei potentati politici, è quella di gettare fango
sulla Calabria, di tradire il territorio».
2.2) I felpati avvertimenti, le nuove mafie, l'offensiva della ’ndrangheta al nord.
Tra le numerose audizioni – invero tutte interessanti, seppur nelle loro peculiarità – alcune spiccano per l'esaustività dei temi trattati. È il caso, ad esempio, di Enrico Bellavia (3), giornalista de la Repubblica che, nel descrivere la propria vita professionale, ha delineato uno spaccato inedito delle criticità che caratterizzano oggi in Italia il mestiere di giornalista. Ovvero: non solo minacce, avvertimenti, aggressioni ma anche suggerimenti, soprattutto verso i giornalisti più impegnati sul terreno della cronaca giudiziaria.
«Nella biografia di alcuni dei giornalisti, poi uccisi dalla mafia, non necessariamente si riscontrano lettere anonime. Si riscontrano molto più felpati avvertimenti, magari sottovalutati, o l'idea che si erano fatte le cosche che quel collega servisse un partito mafioso piuttosto che un altro. [...] Mi sono trovato con uomini che mi spiegavano che non avevo capito niente e che bisognava leggere le cose in un altro modo. Quelli erano i felpati consigli di chi forse aveva un interesse a dirottare le indagini in una direzione piuttosto che in un'altra. Il clima fondamentalmente minaccioso era quello dell'avvocato dei boss, dell'avvocato difensore di boss importanti che ti diceva: «Hai scritto un sacco di sciocchezze», oppure «Guarda che il mio cliente è particolarmente incazzato con te» e quasi te lo dice come consiglio».
Bellavia ha ricordato le lettere anonime ricevute in occasione della pubblicazione di un suo libro-intervista con il boss di cosa nostra e collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, «...ritenuto tra i più attendibili nei processi che hanno esplorato la cosiddetta zona grigia, cioè i rapporti tra mafia e colletti bianchi, tra mafia e servizi segreti. Pag. 12[...] In una parte dell'intervista Di Carlo riconosceva di avere incontrato in cella, mentre era detenuto in Inghilterra, l'ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. L'incontro era finalizzato a cercare dei contatti con l'organizzazione mafiosa per fermare Giovanni Falcone. La datazione è molto importante, perché siamo prima del fallito attentato dell'Addaura. [...] Di Carlo ebbe modo di soffermarsi su alcuni personaggi che, a suo dire, avevano avuto rapporti con cosa nostra. Per questa ragione
è arrivata la prima lettera, che faceva esplicito riferimento a Di Carlo e mi raccomandava di stare lontano da queste tematiche, perché queste “cose del passato – c'era scritto e espressamente così – possono far male”».
Anche Bellavia sottolinea la condizione di maggiore difficoltà dei colleghi delle redazioni più periferiche.
«Io ho avuto la grande fortuna di lavorare in una grande città, Palermo, il che consente comunque un certo anonimato nel privato. Cosa diversa è per chi lavora in un piccolo centro. Penso al collega Dino Paternostro a Corleone, a Cosimo Di Carlo a Corleone, a Pino Maniaci a San Giuseppe Jato e a Partinico... In un posto piccolo il boss lo incontri al bar. Al bar lui sa quanti cannoli comprerai per andare a pranzo dalla suocera, dove vanno a scuola i tuoi figli, che percorso fanno, chi frequentano, chi vedono, quali interessi hai coltivato nella tua vita, dove hai comprato casa, quali terreni hai, se vai in campagna il sabato, se ci vai la domenica, se zappi da solo, se sei in compagnia del contadino, se raccogli l'olio, da chi ti servi per il frantoio, da chi hai comprato il trattore e dove custodisci il trattore...».
Ed ancora, sulle difficoltà del lavoro dei freelance, senza alcuna garanzia contrattuale.
«C’è anche una precarizzazione diffusa del lavoro. Molti dei colleghi che ricevono minacce, se gratti gratti, vedi che non hanno neanche la copertura previdenziale, figuriamoci la copertura professionale e tutto il resto. La permeabilità è legata a un sistema imprenditorial-commerciale profondamente inquinato. Noi dobbiamo recuperare l'attenzione per quei giornalisti che lavorano in provincia. Quelli dei grandi centri o dei grandi giornali non dico che non rischino, anzi, rischiano, vanno tutelati e a loro vanno tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto; ma chi lavora in un piccolo centro e spesso in realtà editoriali molto opache, non solo dal punto di vista contrattuale, è particolarmente esposto».
C’è anche un'ostilità che non ha bisogno di parole, quando le decisioni prese contro i giornalisti non devono essere minacciate ma solo eseguite.
Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, una lunga esperienza sul fronte dell'informazione calabrese, ha raccontato al Comitato (4): «Ho subìto due attentati. Per due volte hanno sparato alla mia macchina, per due volte hanno messo una bomba alla mia macchina. Io non ho mai avuto in trent'anni una lettera di minaccia. Mai. Devo dirvi che io sapevo che qualcosa mi sarebbe successo. Il primo caso per una serie di articoli su Locri che avevo sollevato io e soltanto io. All'epoca lavoravo alla Gazzetta del Sud. [...] Un noto killer della cosca Cordì di Locri venne intercettato mentre saliva in montagna con dieci copie de L'Espresso che riprendevano quell'articolo. Io capii Pag. 13bene che quelle dieci copie erano destinate ai latitanti e capii bene che i latitanti dovevano discutere che cosa fare per
quell'episodio. Pertanto, quando qualche giorno dopo arrivò la bomba, non me ne sorpresi. Questo lo dico anche perché la ’ndrangheta, quando colpisce veramente, lo fa in maniera che non ci possano essere equivoci. La sua rivendicazione deve essere alta e forte. Il bigliettino «stiamo valutando se...», «avremmo intenzione di...» paradossalmente ci tranquillizza. Io, che ho la responsabilità di avere giovani cronisti molto in gamba, molto bravi, che stanno sul territorio e per i quali sento anche il peso morale della loro esposizione fisica, se arriva una lettera di minacce, ovviamente autentica, non taroccata, la considero un motivo di tranquillità. Il silenzio che circonda le nostre inchieste più eclatanti, invece, ci toglie il sonno».
La più recente minaccia rivolta da Massimo Carminati – personaggio di spicco della cosiddetto «mafia capitale» – a Lirio Abbate ci riporta all'audizione del giornalista de L'Espresso, sotto scorta da molti anni perché minacciato più volte da mafia, camorra e ‘ndrangheta (5).
Dalle carte dell'inchiesta su Roma risulta come Massimo Carminati, a capo del sodalizio criminale che a Roma controllava appalti e finanziamenti pubblici con metodi mafiosi, parli più volte di Lirio Abbate (6). In particolare, in una delle intercettazioni, registrata il 7 dicembre del 2012, Carminati afferma: «Finché mi dicono che sono il re di Roma mi sta pure bene, come l'imperatore Adriano... però sugli stupefacenti non transigo, lunedì voglio andare a parlare col procuratore e dirgli: se sono il capo degli stupefacenti a Roma mi devi arrestare immediatamente. Non so chi cazzo è questo Abbate, questo infame pezzo di merda, finché mi accusano di omicidi... ma la droga no... come trovo il giornalista gli fratturo la faccia... tanto sarà scortato, così gli aumentano pure la scorta».
Non pare altresì casuale l'inquietante episodio che ha visto coinvolto a Roma Lirio Abbate allorquando, nello scorso settembre, era stata fatta trovare, sotto la redazione del suo giornale, un'auto con all'interno alcuni proiettili ed un biglietto indirizzato al giornalista. Tutto ciò a distanza di qualche settimana da un altro episodio, l'inseguimento dell'autovettura della polizia, su cui viaggiava l'Abbate, speronata da due individui uno dei quali è riuscito poi a fuggire.
Lirio Abbate è stato esplicito non solo sui rischi cui vanno incontro oggi molti giornalisti ma anche sul rischio che l'informazione stessa resti irretita in un contesto opaco o strumentale per i poteri mafiosi. È un punto che questa relazione affronta diffusamente più avanti ma è utile registrare qui il pensiero del giornalista palermitano.
«Le indagini antimafia che soprattutto negli ultimi quindici anni si sono sviluppate in Sicilia e in Calabria ci hanno fatto conoscere una mafia e una ’ndrangheta sempre molto interessate all'informazione, in particolare a quella locale. In un salotto bene di Palermo, quello del medico mafioso di Brancaccio Giuseppe Guttadauro, nel 2001 le intercettazioni ambientali hanno registrato che i capimafia si riunivano Pag. 14proprio in quel posto, a casa di Guttadauro, con Guttadauro in testa, e discutevano del fatto che per i mafiosi fosse importante coinvolgere i giornalisti nel loro progetto. Essi volevano interessare i giornalisti a livello di stampa nazionale per fare gli interessi di cosa nostra. È importante per la mafia influenzare anche l'opinione pubblica, perché la mafia è fatta anche di consenso».
Particolare, per come ne venne a conoscenza lo stesso giornalista, è la storia di Giovanni Tizian, sotto scorta dal dicembre del 2011. All'epoca Tizian, figlio di una vittima innocente della ’ndrangheta, lavorava principalmente per la Gazzetta di Modena, sulla quale aveva pubblicato diversi articoli dedicati alle infiltrazioni mafiose, in particolare nell'edilizia e nel gioco d'azzardo legale. Uno dei boss di cui si parlava negli articoli, Nicola Femia detto Rocco, nel corso di alcune telefonate intercettate si dilunga a parlare dei «fastidi» che gli articoli di Tizian stanno procurando alla sua attività, e pensa di bloccare il giornalista anche «sparandogli in bocca».
Ecco come Tizian descrive Femia nel corso dell'audizione (7): «Un imprenditore molto potente, rispettato da tutti, con ottime amicizie e relazioni in Emilia Romagna, ma che in passato era un narcotrafficante. Quando scrivevo di lui per la prima volta, infatti, aveva già una condanna per 23 anni in appello, eppure in Emilia Romagna si era riciclato ed era rispettato da tutti. L'organizzazione di Femia verrà arrestata nel gennaio 2013 e si scopriranno varie relazioni che Femia e la sua famiglia avevano anche con i servizi segreti. Femia aveva addirittura tentato di “comprare” la sentenza dei 23 anni in Cassazione attraverso due professionisti romani».
Al processo scaturito da questa indagine, Giovanni Tizian – nel frattempo passato a lavorare per il settimanale l'Espresso – si è costituito parte civile affiancato dall'Ordine dei giornalisti. La scelta non è stata gradita dagli imputati che, già alla prima udienza, hanno accolto Tizian nell'aula del tribunale con un florilegio di messaggi minacciosi. Evidentemente aver reso pubblico sulla stampa il ruolo criminale dei Femia è stato ritenuto dall'organizzazione più deleterio delle stesse indagini che, come detto, erano già concentrate su quella famiglia ben prima degli articoli di Tizian sulla Gazzetta di Modena. Per le cosche mafiose, le inchieste della magistratura rientrano nel perimetro dei rischi possibili; gli articoli e le sottolineature della stampa sono considerate invece un'intollerabile invasione di campo. Da punire. Anche «sparando in bocca»...
La Gazzetta di Modena ha avuto sicuramente il merito di dare ampio risalto agli articoli di Tizian e di sostenerlo anche dopo le minacce, ma è significativo dello stato complessivo di questo mestiere rilevare, dalle stesse parole del giornalista, quali erano le sue condizioni contrattuali mentre lavorava a quell'inchiesta: «Il mio primo contatto con la Gazzetta di Modena è del 2006. Non è un contratto, parliamo sempre di una lettera di incarico per pezzi pagati 4 euro ciascuno, più il rimborso della benzina». Solo dopo la vicenda delle minacce, la sua situazione contrattuale evolve: «Subito un contratto di collaborazione con un fisso, quindi non giornalistico, con Pag. 15il gruppo Espresso di cui la Gazzetta di Modena fa parte. Dal 10 marzo 2014, invece, un contratto giornalistico per il settimanale
l'Espresso».
Nel corso dell'audizione Tizian ha sottolineato come la questione dell'equo compenso non sarebbe comunque risolutiva, mentre andrebbe affrontato il capitolo di un diverso riconoscimento contrattuale dei freelance, valutandoli come collaboratori che apportano contenuti nuovi alla testata per la quale scrivono e non come un sotterfugio contrattuale utile a nascondere lavoro precario e sottopagato.
2.3) Pagato per non scrivere.
L'audizione del giornalista Francesco Castaldo (8) è stata svolta dall'VIII Comitato al fine di riepilogare una vicenda che lo ha visto protagonista e che riguarda la lunga controversia di lavoro che lo ha opposto al giornale per il quale lavorava, La Sicilia. Una vicenda abbastanza complessa dal punto di vista giuridico, anche per le ragioni e per le conseguenze che ha prodotto.
Francesco Castaldo, come dallo stesso riferito nel corso dell'audizione, è ancora oggi – per sentenza – dipendente della Domenico Sanfilippo Editore (9), con la qualifica di capo servizio. Percepisce regolarmente lo stipendio ma non lavora, nel senso che il suo direttore-editore Mario Ciancio non lo fa lavorare e soprattutto gli impedisce di entrare nella redazione di Agrigento, dove ha lavorato fino al 1996 come capo della redazione occupandosi principalmente di vicende di mafia.
Castaldo ricorda al Comitato la vicenda che suo malgrado l'ha visto protagonista: «Ha inizio nel 1995 quando, nel corso di un'udienza del maxiprocesso di Agrigento che si svolse a Roma, scrissi ciò che venne fuori da quell'udienza, cioè che un pentito accusava un imprenditore all'epoca molto potente, Filippo Salamone, di essere vicino alla mafia. (10) Immediatamente dopo, in seguito a un incontro tra il mio editore-direttore Ciancio e il Salamone, venni trasferito a Catania».
Il giornalista, soffermandosi sulle modalità che hanno determinato i propri trasferimenti, rappresenta: «Il primo trasferimento era motivato fittiziamente – questo è emerso processualmente – con una letterina di tre righe: “intendendo avvalerci della sua alta professionalità, la trasferiamo a Catania al settore cronache”. Questo fu il primo documento ufficiale che io contestai, dichiarando che era tutto un trucco, perché dicendo che ero bravo volevano togliermi da lì.[...] Trasferito a Catania mi hanno messo in uno sgabuzzino. [...] Ricordo che non avevo una scrivania né un telefono, mi sedevo nel posto del collega che quel giorno era di corta».
«I processi misero in evidenza esattamente quanto vi sto raccontando. Tutti i trasferimenti e l'unica sospensione che ebbi senza sospensione dello stipendio sono stati cassati, le sentenze ora sono Pag. 16definitive e devo anche dirvi che in sede di risarcimento del danno ad oggi la Domenico Sanfilippo editore mi ha liquidato 604.000 euro. Questa vicenda però non è finita perché, tenuto conto che non mi riporta in redazione come dicono le sentenze, ogni due anni faccio una causa di risarcimento del danno. [...] Nel corso dei procedimenti scoprimmo poi che Ciancio si era incontrato con Salamone, che avevano utilizzato un po’ di gente per gettare fango sul mio nome, sulla mia persona, ma fortunatamente sia in sede civile che in sede giudiziaria sono riuscito a dimostrare l'infondatezza di tutte le cose proditoriamente diffuse, e dal 1996 ad oggi sono diciotto anni che
percepisco lo stipendio e ogni due anni un risarcimento del danno ma non ho più messo piede in redazione ad Agrigento. Per la cronaca, Filippo Salamone è stato arrestato per mafia, è stato condannato definitivamente a sei anni e mezzo, e io sono qui».
Ed ancora, sulla vicenda Salamone: «Per effetto del mio primo articolo Salamone e l'Impresem hanno querelato e citato per danni me e il mio editore. [...] Prima ancora di arrivare al processo scoprii – e da lì capii che c'era stato l'incontro tra Ciancio e Salomone, poi confermato, e che si era parlato del mio trasferimento – che Salamone aveva rinunciato ad ogni attività risarcitoria e ritirato le querele nei confronti di Mario Ciancio. Davanti al tribunale di Catania venni assolto [...] con motivazioni lusinghiere in quanto nella sentenza definitiva si evidenzia che avevo svolto bene il mio mestiere, senza alcuna fantasia o astio nei confronti di chicchessia, [...] Salamone venne condannato a risarcirmi un danno di 26.000 euro.»
Nel corso dell'audizione il giornalista ha focalizzato, seppur sinteticamente, due criticità, peraltro ribadite da altri suoi colleghi auditi: la precarietà contrattuale e le tutele – non sempre efficaci – offerte a livello regionale dall'Ordine dei giornalisti.
Sul primo punto, ricorda Francesco Castaldo: «Sono stato il primo giornalista professionista ad Agrigento. [...] Ho fatto quindici anni di gavetta lavorando a 2.000 lire a pezzo, ho cominciato con la macchina da scrivere e per ottenere un contratto ho impiegato quindici anni. Considerate che sono stato il primo professionista ad Agrigento, il primo fatto da “La Sicilia”, perché fino a quel momento la redazione era frequentata da persone che avevano un lavoro principale. Quindi il primo professionista sono stato io e la redazione ad Agrigento c'era dal 1950: quarant'anni dopo La Sicilia ha fatto un professionista».
Sul ruolo in Sicilia dell'Ordine in relazione alla vicenda che lo ha visto protagonista: «Con una velocità mai vista e prima ancora di cominciare a ragionare, alla conferenza stampa di Salamone (che annunciava la querela nei confronti di Castaldo, ndr.) l'Ordine fece un comunicato dicendo: «abbiamo aperto un fascicolo e ci stiamo occupando di questa cosa», nel senso che era stato aperto un fascicolo nei confronti di Castaldo a seguito delle accuse rivolte a Salamone. [...] Il Presidente portava le carte dall'Ordine a Mario Ciancio a Catania: quando uno che ha un contenzioso con l'editore, tra le carte trova il proprio verbale con la scritta «consegnato a mano a Catania a Mario Ciancio» capisce che non l'hanno fatto neanche disturbare per andarselo a prendere ! Questo succedeva.»
«Successivamente si registrava un cambiamento di rotta: [...] l'Ordine, non questo che aveva aperto l'istruttoria, ma il successivo con Pag. 17Parodi presidente, censurò Mario Ciancio, gli scrisse più di una volta e fece un documento di solidarietà nei miei confronti».
Castaldo ricorda anche la posizione della Federazione Nazionale della stampa: «Ha fatto una battaglia serrata, che però non ha prodotto i risultati sperati perché Ciancio comunque si è arroccato e ha detto “io questa cosa non la faccio !”».
Il Comitato ha voluto approfondire il caso Castaldo anche nel corso dell'audizione del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Riccardo Arena (11) (che riprendiamo più diffusamente in altra parte di questa relazione). Questa è la parte dell'audizione dedicata all'argomento:
«RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. Devo dire che il collega Castaldo paga, dal nostro punto di vista, l'anomalia di cui parlavo. Lì abbiamo un editore-direttore nella stessa persona, ma nel caso specifico non agisce come giornalista, bensì come imprenditore, come titolare e proprietario di un quotidiano. È un po’ complicato per noi oggi, per il consiglio di disciplina, intervenire e punire una persona che ha anche un'altra funzione, dato che questa persona è anche direttore. [...] Credo che non agisca neanche il giornalista Ciancio, ma un'azienda che ha deciso di non riavere più al suo interno il collega Franco Castaldo, che credo non abbia più grande interesse, dato che ha ottenuto i risarcimenti e ha una sua realtà professionale.
PRESIDENTE. Per capirlo noi e perché resti ai nostri atti, se ci troviamo di fronte a una figura un po’ patologica, come quella rappresentata da chi è contemporaneamente direttore ed editore, [...] l'Ordine ritiene prevalente la funzione di editore, e quindi fa un passo indietro, o non ritiene comunque di far valere le regole della professione, anche se quel professionista è contemporaneamente un editore ? Il fatto, cioè, di essere anche l'editore, con questa lettura non rischia di diventare una causa di giustificazione per tutto ciò che viene commesso nella funzione e nella veste di direttore, e quindi di giornalista ?
RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. No, non è una causa di giustificazione [...] l'Ordine della Sicilia dovrebbe intervenire su una situazione che va avanti da circa trent'anni o forse anche di più. Esistono anche altre realtà siciliane. A parte quella del Giornale di Sicilia, fino a qualche tempo fa avevamo la Gazzetta del Sud, che aveva una situazione simile. l'ordine nazionale non ritiene illecito quello che avviene. Purtroppo, è un fatto molto inopportuno, molto spiacevole, ma se dobbiamo agire, dobbiamo farlo con la certezza minima di non imbarcarci in un'avventura che finisca con il consolidare...
PRESIDENTE. Quest'Ordine regionale, al di là di quello che ritiene l'Ordine nazionale, ha mai ritenuto di dover mettere per Pag. 18iscritto, anche in forma amichevole, la preoccupazione sull'opportunità di continuare a mantenere le due funzioni ?
RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. No, non l'abbiamo fatto per iscritto, ma la nostra posizione è assolutamente nota».
2.4) La «normalizzazione» dell'emittente siciliana Telecolor.
Sintomatica dei rischi che si annidano nell'editoria, a causa del controllo monopolistico di taluni segmenti di mercato è la vicenda di Telecolor.
Il giornalista Domenico Valter Rizzo (12) è stato ascoltato dall'VIII Comitato affinché potesse ricostruire una vertenza che lo ha visto tra i protagonisti, cioè il licenziamento di alcuni giornalisti e lo smantellamento de facto della redazione di Telecolor, l'emittente regionale più importante in Sicilia all'epoca dei fatti, di proprietà dell'editore Mario Ciancio.
Nell'audizione, Rizzo ricostruisce anzitutto il contesto editoriale in cui si colloca l'emittente per cui lavorava.
«La vicenda di Telecolor va inquadrata nella situazione dei media catanesi e siciliani. I mass media siciliani sono in grandissima parte sotto il controllo di un unico editore, Mario Ciancio Sanfilippo che non è soltanto proprietario del quotidiano La Sicilia e delle emittenti televisive Antenna Sicilia, Telejonica e Teletna, con tutti i rispettivi canali controllati da queste emittenti, e anche dell'emittente radiofonica Radio SIS, dei siti web LaSicilia.it e LaSiciliaweb, ma ha anche quote del gruppo che controlla il quotidiano più diffuso a Messina e in Calabria, la Gazzetta del Sud, e il 16 per cento del Giornale di Sicilia. Ciancio è anche proprietario del più grosso centro stampa tipografico della Sicilia, centro che stampa numerosi quotidiani nazionali tra cui (li cito perché due vicende riguardano direttamente questo aspetto) la
Repubblica e l'Unità (finché quest'ultimo non ha cessato la pubblicazione). [...] Ciancio è anche vice presidente dell'agenzia ANSA, la cui redazione catanese ha sede nei locali del quotidiano La Sicilia.»
In un quadro fortemente polarizzato dalle iniziative editoriali riferibili a un solo gruppo, Telecolor, ricorda Rizzo al Comitato, «rappresentava oggettivamente un ostacolo a un controllo totale dei mass media in Sicilia».
Telecolor nasce nel 1976, fondata da alcuni imprenditori catanesi, e dopo diversi passaggi editoriali viene totalmente acquisita dal gruppo Italimprese che faceva capo all'imprenditore Eugenio Rendo.
«Dentro questa redazione – ricostruisce Rizzo – si era formato un gruppo di giovani giornalisti, del quale facevo parte anch'io, che non aveva mai avuto alcun tipo di contatto con il gruppo Ciancio. [...] Sostanzialmente eravamo un gruppo di giornalisti che non dovevano dire grazie a nessuno e quindi lavoravamo in maniera assolutamente autonoma. Telecolor non faceva un'informazione barricadera, non Pag. 19faceva un'informazione rivoluzionaria, non faceva controinformazione: faceva un telegiornale come andava fatto, noi raccontavamo i fatti come stavano, senza togliere e senza mettere, senza fare campagne di stampa in una direzione o in un'altra: avevamo la possibilità di fare un telegiornale normale. Questo a Catania non era consentito, in quanto fare un'informazione normale, svincolata dal controllo, diventava un atto rivoluzionario. Bisogna anche dire
che in questo gruppo di giornalisti alcuni si erano formati anni prima, proprio quando erano molto giovani, addirittura nella redazione del Giornale del Sud diretto da Giuseppe Fava. Cito Alfio Sciacca per tutti, ma ce n'erano anche tanti altri».
«Telecolor era diventata anche un grande punto di riferimento nazionale, perché nel momento in cui si verificavano episodi importanti gli inviati di tutti i giornali si concentravano a Telecolor, interagivano con la sua redazione e in determinate situazioni si rilevava una concentrazione anche degli inviati dei grandi giornali internazionali (penso per esempio agli inviati del Guardian, del Financial Time...). Bisogna anche dire che dalla fine degli anni ’80 alcuni di noi avevano assunto l'incarico di corrispondenti di alcuni quotidiani, segnatamente l'Ora, l'Unità, la Repubblica, il Corriere della Sera, Il Mattino e La Stampa, e il sottoscritto era il punto di riferimento della redazione di Michele Santoro da Samarcanda in avanti. [...] C'era un'azione quasi quotidiana, per cui sul quotidiano La Sicilia si scriveva una cosa e noi ne mandavamo in onda
un'altra, sui giornali nazionali i nostri pezzi raccontavano una realtà completamente diversa da quella che veniva raccontata da La Sicilia».
Insomma, Telecolor rappresentava l'unica alternativa al monopolio del mercato (anche pubblicitario) in Sicilia. «E questo – spiega Rizzo nel corso della sua audizione – era un altro elemento per cui Ciancio mirava ad acquisire la proprietà di Telecolor. Cosa che più volte aveva tentato invano di ottenere, fino a quando la crisi economica del gruppo Italimprese mise Telecolor in una condizione di assoluta vulnerabilità sul piano economico e quindi Ciancio riuscì ad acquisire in due tornate la totalità del pacchetto azionario, intestandola alla moglie e alla figlia».
«L'azione di normalizzazione sulla redazione di Telecolor non è avvenuta in un giorno, ma è stata un'azione graduale che si è protratta nel tempo. Con la scusa che bisognava risparmiare ci toglievano totalmente i mezzi per potere lavorare, e addirittura siamo arrivati al paradosso che quando arrestarono Provenzano abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione all'amministratore delegato, cioè a un ragioniere, per far partire un inviato speciale per andare a seguire l'arresto di Bernardo Provenzano ! Non ci facevano pressioni su cosa dovevamo scrivere, ma semplicemente non ci facevano lavorare. Ci hanno tolto gli operatori, ci hanno tolto i tecnici di montaggio, hanno ridotto la televisione in una condizione in cui era difficilissimo continuare a lavorare».
«Poi hanno fatto un'altra operazione propedeutica a quella dei licenziamenti [...] Ciancio crea un'agenzia, che si chiama Asi, di proprietà della famiglia Ciancio e diretta dalla figlia di Ciancio. Questa agenzia [...] viene incaricata senza che nessuno di noi venga coinvolto, contattato o avvertito (tantomeno vengono avvertiti il direttore o il Pag. 20comitato di redazione che da contratto dovrebbe essere consultato di fronte a una cosa di questo genere) di occuparsi totalmente dei servizi sportivi. Telecolor forniva all'Asi i tecnici di montaggio, gli operatori, i macchinari, tutte le strutture, l'energia elettrica, tutto quello che serviva per la produzione di servizi sportivi e in più pagava anche le uplink, che sono sostanzialmente i noleggi dei passaggi satellitari per trasmettere via satellite [...] l'Asi non spendeva una lira, spendeva tutto
Telecolor e in più Telecolor dava all'Asi 750 mila euro ogni anno. Finchè, il 2 settembre 2006, la redazione di Telecolor decide di scioperare di fronte a questa situazione. Angela Ciancio, la figlia di Mario Ciancio, convoca i rappresentanti sindacali della redazione, il comitato di redazione e il direttore in una riunione nei locali de La Sicilia, e viene detto in maniera molto chiara che o noi accettavamo che l'Asi si occupasse anche di tutta la cronaca, non soltanto dello sport, oppure sarebbero stati assunti «provvedimenti drastici». [...] Secondo quanto ci veniva chiesto dalla signora Angela Ciancio l'agenzia Asi avrebbe dovuto occuparsi totalmente dell'informazione, sarebbe stata una sorta di redazione parallela che avrebbe seguito i casi «più sensibili», mentre noi ci saremmo occupati della parte residuale [...] La risposta è stata categorica: non se ne parla. La redazione ha confermato lo
sciopero ed è stato ribadito che un'informazione prodotta da soggetti che non fossero sotto il controllo del direttore responsabile della redazione, controllo fondamentale sulla base dell'articolo 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, sarebbe stata una violazione dell'autonomia professionale della redazione. [...] Il 22 febbraio del 2006, pochi mesi dopo i fatti che sto riferendo, viene avviata la procedura di licenziamento, ufficialmente perché bisognava risparmiare. Il risparmio doveva essere intorno ai 400.000 euro solo per la redazione».
La vertenza va avanti e in un primo momento sembra trovare – ricostruisce Rizzo – un punto di mediazione positiva.
«Il 20 giugno 2006 dovevamo vederci per la firma (dell'accordo raggiunto, ndr). Invece arriva una lettera inviata al prefetto e a noi del comitato di redazione: o accettate che l'Asi entri dentro Telecolor e faccia una redazione parallela, per cui voi venite esautorati e vi garantite lo stipendio, oppure noi procediamo con i licenziamenti. Il risultato è stato che noi abbiamo rotto il tavolo. [...] Il 2 luglio vengono eseguiti i primi due licenziamenti, quelli del collega Sciacca e del collega Fabio Albanese, rispettivamente vice caporedattore e caposervizio. Il direttore Nino Milazzo che, sempre sulla base del contratto nazionale di lavoro, avrebbe dovuto avallare i licenziamenti, si è rifiutato e si è dimesso per protesta. A quel punto Ciancio convoca una redattrice, Michela Giuffrida, che doveva essere anche lei licenziata, e la nomina direttore. Noi non votiamo la fiducia nei confronti di questa persona e sono
scattati i licenziamenti per gli altri colleghi che rimanevano. Se non ricordo male, l'Asi è stata messa in liquidazione sei o dodici mesi dopo il nostro licenziamento e non ha mai fatto altro».
La vicenda in questione è stata affrontata dal giudice del lavoro del tribunale di Catania che, con sentenza n. 4538 del 2009, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ordinando a reintegra nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento. La decisione Pag. 21è divenuta esecutiva con la sentenza in Cassazione n. 770.15 del 19 gennaio 2015.
Sulla vicenda Telecolor il comitato ha audito anche Nino Milazzo che fu, appunto, l'ultimo direttore prima dei licenziamenti a cui si riferisce la succitata sentenza. Milazzo (della cui audizione diamo conto più diffusamente in altra parte di questa relazione) ha ricostruito per il Comitato non solo la cifra giornalistica di quell'esperienza ma anche il rapporto che ebbe durante quegli anni con l'editore dell'emittente, ovvero il gruppo Ciancio.
«Non solo Telecolor si atteggiava a un'autonomia assoluta e impenetrabile – ha ricordato Milazzo – ma diventava un condizionamento per gli altri, nel senso che chi avesse voluto omettere o falsificare era costretto a seguirci... Non ho mai avuto nessuna pressione da nessuno. Nessuno ha osato mai dirmi cosa dire o non dire. Mai nessuno ha osato farmi una telefonata. Anzi, a testimonianza dell'assoluta, quasi maniacale autonomia con cui volevo affermare il ruolo della testata, ricordo che in un'occasione un servizio pubblicitario introdusse irregolarmente elementi di informazione, allora feci un editoriale attaccando l'azienda e dicendo che non si permettessero più di farlo. Cito questo episodio non per vanità o per dire che sono stato forte, ma per dire che la nostra autonomia era talmente vigorosa e urticante che feci un attacco all'azienda di cui ero dipendente e nessun osò dirmi nulla. Da questo
punto di vista, non ho avuto pressioni» (13).
Anche l'onorevole Michela Giuffrida, giornalista, oggi parlamentare europeo e all'epoca della vertenza Telecolor direttore ad interim dell'emittente, conferma questo punto di vista: «La redazione di Telecolor è sempre stata un punto di riferimento per il panorama informativo nazionale. Nella redazione di Telecolor c'erano tutti i corrispondenti dei giornali nazionali, che liberamente, così come facevo io, scrivevano ciascuno per il proprio quotidiano». E sui rapporti con l'editore, aggiunge: «Non ho mai subìto pressioni o richieste e non sono mai stata condizionata dalla presenza della famiglia Ciancio» (14).
Sui sei licenziamenti (quattro dei quali avvennero durante la sua direzione ad interim), puntualizza la Giuffrida: «Il mio coinvolgimento è praticamente inesistente. La procedura di licenziamento di Telecolor comincia con comunicazione preventiva il 22 febbraio 2006, direttore Nino Milazzo. In quel momento l'azienda denuncia un esubero di nove unità... Da dipendente anziano, io vengo nominata direttore ad interim nel momento in cui il direttore Milazzo si dimette e dopo di me, dopo questo periodo, credo già a settembre o il primo ottobre, comunque non più tardi di allora, arriva il nuovo direttore...» (15). Alla domanda se, nella sua qualità di direttore, avrebbe potuto evitare quei licenziamenti, la risposta dell'onorevole Giuffrida è netta: «Ritengo che i licenziamenti sarebbero comunque andati a buon fine, non potendo
Pag. 22nessuno interagire con questa procedura, che allora l'editore estrinsecò per motivazioni economiche. Certamente qualunque mio atto non avrebbe potuto intaccare la volontà che l'editore... Io non li ho certamente avallati: è una procedura che ha visto il suo epilogo in quella data ma non ho avuto alcun ruolo in questa procedura» (16).
Resta – tra la Giuffrida e il suo predecessore Milazzo – una lettura diametralmente opposta sulle ragioni che indussero la famiglia Ciancio a procedere a quei licenziamenti.
«La mia idea – ci ha detto Nino Milazzo – è che si è partiti da una crisi economica, ma si è colta questa difficoltà per smantellare una redazione e una testata che disturbava i manovratori perché era incontrollata e incontrollabile. Nessuno osava intervenire. La mia opinione è questa. La cosa si realizzò anche perché io avevo detto che se avessero fatto un solo licenziamento, mi sarei dimesso. Naturalmente, questa affermazione fu colta al volo dall'editrice, che era la figlia di Ciancio, per fare un primo licenziamento che mi indusse a dimettermi. Poi seguirono altri licenziamenti» (17).
Di segno opposto la valutazione di Michela Giuffrida: «Io non ho motivo di supporre che la redazione di Telecolor sia stata smantellata per questo» (18).
2.5) La mafia nel litorale romano.
La vicenda di Federica Angeli, cronista de la Repubblica per la cronaca di Roma, inizia con una video-inchiesta girata all'interno del lido di Ostia Orsa Maggiore. In questo lido, con una serie di sotterfugi e grazie a complicità nella struttura tecnica del municipio di Ostia, erano riusciti ad entrare nella gestione anche esponenti della criminalità locale, in particolare Armando Spada, che il 4 novembre 2014 sarà tra gli arrestati di un'operazione congiunta tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia costiera su mandato della DDA di Roma.
Racconta la giornalista nel corso dell'audizione (19): «Quando si accorge della telecamera, Spada mi chiede di spegnerla e di cancellare quanto avevo registrato. Mi dice che se non avessi fatto questo mi avrebbe sparato in testa. I ragazzi che erano con me, non conoscendo lo spessore criminale di queste persone che operano esclusivamente su Ostia, gli dicono: “Che hai detto ? Ci hai minacciato ?”. Di fronte a questa provocazione, [...] mi prendono, per un'ora e mezza mi chiudono in una stanzetta e mi perquisiscono. Armando Spada mi dice chiaramente: «Qui a Ostia per trent'anni ha funzionato così. Adesso tu ti fai gli affari tuoi, ti giri dall'altra parte e fai un'inchiesta su altro, perché Pag. 23non esiste che finora abbiamo campato bene e adesso arrivi tu. Chi sei ? Ha sempre funzionato
così !»
Successivamente la Angeli è testimone anche di uno scontro notturno, a colpi di coltello e di pistola, tra esponenti del clan Triassi ed esponenti del clan Spada. La giornalista non si limita a scriverne ma decide di denunziare i fatti ai carabinieri. Ed è in quel momento, anche alla luce di nuove minacce che nel frattempo ha ricevuto, che la Angeli viene messa sotto protezione.
Di fronte a una sovresposizione così manifesta della cronista de la Repubblica (aggredita platealmente perfino sulle pagine dei socialnetwork da esponenti della famiglia Spada), il comitato ha cercato di approfondire anche il comportamento sulle vicende di Ostia degli altri mezzi d'informazione. È la stessa Angeli a raccontare: «Abbiamo cinque quotidiani cartacei, l'edizione locale de Il Messaggero, più tre televisioni, che sono Canale 10, Ostia TV e un'altra più piccola. In tutti questi anni, da cittadina di Ostia prima ancora che da giornalista, leggendo mi sono resa conto che, tranne Alessandro Fulloni che stava al Corriere della sera ed era un ottimo collega, non ci sono stati altri che hanno fatto qualcosa in più rispetto alla pubblicazione del comunicato che ci potevano passare la polizia o i carabinieri su operazioni che c'erano state. [...] Devo dire che a
l'Espresso Lirio Abbate ha fatto diverse cose su Roma, citando sempre queste famiglie criminali e ovviamente allargando il tiro ad altri gruppi criminali, come i Carminati. [...] Tuttavia non ho visto nessuno proseguire l'inchiesta o fare un passo in più. Non sono in grado di dire se sia stato per paura o per mancanza di volontà. Per quanto riguarda il mio giornale, all'indomani dell'assegnazione della scorta, mi ha impedito di scrivere ancora di Ostia per una questione di mia sicurezza. È stata una decisione che in parte ho condiviso e in parte no, perché da quel momento si è smesso di parlare di Ostia».
Sempre sulla zona del litorale romano opera il giornalista Luigi Centore, giornalista pubblicista, che si occupa prevalentemente di Ardea, una cittadina circa trenta chilometri a sud di Ostia, con quasi 50 mila abitanti. Anche Centore, che attualmente scrive per la testata locale Il faro on line, è stato sentito in audizione (20). In particolare la sua vicenda nasce da alcuni articoli, a cui hanno fatto seguito anche interrogazioni comunali, sul fatto che in un terreno demaniale molto ampio fossero sorte negli anni diverse attività economiche e commerciali senza alcuna autorizzazione. Si tratta di circa sessanta capannoni in località “Le Salzare”. Dopo aver denunciato questa storia, ed altre vicende legate ad appalti comunali, ha subito due attentati contro la sua auto: il primo nel 2005 ed il secondo nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 2013.
Non sono stati casi isolati. Negli ultimi anni ad Ardea sono state bruciate diverse auto di esponenti delle istituzioni tra cui il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il presidente della Commissione ambiente. In quel territorio esiste solo un'altra rivista on line, oltre quella con cui collabora Centore, e anche il direttore di quella testata è stato minacciato. Spiega Centore: «Ogni volta che mi sono interessato Pag. 24di problemi amministrativi relativi ad appalti e a gestioni che io ho ritenuto poco chiare (molte sono poi finite presso il tribunale di Velletri) sono successe intimidazioni, minacce, incendi di auto anche ai miei familiari...»
Le denunce presentate da tutti i danneggiati non sembrano aver portato ad alcun risultato giudiziario al momento. La vicenda di Ardea è un altro paradigma di come sia difficile il racconto dei fatti criminali nei territori lontani dalle luci della ribalta, anche se si trovano a pochi chilometri da Roma.
2.6) La solitudine dei cronisti minacciati.
Sui rischi di isolamento cui vanno incontro i giornalisti minacciati anche all'interno delle loro stesse redazioni è stato audito Carlo Bonini, inviato de la Repubblica e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti (21).
«Quasi sempre la minaccia produce un effetto perverso, perché il collega minacciato, intorno al quale immediatamente si stringe una qualche forma di solidarietà, passati un mese, due mesi o tre mesi, diventa un problema per la sua redazione e per gli altri colleghi. Normalmente, quindi, diventa due volte vittima: è vittima prima di chi lo minaccia e poi di un clima di sostanziale fastidio, indifferenza o addirittura isolamento nel suo stesso contesto di lavoro».
«Quello che invece mi preme dire e che personalmente ho potuto osservare e osservo è che, come sempre, c’è un punto critico, che riguarda appunto la tenuta del sistema informativo rispetto alle minacce delle mafie, piccole, medie o grandi che siano, e che ha a che fare con lo stato miserabile (io uso questo aggettivo consapevolmente) dell'informazione italiana. Quando dico «miserabile» intendo dire che il mercato dell’ informazione in Italia, non diversamente da altri Paesi europei, come sapete, sta attraversando una crisi strutturale profonda. Il numero dei disoccupati ormai è molto alto. Le figure professionali sono sempre più evanescenti dal punto di vista delle garanzie. Come voi sapete, nella legge istitutiva dell'Ordine esiste storicamente una differenza tra il giornalista professionista e il cosiddetto «pubblicista». Oggi, di fatto, il rapporto tra pubblicisti e professionisti si
è capovolto. Il mercato del lavoro non produce più praticanti e, quindi, non produce più professionisti o ne produce un numero molto ridotto. Il lavoro dei giornali, delle radio e delle televisioni pesa sempre di più e per lo più sulle spalle di giornalisti che sono formalmente pubblicisti, ma di fatto spesso fanno un lavoro da professionisti. Come se non bastasse, questi colleghi, che da un punto di vista formale sono già più deboli e più fragili nelle garanzie, si misurano con un mercato del lavoro dove la retribuzione media di un pezzo di cronaca non supera i quindici, venti euro lordi».
«È evidente che per un'organizzazione criminale condizionare e manipolare l'informazione in una grande città come Roma è un pochino Pag. 25più complicato. È un po’ difficile far uscire, sulle cronache locali dei quotidiani che si stampano a Roma, notizie pilotate e utili alle organizzazioni criminali. Diventa molto più agevole farlo in provincia e in periferia. Non sto pensando solo alla Campania o alla Sicilia, ma anche al Lazio. Penso ai giornali locali della nostra regione, dove il grado di intimidazione e di intossicazione cresce al crescere della fragilità del tessuto che si trova di fronte».
Altra esperienza significativa, che il Comitato ha potuto raccogliere, è quella di Rino Giacalone, giornalista trapanese, uno dei più attivi – e dei più esposti – sul fronte dell'informazione su cosa nostra. La «solitudine» in questo caso viaggia sul crinale delle querele per diffamazione, assai spesso strumentali – per l'uso e l'abuso che se n’è fatto – nei confronti dei giornalisti (ne parliamo più diffusamente in altra parte di questa relazione).
«Io non mi sono mai sentito intimidito più di tanto. Le intimidazioni sono state ben altre e sono state le querele subìte – ha spiegato Giacalone al Comitato –. Una di queste querele in sede civile l'ho appena perduta con l'ex sindaco Girolamo Fazio di Trapani, una querela nata da un articolo in cui si diceva che quel sindaco, per negare la cittadinanza onoraria a un ex prefetto, Fulvio Sodano, di recente scomparso, aveva detto che l'antimafia faceva più danno della mafia. Mettevo in evidenza che nei pizzini che erano stati allora appena ritrovati della corrispondenza particolare di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso sosteneva la stessa cosa... Sono stato condannato a pagare 25 mila euro. La sentenza è già esecutiva: il sindaco Fazio ha messo in azione il precetto. Per valutare l'entità del danno morale subìto da questo signore considerate che questo articolo venne scritto mentre
lui era alla prima sindacatura: uscì l'articolo, affrontò la seconda candidatura venendo eletto con il 70 per cento dei consensi a Trapani, e successivamente venne eletto deputato regionale di Forza Italia, primo degli eletti. Quell'articolo gli ha fatto grandissima pubblicità più che danno...
In questo momento è in itinere il procedimento che mi vede citato direttamente in giudizio perché alla morte di un importante boss di Mazara del Vallo, Mariano Agate, nel ricordare le malefatte di quell'uomo (bambini straziati dal tritolo, omicidi, la condanna per la strage di Capaci) mi sono limitato a dire che, come Peppino Impastato diceva – perdonate il termine – che «la mafia è una montagna di merda», con la morte di Mariano Agate un pezzo di questa montagna veniva meno. La vedova mi ha querelato, un pubblico ministero a Trapani dapprima ha tentato di farmi incontrare la vedova per stringerle la mano e vedere di rimettere la querela ma io non mi sono presentato, e adesso sono citato in giudizio per avere dato – credo – a un mafioso quello che si merita».
Infine, tra i giornalisti più attivi nella denuncia di vicende poco trasparenti nel settore dei rifiuti e delle infiltrazioni mafiose nell'economia e nella politica locale (in una zona che resta spesso nell'ombra come la provincia di Ragusa) va ricordato anche il giovane giornalista Paolo Borrometi che ha scritto numerosi articoli sul suo blog La spia. E che per questo lavoro di scavo e di investigazione è stato fatto oggetto di significative minacce.
3. Gli elementi di fragilità del mestiere di giornalista.
3.1) La sottovalutazione del fenomeno delle minacce.
Nell'ultimo rapporto elaborato da Ossigeno per l'informazione è stata fatta, su incarico specifico della Commissione Antimafia, un'analisi puntuale non solo dei dati sul fenomeno delle minacce e delle intimidazioni subite dai giornalisti italiani, ma anche su come sono percepite dalla classe politica, dall'opinione pubblica diffusa e dagli stessi giornalisti.
«Le intimidazioni, le minacce, gli abusi e le forzature del diritto condizionano la vita e il lavoro di migliaia di operatori dell'informazione, e rimangono in gran parte impuniti» scrive il rapporto. Un'analisi su 1227 giornalisti vittime di intimidazioni fra il 2011 e il 2014 rivela la seguente composizione qualitativa: avvertimenti 43 per cento, aggressioni e danneggiamenti 21 per cento, querele pretestuose e altri abusi del diritto 36 per cento. Questi e altri dati (esposti dettagliatamente nel rapporto finale che la Commissione ha acquisito) confermano che in Italia le intimidazioni ai giornalisti non sono episodiche, si manifestano da anni con un trend costante (oltre 300 ogni anno), sono diffuse sull'intero territorio nazionale e soprattutto stanno divenendo più frequenti (il 50 per cento di incremento nell'ultimo anno).
Per contro, scrive il rapporto di Ossigeno per l'informazione, «i media, la politica e gli stessi giornalisti continuano a ignorare un problema così grave e di così vaste dimensioni. La negazione del problema è l'ostacolo principale da superare. Si ottiene l'oscuramento dando visibilità mediatica soltanto agli episodi più eclatanti e rappresentando il fenomeno complessivo come un insieme di piccoli fatti locali non collegati da una matrice comune. Ciò consente anche alla politica di minimizzare il problema e di occuparsi soltanto delle intimidazioni più gravi ed evidenti, trascurando le cause generali del fenomeno.
Anche la solidarietà sociale verso i giornalisti minacciati è debole. Esprimere solidarietà a un giornalista minacciato in alcune parti d'Italia è considerato rischioso e spesso la solidarietà è formale, fredda, rituale. Inoltre, negli ultimi anni le dichiarazioni pubbliche di vicinanza ai giornalisti minacciati sono diminuite.
Molti, soprattutto i cronisti locali, avvertono il clima di paura e subiscono le intimidazioni senza reagire. Ma altri trovano il coraggio di ribellarsi. [...] Sono moltissimi i giovani giornalisti che negli ultimi anni hanno sfidato il silenzio imposto dalle cosche e hanno vinto la partita, facendo conoscere informazioni importanti cui l'opinione pubblica altrimenti non avrebbe avuto accesso.
Sulla molteplicità di strumenti per mettere a tacere o condizionare un giornalista, la ricerca di Ossigeno per l'informazione conferma le valutazioni che sono state offerte al Comitato da quasi tutti gli auditi.
«In Italia si può mettere a tacere un giornale e un giornalista senza ricorrere alla violenza. Si possono usare strumenti legali potenti ed efficaci come le querele per diffamazione, come le citazioni per danni che – anche quando vengono attivate senza fondato motivo – riescono a determinare forti condizionamenti. Riescono a farlo già prima che un Pag. 27giudice esamini le denunce e decida sulla loro ammissibilità. Questi veri e propri abusi del diritto sono consentiti da leggi anacronistiche e punitive nei confronti dell'informazione giornalistica e di chi la produce e la diffonde.».
3.2) L'informazione precaria: freelance, sommersi, marginali.
Dal Terzo Rapporto di Ossigeno per l'informazione 2011/12 si evidenziava come anche l'OSCE avesse rimarcato che in Italia «è necessario rompere la spirale che produce da anni una progressiva intensificazione dell'uso della violenza e del ricorso agli abusi per condizionare l'attività giornalistica e impedire la pubblicazione di notizie sgradite».
Un clima sempre più condizionante per chi osserva i fatti, raccoglie informazioni, per chi non si ferma alle versioni parziali, alle “veline”, ai comunicati ufficiali.
Per rompere la spirale, è indispensabile soccorrere e sostenere soprattutto i cronisti locali, i giornalisti, i fotoreporter, gli operatori televisivi di piccole testate locali, freelance e blogger che raccontano – spesso in esclusiva – ciò che accade nei piccoli comuni e nelle terre di mafia; i giornalisti che stanno nei fatti, quelli che sono più attenti ai risvolti degli avvenimenti, quelli che si documentano direttamente, quelli che si spingono più avanti. Occorre premiarli, incoraggiarli, indicarli ad esempio. È necessario, in sintesi, dare ossigeno all'intero sistema dell'informazione per respingere una concezione rinunciataria, burocratica, accomodante del giornalismo.
Nell'ultimo rapporto Ossigeno per l'informazione si evidenzia come questa «marginalità» sia esasperata da una situazione di crescente debolezza economica delle testate, soprattutto di quelle della carta stampata. «Negli ultimi quattro anni la crisi ha ridotto sensibilmente le risorse dell'editoria. Il fatturato totale delle tv è sceso sotto dieci miliardi. Il mercato pubblicitario ha subito un calo del 14,6 per cento in nove mesi, penalizzando soprattutto la carta stampata. In quattro anni la crisi ha espulso dalle redazioni duemila giornalisti professionisti su diciottomila. Altre migliaia di operatori dei media hanno perso il lavoro o hanno subito sensibili riduzioni di stipendio. La politica ha acquisito più potere sulle fonti di finanziamento all'editoria e la criminalità organizzata ha trovato nuove occasioni per infiltrarsi nei media. Tutto ciò ha ridotto lo spazio dell'informazione
giornalistica di qualità, ha ridotto il pluralismo, l'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti.»
Oggi i giornalisti con un contratto di lavoro stabile sono soltanto 15.891 (13.048 professionisti, 2.700 pubblicisti e 143 praticanti) a fronte di quasi 60 mila operatori a vario titolo nel settore. E la categoria subisce una progressiva, inarrestabile erosione visto: nel 2009 erano inquadrate regolarmente 18.859 persone, dunque in cinque anni «il tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico è 6,4 volte maggiore di quello della generalità del sistema Paese» spiega Andrea Camporese, presidente dell'Inpgi (l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti). Se si valuta che i giornalisti professionisti sono in totale 29.110, se ne ricava che – tolti i 13.048 Pag. 28contrattualizzati stabilmente – il 55,18 per cento è in cerca di collocazione.
A ciò va aggiunta una complessiva e crescente contrazione delle retribuzioni dei giornalisti non coperti da contratto. La ricerca “Smascheriamo gli editori” (22), presentata nel 2010 dall'Ordine nazionale dei giornalisti, ha analizzato la situazione dei freelance di una cinquantina di testate nazionali e locali: articoli pagati meno di tre euro e compensi percepiti dopo anni o mai. Nessun settore è immune: dalla carta stampata ai giornali online, dalla radio alla tv.
3.3) Le “persuasioni legali”.
Come abbiamo potuto constatare dalle audizioni, al di là delle minacce tipiche, va aggiunto il fenomeno – peraltro in forte espansione – di un uso strumentale e spesso intimidatorio di alcuni strumenti del diritto.
In particolare, le audizioni di Milena Gabanelli (23) e di Pino Maniaci (24) hanno fatto emergere il delicato aspetto delle querele temerarie e dell'abuso nel ricorso alla causa civile per danni, fenomeni piuttosto diffusi che tendono ad intimidire i giornalisti con richieste economiche esorbitanti e del tutto sproporzionate rispetto all'eventuale danno effettivamente arrecato in caso di errore del cronista.
Su questo punto, di estremo interesse per il comitato è stata l'audizione della signora Milena Gabanelli, responsabile del programma televisivo Report. La Gabanelli e il suo programma hanno ricevuto richieste di risarcimento per una cifra complessiva superiore ai 250 milioni di euro («Ne abbiamo persa solo una in appello per 30 mila euro»): dalla compagnia telefonica HG3 137 milioni di euro ai 10 milioni richiesti dall'editore catanese Mario Ciancio.
«Premetto che io non voglio trattamenti di favore e nemmeno li auspico per la mia categoria. Credo che possiamo fare molto bene, ma anche molto male. Pertanto, nel momento in cui sono accertati la malafede e il dolo, io voglio assolutamente essere punita e non voglio alcuna clemenza. Ciò premesso, riassumo quello che è successo in questi diciotto anni di Report: al momento io ho sessanta cause aperte. Va bene, si tratta di un programma d'inchiesta duro e aggressivo, ragion per cui, giustamente, si determinano delle reazioni. La cosa che non è tollerabile, a mio avviso, è che buona parte delle cause civili non hanno presupposti. Quando mi arriva una querela, io sono felice. Vuol dire che c’è un filtro, che c’è un magistrato che valuta se ci si infilerà nel processo oppure se non ci sono gli elementi. Nelle cause civili, invece, come voi sapete, basta che uno decida che l'hai guardato
storto e ti chieda un sacco di soldi e tu ti infili automaticamente dentro il processo e stai a bagnomaria fino a dieci anni. Il punto è che si innesca un Pag. 29meccanismo perverso. Vengono chieste cifre che non hanno ragione di essere, perché non si capisce dove è stato il danno. Parliamo di milioni di euro. Me n’è arrivata una per 137 milioni di euro, che è durata otto anni, dalla compagnia telefonica H3G. Si è chiusa l'anno scorso e si è chiusa bene. Io avevo chiesto che venisse considerata lite temeraria. Tuttavia, il giudice ha valutato di no, come anche in altri casi».
Non di rado, nell'esperienza della Gabanelli, l'intenzione dissuasiva si manifesta già nell'annuncio di un'azione legale, a prescindere dal fatto che venga o meno realizzata.
«Te lo dicono prima. Ti dicono che, se tu parlerai di questa cosa, ti arriverà la lettera dell'avvocato che dice: «Sappiate che si tratta di una compagnia quotata», oppure «l'immagine dell'imprenditore tal dei tali» o «del mio assistito, se affrontate quell'argomento, verrà danneggiata. State bene attenti, altrimenti procederemo per le vie legali e ne discuteremo nei luoghi di competenza». È una formula di prassi. Almeno nell'80 per cento dei casi. Poi ci sono state querele annunciate e mai fatte: Moncler, per esempio, ha annunciato una grande causa per danni, che, però, finora non è mai arrivata. Ci sono, però, cinque anni di tempo. Cremonini aspettò quattro anni e nove mesi e alla fine ci fece la sua citazione per dieci milioni di euro».
«Come dicevo, un freelance o un piccolo editore, quando si trova delle cause milionarie, certo può pensare di essere sicuro del fatto suo e, quindi, di vincere ma, con i tempi della giustizia civile in Italia, parliamo, se va bene, di quattro anni. In quegli anni chi paga l'avvocato ? Ovviamente, se il giornalista non è tutelato, se lo deve pagare di tasca sua, altrimenti lo paga il piccolo editore, ma anche per il grande editore questo diventa un problema. Nel mio caso, fortunatamente, alle mie spalle ho la RAI. Tuttavia, con sessanta cause, di cui una buona parte chiede risarcimenti danni da dieci milioni in su, quanto deve accantonare l'azienda dentro al fondo rischi ? Quando ci sono delle cause così pesanti, per un editore importante, delle cifre considerevoli devono essere accantonate».
Diversa è la disciplina normativa prevista in altri Paesi europei su eventuali abusi nel ricorso allo strumento della querela o dell'azione civile per danni. Dice la Gabanelli: «Io ho indagato su che cosa succede anche in altri Paesi. In Francia è interessante il fatto che, quanto meno prima di entrare automaticamente nel processo c’è un filtro, ovvero c’è un magistrato, o l'equivalente di un magistrato, che valuta se ci siano gli elementi per entrare dentro il processo. I colleghi di Panorama della BBC, un programma che va in onda tutte le settimane, tutto l'anno, da tempo immemore, non hanno un decimo delle cause che ho io. Perché ? Eppure non è un programma all'acqua di rose il loro... Nel diritto anglosassone, che, a mio avviso, dovrebbe essere preso come esempio, la lite temeraria verso il giornalista è considerata un sopruso, un'intimidazione e un condizionamento della
libertà d'informazione: che è protetta, ovviamente, dalla Costituzione. Pertanto, viene punita in maniera esemplare, fino a quasi un multiplo di ciò che viene chiesto. Quando chiedi 10 milioni di euro e rischi di venir condannato a pagarne 20, giustamente ci pensi un po’. Se ci sono gli elementi, va bene, ma se lo fai puramente per fare in modo che il giornalista per cinque, sei, sette od otto anni non tocchi più quell'argomento, è diverso. Pag. 30Nel nostro caso, in Italia, è prevista la sanzione per le liti temerarie. l'articolo 96 del codice di procedura civile la prevede ma, a mia memoria, io non ricordo che sia mai stato sanzionato qualcuno per lite temeraria. Nei rari casi in cui è successo, il giudice ha stabilito che colui che aveva disturbato il giudice per niente si beccasse una sanzione di mille euro ! Certo, paghi le spese legali delle persone che
hai portato in tribunale per niente, ma che cosa importa al signor Scaroni di turno, alla compagnia telefonica, al grande imprenditore di dover rischiare di pagare 20 mila euro fra sei sette anni ? Più o meno sono queste le spese che il giudice liquida per il pagamento delle spese legali... Al massimo il rischio che corri è di pagare mille euro proprio perché la causa non aveva ragione di esistere».
«[...] Se si assume il fatto che la libertà di informazione è un valore che va tutelato e preservato, bisogna, secondo me, punire con sanzioni esemplari chi interviene temerariamente sul giornalista per tappargli la bocca. Il parametro giusto, io credo, potrebbe essere quello di prendere come riferimento il danno che viene chiesto. l'altra strada potrebbe essere quella di mettere un filtro. Mentre la prima interviene solo nel caso di lite temeraria con il giornalista, proprio per il lavoro che svolge il giornalista, l'altra vale per tutti. Varrebbe anche per i comuni cittadini. Per evitare che ci si infili dentro un processo per le liti da cortile, o anche non da cortile, io credo che una strada potrebbe essere quella del filtro, prima di avventurarsi in questo mondo che tiene a bagnomaria anche per dieci anni».
Certo, l'esperienza della Gabanelli muove da una condizione del tutto particolare: il rapporto con la Rai, committente della trasmissione Report, regolato da condizioni di particolare tutela nei confronti degli autori del programma.
«Noi non siamo dipendenti RAI e quindi la tutela legale è da decidere volta per volta. Un anno ce la volevano togliere e io ho cercato sul mercato una polizza per tutti noi, per me e per i miei collaboratori. Alla fine sono riuscita a trovare sul mercato americano una compagnia che assicurava il prodotto dalle cause, ma non ci copriva per le spese legali, e il motivo è stato il seguente: “Voi siete bravi e diligenti, tant’è che finora, incrociando le dita, non avete perso nessuna causa. In Italia, però, tutti fanno le cause civili e si entra automaticamente dentro al processo e, quindi, la spesa legale è una spesa certa. Nessuna compagnia di assicurazione assicura una spesa certa. Della serie: vi chiedono 100 milioni di euro di danni ? Nessun problema. Noi vi assicuriamo per quello, ma gli avvocati ve li pagate voi”».
«Adesso c’è una clausola inserita nel contratto, nella quale la RAI dice che ci paga le spese legali e ci tutela in caso di soccombenza, salvo in caso di soccombenza dovuta a dolo o colpa grave, come è giusto che sia. Questo, però, avviene dal 2007. Noi siamo in onda dal 1997. I primi dieci anni li abbiamo rischiati tutti sulla nostra buccia. Di fronte alle situazioni problematiche mi consulto con l'ufficio legale della RAI. Sono avvocati, ci mancherebbe altro. Ascolto i suggerimenti. Non mi è mai capitato che mi censurassero, ma io mi consulto molto spesso. A volte basta una parola per evitare problemi. [...] Non temiamo le cause, dobbiamo solo essere certi che eventualmente le vinciamo».
Decine di cause civili. Tutte vinte, finora, tranne una. Così le riassume Milena Gabanelli, partendo dalla più onerosa: quella intentata Pag. 31contro Report dall'operatore telefonico H3G. «Io venivo accusata di aver detto all'epoca – era il 2006, la compagnia stava cercando di entrare in Borsa e, giustamente, chiedeva i soldi al mercato: e io faccio le pulci a chi chiede soldi al mercato – che era una media company. Ci furono, credo, diverse pagine dedicate al danno che si faceva alla compagnia telefonica col sostenere che fosse una media company, quando, invece, è una compagnia telefonica. Caspita, io avevo l'amministratore delegato intervistato in trasmissione che diceva: «Noi non siamo una compagnia telefonica, siamo una media company». Di che cosa venivo accusata ? Poi c'era tutta una parte che riguardava i
filmini porno autoprodotti, nell'area riservata per adulti del telefonino. Producendo questi filmatini, a ogni click c'era la possibilità di avere tre centesimi di ricarica. Pertanto, io mi chiedevo chi fosse interessato a slacciarsi i pantaloni e a farsi un filmino per avere tre centesimi alla volta di ricarica. Per arrivare a quindici euro ce ne vuole. Chi ha figli adolescenti sa benissimo che il problema degli adolescenti sono i quindici euro di ricarica. Non c'era alcun filtro per l'accesso all'area riservata. Consideriamo che il telefono se lo “setta” direttamente il ragazzino. Ci fu nell'immediato l'intervento dell'AGCOM, che fece sospendere il servizio. Questa storia è andata avanti e, lo ripeto, si è chiusa l'anno scorso, nel 2014 – come vedete, sono stata in ballo otto anni – con 137 milioni di euro fra capo e collo, che ti mettono in una condizione problematica verso la tua azienda e verso il tuo direttore.
Anche se non c’è nulla, alla fine devi aspettare che arrivi la sentenza definitiva».
«Adesso ho la causa che mi ha fatto l'ENI – Scaroni personalmente, credo – per una puntata che faceva i conti in tasca alla sua gestione ed ha chiesto 25 milioni di euro di danni. Non c'era una virgola che non fosse documentata... [...] Anche la causa che mi fece Ferrovie dello Stato anni fa fu molto penosa, perché in mezzo ci fu il licenziamento di quattro ferrovieri che furono riconosciuti, licenziati e poi reintegrati. La causa fu di 26 milioni di euro, più un trattamento particolare riservato proprio soltanto a me, per 2 milioni di euro, da parte dell'ingegner Moretti per via del fatto che io avevo detto: “È un uomo di ampie vedute. Da rappresentante nazionale CGIL Trasporti è passato dall'altra parte”: il che è un fatto. Tuttavia, questa dichiarazione era stata vissuta in maniera molto diffamatoria e lui mi chiese 2 milioni di euro. Come avevano composto i 26 milioni di euro ? Sul
danno pubblicitario arrecato a quell'ora con quel tipo di pubblico. Hanno dedotto che, per ristabilire il danno di immagine creato alle ventuno con tre milioni di telespettatori, loro avrebbero dovuto fare campagne pubblicitarie che sarebbero costate quella cifra. [...] Una causa civile è stata intentata anche dall'editore Mario Ciancio Sanfilippo per 10 milioni di euro. Ha perso ed è stato condannato a pagare le spese».
Naturalmente l'azione non si rivolge mai solo alla Gabanelli. «In tutte le cause civili o nelle querele viene citata la RAI, vengo citata io, in qualità di responsabile del programma e anche in qualità di ciò che dico in trasmissione, e viene citato comunque sempre l'autore». Con alcune azioni giudiziarie al limite del paradosso: «A volte ci è capitato che venissero citati tutti i soggetti che erano presenti nei titoli di coda, finanche il montatore...».Pag. 32
A Pino Maniaci, direttore di Telejato, è stato chiesto di ricostruire la vicenda professionale della televisione che dirige da molti anni e che ha il primato delle querele ricevute, più di 300.
Dice Pino Maniaci: «Luciano Mirone ha scritto “Gli insabbiati”, sui giornalisti che sono stati uccisi dalla mafia e sepolti dall'indifferenza. Lei, presidente, ha scritto “I disarmati”, i giornalisti che nel territorio sono stati lasciati soli da destra e da sinistra, e con pochi mezzi hanno cercato di combattere il fenomeno mafioso. Oggi ci sarebbe da scrivere invece dei “diffamati”, perché il mezzo oggi utilizzato per cercare di isolare un giornalista che cerca di fare il proprio dovere è la diffamazione [...]e quindi, come al solito, fare il gioco dalla mafia e dei mafiosi». «In sostanza nel corso di questi anni, quando io inizio questa impresa da non giornalista, non faccio altro che raccontare quel territorio, quel territorio significa distillerie Bertolino, cioè inquinamento ambientale, significa la figlia di Giuseppe Bertolino, autista di Al
Capone e cognata di Angelo Siino, «ministro dei lavori pubblici» di Totò Riina. Significa raccontare la mafia locale, la famiglia mafiosa dei Vitale, dei Fardazza, significa raccontare, visto che Telejato arriva a Corleone, le famiglie del corleonese».
«Noi non facevamo altro che scendere nel territorio, trovare l'inquinamento della Bertolino, denunciarlo (ovviamente con le immagini, le riprese visive), metterlo in onda, e dalla signora siamo stati omaggiati di ben 200 querele ! Questa è una cosa che non ho mai detto a nessuno: a un giornalista che non ha registrato ma era andato a chiederle come mai tutte queste querele, ha risposto che «oggi si usano le querele, ieri si sarebbero usati altri metodi». Si è fermata alla duecentesima querela perché c’è stata una mia provocazione [...] mi sono spogliato nudo davanti alla Distilleria Bertolino, facendo questa provocazione del “non possiedo più nulla, ti lascio tutto qui, fai quello che vuoi, se vuoi puoi continuare”. Era il 31 dicembre, faceva un po’ freddo».
Pino Maniaci, soffermandosi sulle numerose querele, sottolinea: «[...] le abbiamo vinte tutte» «[...] molte archiviate, [...] ne abbiamo ancora una in sospeso, io non me ne occupo più, perché ho delegato un avvocato che mi segue le 314 querele per la precisione...». Specificando al riguardo che «...114 sono di vari politici e persone comuni».
Il direttore di Telejato ricorda anche le minacce subite: «Nel corso degli anni, presidente, noi abbiamo avuto qualcosa come 40 gomme tagliate, tre macchine bruciate, io ho subìto un'aggressione fisica da parte del figlio del boss Vito Vitale, che ha cercato di strozzarmi con la mia stessa cravatta e sono stato fortunato visto che mio papà mi ha insegnato il doppio nodo che non strozza più di tanto. Mi sono salvato, ma allo stato attuale io porto un busto perché sono stato fracassato dai pugni e tuttora ne porto i segni».
«Le minacce sono state di diverso tipo, anche con lettere intimidatorie, tutte denunciate, oltre che freni tagliati, colpi di pistola nei vetri... Hanno cercato di intimidirmi bruciando anche la macchina di mio figlio, tutte cose denunciate, tanto che dal 2008 ad oggi io sono sotto tutela dei carabinieri, e la Guardia di finanza e la polizia hanno il compito di tutelare sede della televisione e casa».Pag. 33
Significativa anche l'esperienza offerta dalla direttrice di Radio Siani, Amalia De Simone (25): «Io sono una di quelle che hanno subìto negli anni più querele temerarie. [...] È un metodo che viene utilizzato prevalentemente nei confronti dei giornalisti precari, che non hanno tutele. [...] Nel mio caso, per esempio, quando mi è successo, ho dovuto comunque pagarmi l'avvocato e andare a farmi interrogare. Poi magari si chiedeva l'archiviazione e loro facevano opposizione all'archiviazione e quindi si andava in udienza. Ho collezionato una serie di bellissimi «non luogo a procedere», cioè non sono mai arrivata a processo, ma ci sono stati momenti durissimi. Quando queste cose accadono perché tu fai giornalismo d'inchiesta e magari denunci le collusioni tra il mondo economico, quello politico e quello della criminalità organizzata, eccetera, per anni ti devi
difendere da queste cose e soprattutto non hai nessuno che ti tutela alle spalle, a un certo punto ti viene da pensare «ma chi me lo fa fare ?» Questa è la cosa che forse più di tutte mina la libertà di stampa. Oggi come oggi, questo andrebbe rivisto. Questo contratto di lavoro giornalistico siglato recentemente è vergognoso, perché mette da parte i precari, i freelance eccetera».
Il direttore di Ossigeno per l'Informazione, Alberto Spampinato, durante una sua audizione alla Commissione giustizia della Camera dei deputati (26), ha voluto sottolineare come la normativa vigente consenta gravi abusi e forti limitazioni della libertà di stampa e di espressione sancite dall'articolo 21 della Costituzione. Le rilevazioni di Ossigeno per l'informazione affermano che, nel periodo 2011-2014, le querele temerarie e le citazioni per danni infondate hanno rappresentato il 38 per cento degli episodi classificati dall'osservatorio quali atti compiuti a scopo intimidatorio nei confronti degli operatori dei media. Anche in conseguenza delle attuali procedure giudiziarie, le querele e le citazioni per danni hanno sostituito progressivamente – e questo è un fatto negativo – la prassi della richiesta di rettifica.
Il quadro è particolarmente grave ove si consideri – come ricordato da molti auditi – che la stragrande maggioranza dei giornalisti italiani ha rapporti di lavoro precario, compensi estremamente esigui e paga in proprio le spese di difesa legale per i processi di diffamazione.
4. I condizionamenti all'informazione.
4.1) Il giornalismo in terra di camorra.
La senatrice Rosaria Capacchione è stata sentita dal Comitato come giornalista, attualmente sotto protezione, ma ne ha anche fatto parte in quanto senatrice, apportando così un contributo prezioso in Pag. 34termini di esperienza diretta e di conoscenza delle dinamiche professionali (27).
«Sono arrivata al giornale (Il Mattino, ndr) due mesi prima della morte di Giancarlo Siani, che non è un fatto simbolico ma è importante per spiegare anche quale sia stato il ruolo che noi giovani a quell'epoca abbiamo ricoperto. La morte di Giancarlo Siani ha condizionato in qualche modo le nostre vite, ma ha fatto anche da scudo a richieste scandalose che potevano venire da parte dell'azienda o dei direttori. Se ce ne sono state in passato, non riguardano la mia esperienza. Ho cominciato a occuparmi di criminalità organizzata praticamente da subito. Sono stata destinata – allora ero abusiva – alla redazione di Caserta, dove c'erano pochissime persone, tre, diventate con me a tempo pieno, in uno dei tanti periodi delle guerre di camorra. Giocoforza, quindi, pur non avendo io un retroterra di specializzazione su questi temi – mi ero occupata sempre, sostanzialmente, di bianca – sono stata
destinata, come tutti, chiunque passasse in una redazione piccola, a occuparmi di quello che succedeva tutti i giorni: e, nel caso specifico, di omicidi».
Come detto la Capacchione è sotto protezione per una vicenda che ha a che vedere con il clan dei Casalesi, una vicenda particolarmente rilevante perché le minacce contro di lei arrivarono nel corso di una udienza processuale, direttamente per voce di un avvocato difensore del boss della camorra Francesco Bidognetti che la indicò come «una delle responsabili delle disgrazie del clan» insieme ai magistrati Cafiero de Raho e Cantone, e al giornalista Roberto Saviano (per queste minacce l'avvocato, Michele Santonastaso, è stato condannato in primo grado il 9 novembre 2014 a un anno di reclusione dal tribunale di Napoli).
La Capacchione ha offerto alla Commissione un preciso spaccato sulla situazione dell'informazione quotidiana in Campania, sui condizionamenti mafiosi, sui meccanismi di censura e sulle forme di autocensura a cui si sceglie di ricorrere.
«Ritengo, alla luce della mia personale esperienza, che chi ha taciuto, chi ha omesso, chi ha censurato qualcosa, l'ha fatto per scelta sua, non perché gli sia stato imposto da qualcuno, almeno a Il Mattino, al Corriere del Mezzogiorno, a la Repubblica. Se qualcuno ha nascosto qualcosa, l'ha fatto perché voleva nascondere. Non aveva nessuna giustificazione. Posso dire che mai, da Pasquale Nonno fino a Barbano, in quasi trent'anni di direzione del giornale, nessuno è venuto a dirmi che non dovevo scrivere qualcosa o dovevo scriverla di meno. È successo il contrario. Nel 2002, mentre mi occupavo sempre di faccende che riguardavano Francesco Schiavone (il capo del clan dei casalesi, ndr), che si rischiava fosse scarcerato da un momento all'altro, ricevetti un'intimidazione piuttosto brutta che riguardava la mia famiglia: chiesi, al terzo servizio che facevo sull'argomento, se potesse occuparsene anche qualche altro e mi
fu risposto che ero pazza, che non potevo abbassare la testa, che non se ne parlava proprio, che il giornale stava con me, punto e basta. Siccome questo è successo a me, in un giornale spesso tacciato per essere organo istituzionale, paraistituzionale, giornale dei Pag. 35potenti e così via, posso dire che non è vero. Se qualcuno ha voluto fare finta di non vedere o di non sentire, è una scelta personale e non del giornale».
Diversa la situazione in alcuni giornali della provincia di Caserta, spesso protagonisti di campagne di discredito nei confronti dei soggetti più esposti nella lotta contro la camorra, o utilizzati persino per inviare messaggi trasversali da parte di esponenti della camorra. Ricorda la senatrice Capacchione: «Purtroppo, in Campania – ho visto che succede anche in altre regioni – soprattutto in provincia, in aree sensibili come quella del clan dei casalesi, nel 1995, proprio in concomitanza con il blitz di Spartacus, sono arrivati degli avventurieri, che non so come altro definire – potrei, in realtà, definirli in un altro modo, delinquenti – che hanno fatto del ricatto a mezzo stampa il loro modo di vivere. Non sto usando il termine in modo casuale. Maurizio Clemente, l'editore di uno di questi giornali, che nel frattempo ha cambiato nome (il Corriere di Caserta, diventato poi Cronache di
Caserta, ndr), è stato arrestato e condannato in primo grado (a otto anni e sei mesi di reclusione dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ndr) proprio per estorsione a mezzo stampa.
Come in tutti i casi di ricatto, di estorsione, c’è un piccolo fondamento di verità, che non è tutta la verità, utilizzata per spaventare qualcuno lasciando intravedere sviluppi successivi. Il fine è ottenere soldi.
Questi sono gli stessi giornali, quello che allora si chiamava Corriere di Caserta e adesso si chiama Cronache, e la Gazzetta di Caserta, che nascono dalla stessa proprietà, che poi si è scissa, con l'appoggio esterno di qualche testata on line che fa da sponda ora all'uno ora all'altro. [...] In un caso, la Gazzetta di Caserta pubblicò la lettera che gli era stata spedita da Francesco Schiavone, all'epoca capo del clan dei casalesi, che si congratulava con il direttore per quanto fosse bello quel giornale, lettera pubblicata in prima pagina, con l'indicazione che quel giornale gli piaceva più dell'altro, cioè del Corriere di Caserta, e che quindi avrebbe detto a tutti i suoi amici di cambiare giornale. In effetti, la DDA accertò che da un giorno all'altro ci fu un passaggio di 2.000 copie da una testata all'altra».
Per capire il ruolo svolto da questi giornali è importante rilevare come sia il tribunale di Santa Maria Capua Vetere che alcune sezioni del tribunale di Napoli hanno vietato con decreto che nelle carceri i detenuti al 41-bis del clan dei casalesi e del clan Belforte di Marcianise potessero ricevere in cella questi giornali, evidentemente ritenendoli un possibile tramite di messaggi dall'esterno verso le carceri.
«Alla fine, quando in aula di tribunale – sto parlando di udienze pubbliche – eravamo io, quello del Corriere di Caserta e quello della Gazzetta di Caserta, e io ero l'unica poi a scrivere, si rafforzava l'idea che ci fosse il giornalista bravo e quello cattivo. È bravo chi non scrive quello che non conviene; è cattivo quello che, invece, scrive anche cose che non dovrebbe, pur trattandosi di un'udienza pubblica. Non sto parlando, quindi, di cose scoperte in maniera avventurosa o di lavoro investigativo, ma di banalissima cronaca. È chiaro che questa situazione mette in difficoltà».Pag. 36
L'opacità della gestione, il coinvolgimento di direttori ed editori in indagini giudiziarie, sono spesso stati segnalati anche all'Ordine dei giornalisti, ma non risultano prese di posizione efficaci, neppure per evitare il ricorso a fenomeni distorsivi come la disoccupazione fittizia e il mancato rispetto delle regole contrattuali. Afferma la senatrice Capacchione: «La Gazzetta di Caserta faceva un ricorso palese alla disoccupazione fittizia, con un meccanismo piuttosto collaudato di far licenziare le persone con l'impegno di riassumerle di lì a sei mesi. Prendevano l'accesso alla disoccupazione continuando a far lavorare in nero. Io lo so per certo perché l'ho segnalata numerose volte sia all'Istituto di previdenza, sia all'Associazione sia all'Ordine, ma non mi risulta che siano stati fatti interventi in questa direzione. Sostanzialmente, abbiamo pagato noi un giornale che ha utilizzato la disoccupazione in
questa maniera e ha goduto di contributi pubblici».
Quanto agli attacchi personali subiti, la senatrice Capacchione riporta che ci sono state prese di posizione a sua difesa, soprattutto dopo che la sua vicenda ha avuto maggiore risonanza, ma mai – secondo quanto ha riferito la stessa audita – interventi per distinguere tra chi esercitava un legittimo diritto di cronaca e di critica e chi, molto più semplicemente, orchestrava una campagna di discredito.
«Per diversi anni, prima l'uno poi l'altro giornale mi hanno personalmente fatta segno di attacchi molto violenti, ben al di là della critica. Più volte ho chiesto all'Ordine regionale di intervenire, anche cercando di farmi spiegare chi fosse il giornalista, se io o l'altro, perché la convivenza nello stesso ordine era impossibile. Non ho mai avuto risposte».
A prescindere dalla propria vicenda, molto critiche le considerazioni della senatrice Capacchione sull'Ordine dei giornalisti e sulla sua capacità di intervento e di tutela della professione.
«L'Ordine dei giornalisti non è uguale ovunque. Così com’è, in alcune regioni non serve a niente. [...] Penso, invece, che l'unico modo per arginare queste derive sia una riforma dell'Ordine di effettivo controllo e vigilanza sulla qualità del lavoro giornalistico. Non può essere demandato alla legge o a una causa. C’è bisogno di una tempestività e anche di una conoscenza tecnica del mestiere che il magistrato non ha. L'Ordine, invece, andrebbe riformato per una verifica effettiva, dovrebbe essere una specie di tribunale, di giurì, su questi temi, ma in maniera tassativa, altrimenti viene meno proprio la funzione del giornalista».
Ed ancora, sul segreto professionale: «Si è esteso il segreto professionale anche ai pubblicisti. In linea di principio, è giusto; in linea pratica, significa aver consegnato il segreto professionale a un numero imprecisato di persone che nella vita fanno di tutto tranne che i giornalisti».
Proprio al Corriere di Caserta e alle capacità di condizionamento che riesce ad esercitare la camorra sull'informazione si riferisce una recente sentenza pronunciata il 28 novembre 2014 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La sentenza, non ancora definitiva, ha condannato a due anni di reclusione per violenza privata con l'aggravante camorristica Francesco Cascella, nipote acquisito del capo Pag. 37camorra di Pignataro Maggiore, Vincenzo Lubrano. Nel 2003, documenta la sentenza, Cascella si sarebbe adoperato – per conto dello zio – per far licenziare dal Corriere di Caserta il giornalista Enzo Palmesano, ritenuto scomodo agli interessi di quel clan. Fatto grave, soprattutto se si pensa che in altri casi, proprio su quel territorio, il «fastidio» di un boss per gli articoli di un giornalista si era manifestato non con la pretesa di un
licenziamento ma direttamente con l'omicidio di quel cronista: Giancarlo Siani, assassinato il 23 settembre 1985 per ordine dei Nuvoletta.
Sulla situazione del giornalismo in Campania, e segnatamente sul rischio che la camorra riesca a condizionare la qualità dell'informazione, il direttore del Corriere del Mezzogiorno Antonio Polito (28), ascoltato in audizione, ha osservato che: «C’è stata, contemporaneamente, una crisi delle organizzazioni editoriali tradizionali, cioè quelle gerarchizzate... un direttore, un vicedirettore, un redattore capo, avvocati a cui rivolgersi in caso di bisogno. Oggi aprire un blog, una radio locale, una televisione locale è la cosa più facile al mondo. Può farlo chiunque, figuratevi se non può farlo un potere criminale più o meno forte. Dal punto di vista industriale, quindi, la possibilità è molto maggiore. [...] Aggiungo che anche dal punto di vista culturale il fatto che la società meridionale, non dappertutto ma soprattutto in alcune zone,
è intrisa di rapporti con l'illegalità rende perfino esistente un mercato giornalistico editoriale per questo tipo di informazioni. Immagino che andremo sempre più verso forme di informazione dedicate a una nicchia: la società camorristica è una nicchia di un certo peso nella realtà sociale del nostro Mezzogiorno. Oggi, alcuni comportamenti mafiosi sono addirittura dei modelli sociali. È fuori discussione che, per esempio, nella città, nella zona di Napoli la subcultura camorristica abbia penetrato il mainstream culturale».
Sul ruolo dell'Ordine, il direttore Polito ha ripreso la stessa analisi proposta dalla senatrice Capacchione: «È chiaro che di fronte a questa realtà così magmatica, in cui l'informazione è fatta sempre più da non professionisti, non giornalisti, non iscritti all'ordine, non pubblicisti – oggi, veramente chiunque può andare su Internet e fare quello che vuole, aprire una radio e così via – si dimostra l'anacronismo dell'Ordine che non copre neanche lontanamente questa realtà. Non si può chiedergli di fare il poliziotto dell'informazione in senso lato. Non credo che ne abbia i mezzi».
Meno preoccupata la lettura che ha proposto in audizione il direttore de il Mattino, Alessandro Barbano (29). «Non esistono poteri a Napoli, in Campania, che hanno la forza condizionante dei poteri del passato. Nessun potere criminale oggi a Napoli, per fortuna, ha una strategia che passi per un progetto di condizionamento della comunicazione, almeno dalla mia esperienza. Mi auguro di non sbagliare, perché magari domani mi accorgerò che non è così. [...] In questo quadro di grande frammentazione si inseriscono probabilmente queste Pag. 38piccole contaminazioni che riguardano il giornalismo che lei ha citato, che però camminano a un livello sottostante, di cui noi abbiamo effettivamente dei segnali. Ovviamente, ci sono giornali interamente strutturati sulla comunicazione criminale, nel bene e nel male. Faccio fatica a
individuare quanta di quella parte sia diritto di cronaca e dovere di cronaca e quanto sia, invece, messaggio: ma c’è».
Sull'insieme delle vicende analizzate, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli (30), audito dal Comitato, ha voluto premettere i disagi del ruolo particolarmente impegnativo che, in quella regione, l'Ordine è stato costretto ad assumere: «Caso unico nella storia del giornalismo campano, infatti, in Campania non c’è più un sindacato, nel senso che l'Associazione napoletana della stampa è stata radiata dalla FNSI, è fallita, quindi ci troviamo ormai da quasi un anno senza sindacato per una questione che riguarda la gestione dell'allora Circolo della stampa di Napoli».
Sul caso della Gazzetta di Caserta il giudizio del presidente Lucarelli è articolato: «Abbiamo dovuto aprire negli anni una serie di procedimenti disciplinari e non è stato neanche facile farlo. Quando sono diventato presidente, il direttore era un signore che credo avesse intorno ai 90 anni, che quindi non era neanche facile convocare. In realtà, era il figlio di questo direttore, il vero organizzatore del giornale. Per questo non siamo mai riusciti a fare un'audizione. [...] Su questo giornale bisogna però dire una cosa. Io conosco i redattori uno per uno. Alcuni di questi sono figli di professori universitari, di professionisti... Non mi è piaciuto quando in alcuni casi si è generalizzato su tutta la redazione. [...] È un giornale che vende molto nei territori di frontiera. Ora, qual è il confine tra fare una cronaca quasi porta a porta, strada per strada, di questi territori di camorra e
sostenere che quelli siano giornali di camorra, quasi bollettini ? [...] È verissimo che nelle tane di alcuni boss, quando sono stati stanati, sono state trovate copie di Cronache di Napoli, di Cronache di Caserta, ma che siano i bollettini della camorra, che, addirittura, come è stato detto in alcuni casi, siano utilizzati per mandare segnali e messaggi trasversali, può darsi, ma va provato. Quando parliamo di Cronache di Caserta e Cronache di Napoli, o di Corriere di Caserta e Cronache di Napoli, parliamo anche di una giornalista professionista, Tina Palomba, anche lei minacciata. Lavorare in questi giornali è certamente più difficile che lavorare nella redazione di Napoli di la Repubblica, nel Corriere del Mezzogiorno o nella redazione RAI di Napoli».
«Quando affrontiamo la questione di questi giornali di frontiera, quindi, dobbiamo affrontare il doppio aspetto. Sicuramente, c’è un editore che ha avuto una condanna per estorsione a mezzo stampa. Quando, però, parliamo di singoli giornalisti, dobbiamo affrontare la questione con molta cautela e, soprattutto, va provato se siano dei bollettini. Fino a oggi, non è stato provato. [...] Quando Saviano fece un durissimo attacco qualche anno fa, dicendo che il Corriere di Caserta era il giornale della camorra, intervenni a difesa della redazione e feci una dichiarazione in cui dissi che nella redazione del Corriere di Caserta lavoravano giornalisti perbene».
4.2) L'informazione in Sicilia.
Ha ricordato Francesco La Licata, nell'intervista raccolta dall'ultimo rapporto dell'osservatorio Ossigeno per l'informazione, che «...la sofferenza della Sicilia sul piano della produzione editoriale riguarda soprattutto il fatto che l'intero territorio siciliano, per decenni, è stato in mano a un duopolio che si è diviso il territorio. Da un lato Ciancio per Catania e la Sicilia orientale con il quotidiano La Sicilia, dall'altro gli Ardizzone con il Giornale di Sicilia. Il terzo incomodo era la Rai, che però già allora si presentava imbrigliata dalla funzione di servizio pubblico e proprio in quanto tale era fortemente condizionata dalle forze politiche locali».
Aggiungiamo, tra le condizioni non risolte dell'informazione in Sicilia, il fatto che i due principali quotidiani, La Sicilia e il Giornale di Sicilia, conoscono, ormai da lunghissimo tempo, l'identificazione della figura del direttore politico con quella dell'editore, con una sovrapposizione di funzioni, responsabilità e interessi che non sempre risulta d'aiuto alla qualità dell'informazione.
Naturalmente questo non può diventare un giudizio che liquida anche la funzione positiva che questi giornali hanno svolto nella lotta alla mafia e la ricchezza d'impegno giornalistico e di apertura alla società civile che hanno rappresentato.
Sull'informazione in Sicilia e sui suoi due principali quotidiani il Comitato ha raccolto – attraverso le numerose audizioni e gli atti giudiziari acquisiti – un quadro complesso, con ombre e luci, di cui la relazione dà qui ampio conto. Un'indagine che nulla toglie alla professionalità dei tanti giornalisti che lavorano in quelle redazioni e che hanno continuato a operare con assoluto rigore professionale, a prescindere dalle vicende giudiziarie dei loro editori.
L'impegno civile dei giornalisti siciliani è peraltro ampiamento documentato (ed è stato dolorosamente pagato) dal numero di colleghi uccisi dalla mafia dal dopoguerra ad oggi: ben otto ! Due di loro lavoravano proprio per i due più importanti giornali dell'isola: Mario Francese cronista di giudiziaria al Giornale di Sicilia e Beppe Alfano corrispondente da Barcellona Pozzo di Gotto per La Sicilia.
Di grande lucidità in tal senso il contributo di Nino Milazzo, vicedirettore del Corriere della Sera e, per un breve periodo, condirettore responsabile de La Sicilia di Catania. «Ritengo che la categoria abbia fatto passi avanti nella consapevolezza del pericolo che si chiama mafia – ha detto Milazzo nel corso della sua audizione – Questo vale soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia. Se penso alla vicenda dell'uccisione di Giuseppe Fava, che venne intesa come un delitto passionale, con un'interpretazione fasulla, leggera e assolutamente arbitraria, penso che i progressi siano stati enormi. Oggi nessuno oserebbe incorrere in un infortunio di questa portata. Anche sul piano editoriale c’è stato un certo progresso. Prima vigeva la legge dell'omissione o della falsificazione. Credo che almeno uno di questi due peccati dell'informazione, quello dell'omissione, soprattutto al sud, sia scomparso.
Nessuno osa nascondere quello che è visibile a tutti. Sull'obiettività, non mi spingo fino al concetto di falsificazione dei fatti, ma permane una certa reticenza e un certo atteggiamento negativo» (31).
4.2.1) Mario Ciancio e il sistema di potere mafioso a Catania.
Mario Ciancio, presidente della FIEG dal 1996 al 2001, poi vicepresidente (e attualmente nel consiglio di amministrazione) dell'ANSA, è certamente l'editore più affermato del Mezzogiorno. Negli ultimi trent'anni è stato capace di costruire un perimetro di interessi imprenditoriali che ben presto sono tracimati fuori dall'informazione per estendersi a molti altri settori: dall'edilizia pubblica e privata all'agricoltura, dal mercato pubblicitario ai servizi turistici (32).
Per i molti spunti offerti al Comitato nel corso delle audizioni e soprattutto per la vicenda giudiziaria che lo vede oggi protagonista, il caso di Mario Ciancio, editore e direttore del quotidiano La Sicilia e proprietario, per quota o del tutto, di molte altre testate giornalistiche non solo siciliane (emittenti televisive, radiofoniche e su carta (33)), è stato uno dei focus di questa relazione.
Invitato dalla Commissione antimafia per essere ascoltato in audizione il 15 marzo 2015, Ciancio ha rappresentato, per il tramite del suo legale, che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in quanto gli argomenti che si sarebbero trattati erano parte dell'inchiesta che lo vede imputato di concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati.
Un primo preoccupato giudizio sulla natura delle relazioni intrattenute dall'editore Mario Ciancio era stato già anticipato nelle motivazioni della sentenza di condanna a sei anni e otto mesi di reclusione nei confronti dell'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza, emessa il 19 febbraio del 2014 dal Gup di Catania Marina Rizza, si sofferma sul modus operandi dell'organizzazione mafiosa (34).
Il 1o aprile 2015 la procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio di Mario Ciancio per concorso esterno di associazione a delinquere di stampo mafioso. «Ciancio – recita l'avviso di chiusura delle indagini – metteva a disposizione dell'organizzazione criminale la propria attività economica, finanziaria e imprenditoriale avente ad Pag. 41oggetto, tra l'altro, l'editoria, l'emittenza televisiva, la proprietà fondiaria e l'attività edilizia, centri commerciali, centri turistici, aeroporti, posteggi ed altre lottizzazioni». Mario Ciancio avrebbe promosso «affari di interesse dell'associazione mafiosa, anche mediando con soggetti politici e della pubblica amministrazione», avrebbe costituito «società a cui faceva partecipare persone legate all'organizzazione criminale» e partecipato
«alla distribuzione di lavori controllati direttamente o indirettamente dall'organizzazione mafiosa». E ancora, Ciancio avrebbe affidato «lavori per la realizzazione di progetti o affari da lui promossi ad imprese mafiose o ad imprese a disposizione della medesima associazione mafiosa». Nell'avviso di conclusione delle indagini la procura sottolinea infine che «la contestazione si fonda sulla ricostruzione di una serie di vicende che iniziano negli anni 70 e si protraggono nel tempo fino ad anni recenti» e «riguardano partecipazione ad iniziative imprenditoriali nelle quali risultano coinvolti forti interessi riconducibili all'organizzazione cosa nostra».
Sulle relazioni di Ciancio, questa è la ricostruzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, contenuta nella rogatoria presentata alle autorità elvetiche il 20 ottobre 2014 per l'acquisizione di informazioni e documenti su conti dell'editore catanese presso banche svizzere:
«Le fonti probatorie raccolte in questo procedimento permettono di sostenere che Ciancio Sanfilippo Mario ha avuto, nel tempo, rapporti, a volte commerciali ed a volte di diversa natura, con persone legate a cosa nostra. Quanto ai rapporti "commerciali", Ciancio Sanfilippo – tra l'altro – risulta:
essere stato socio negli anni ’80 della famiglia RAPPA di Palermo per la gestione delle prime televisioni locali, le cui frequenze poi cedeva alla società Fininvest di Silvio Berlusconi; i Rappa sono imprenditori di Palermo, il cui capostipite è stato condannato per essere capo della famiglia mafiosa di Borghetto, mentre i figli – accusati di avere partecipato al "tavolino" di Siino Angelo – sono stati assolti per insufficienza di prove;
essere stato socio e, comunque, in rapporti commerciali con i cosiddetti cavalieri del lavoro di Catania, ed in particolare con i Costanzo;
più recentemente, dai primi anni 2000, lo stesso Ciancio si è interessato dell’ affare avente ad oggetto la progettazione e costruzione di un centro commerciale a Catania (denominato Porte di Catania e noto anche come Il Pigno) su terreni di sua proprietà; lo stesso stipulava contratti di cessione dei terreni, assicurando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative regionali e comunali, con la società ICOM srl, di cui diventava anche socio nel 2005. Nella compagine sociale della Icom risultano presenti anche:
Vizzini Giovanni, fratello di Vizzini Carlo, quest'ultimo senatore in Parlamento; la figlia di Vizzini Giovanni, Vizzini Maria Sole, è sposata con Rappa Vincenzo del 1973 (vedi punto che precede);
Mercadante Tommaso, nipote di Tommaso Cannella (boss di cosa nostra di Palermo) e figlio di Mercadante Giovanni (primario di Pag. 42ospedale, onorevole regionale e recentemente condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione di stampo mafioso).
Si deve aggiungere che la realizzazione del centro commerciale è stato appaltato ad imprese mafiose, come la INCOTER di Basilotta Vincenzo, oggi confiscate in primo grado dal tribunale di prevenzione di Catania.
Inoltre sono state registrate delle conversazioni ambientali da cui emerge un inequivocabile interesse del rappresentante provinciale di cosa nostra catanese, Aiello Vincenzo, per somme di denaro proveniente dall'affare del "Pigno" e in particolare per una somma di 600 mila euro che doveva essere consegnata a cosa nostra catanese e che, con l'autorizzazione di cosa nostra catanese, è stata pagata a Raffaele Lombardo, politico che si era interessato dell'iniziativa del centro commerciale su richiesta dello stesso Ciancio.
Avere promosso e organizzato la creazione di un altro imponente parco commerciale nel centro della Sicilia (Sicily Outlet). Anche per tale vicenda l'interesse del Ciancio non risiede solo nella trasformazione della destinazione dei terreni di sua proprietà da agricoli a commerciali (speculazione), ma anche nel divenire socio della società che promuoveva l'affare e costruiva l'imponente parco commerciale. Si è accertato non solo che risultano soci nell'affare le persone già indicate per «Il Pigno», ma anche che i lavori per la costruzione dell'opera sono stati affidati a imprese mafiose gravitanti su cosa nostra di Catania.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni di questi hanno dichiarato che Ciancio era, già dalla fine degli anni ’70, «vicino» all'organizzazione mafiosa di Catania, riferendo – ad esempio – di rapporti tra l'organizzazione e Ciancio per ottenere una linea editoriale che non pregiudicasse gli interessi o le attività di alcune imprese mafiose (35).»
La rogatoria punta a ricostruire l'esatta entità del patrimonio trasferito all'estero da Mario Ciancio nel corso degli anni. Ciancio oggi è chiamato a spiegare – tra l'altro – l'origine di 52 milioni e 600 mila euro depositati su conti correnti in Svizzera e in altri Paesi, e mai dichiarati, neppure in parte, negli scudi fiscali di cui l'editore catanese si era invece avvalso in passato. Di questi 52 milioni non vi sono tracce nelle precedenti dichiarazioni né – a giudizio della procura – spiegazioni attendibili sulla loro provenienza.
Il 17 giugno 2015 il tribunale per le misure di prevenzione di Catania ha intanto accolto la richiesta della DDA di Catania ed ha affidato ai militari del ROS il sequestro, in applicazione delle norme antimafia, di dodici dei 52 milioni di euro detenuti all'estero da Mario Pag. 43Ciancio e di altri cinque milioni di euro detenuti su un conto bancario a Catania.
A prescindere dall'esito di questo procedimento penale (la prima udienza davanti al GUP si è svolta il 18 giugno 2015), il Comitato ha ricostruito – attraverso più audizioni e l'acquisizione degli atti giudiziari dalla procura di Catania – alcuni episodi di comportamento deontologicamente non corretto dell'editore del quotidiano La Sicilia nei confronti di talune famiglie mafiose locali e i condizionamenti complessivi che ne sono derivati all'informazione.
Una prima vicenda, relativa al boss di cosa nostra Giuseppe Ercolano, è stata ripresa da diversi auditi, oltre ad essere rievocata nella recente richiesta di rinvio a giudizio della procura di Catania.
Valter Rizzo, nel corso della sua audizione sulla vicenda Telecolor (ne parliamo in altra parte di questa relazione), ha ricordato: «Ci sono stati dei casi eclatanti. Il primo fu la vicenda del pesante intervento di Ciancio nei confronti di un giovane redattore del suo giornale, Concetto Mannisi, che alla presenza di uno dei capi di cosa nostra catanese, Giuseppe Ercolano, fu pesantemente redarguito da Ciancio che gli disse «tu non devi più nominare questa persona come boss mafioso anche se te lo dovessero dire i carabinieri !». Chiaramente l'azione fu assolutamente intimidatoria e venne fatta di concerto con la volontà del capomafia (Giuseppe Ercolano che era presente all'incontro fra Ciancio e Mannisi, ndr.). Questa vicenda era rimasta sepolta fino a quando non venne tirata fuori da una nostra collega, Ada Mollica, e poi ripresa sui giornali nazionali e su altri organi di stampa, finché divenne un
caso particolarmente eclatante e venne addirittura portato all'interno del maxiprocesso Orsa Maggiore. Va detto che né Ciancio né Mannisi hanno mai denunciato il fatto fino a quando non vennero chiamati a testimoniare, e Mannisi confermò quello che era successo mentre Ciancio addirittura negò di avere conosciuto Ercolano, dichiarando di averlo incontrato soltanto una volta in aereo.»
L'episodio è stato confermato e censurato dalla procura di Catania, come risulta dagli atti dell'inchiesta della DDA denominata Orsa Maggiore: «Tra i numerosi episodi esaminati nel procedimento val la pena di segnalare quello relativo alle pressioni esercitate sulla stampa che si caratterizza per il fatto di essere emblematico della succubanza in cui la società civile ha vissuto e vive al cospetto della protervia della "famiglia" mafiosa. È accaduto infatti che Giuseppe Ercolano, cognato di Nitto Santapaola e padre di Aldo, abbia richiesto al direttore di un giornale locale di contestare in una sua presenza ad un giornalista dello stesso giornale il contenuto di un articolo pubblicato qualche giorno prima (il 24 ottobre 1993, ndr) in merito ai controlli effettuati dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri all'interno dell'Avimec (azienda dell'Ercolano, ndr). Orbene, in presenza dell'Ercolano, il direttore del giornale
contestava al giornalista il tono non imparziale del suo articolo ed invitava il medesimo, per il futuro, a non attribuire l'appellativo di boss mafioso all'Ercolano e gli altri componenti della sua famiglia, anche se tali affermazioni provenissero da fonti della Polizia e dei carabinieri».
La vicenda verrà ricostruita anni dopo anche nella dettagliata testimonianza del collaboratore di giustizia Angelo Siino, che aveva accompagnato l'Ercolano nella redazione de La Sicilia: «Pippo Ercolano Pag. 44entrò in redazione, mostrando di ben conoscere i luoghi, gridando che voleva parlare con i due giornalisti autori dell'articolo. In redazione, alla presenza di altre persone, Pippo Ercolano gridava e i due giornalisti cercavano di giustificarsi. Io – su mandato di Aldo Ercolano – cercai di tranquillizzare Pippo Ercolano, riuscendovi dopo non pochi sforzi. Questo episodio determinò la reazione di esponenti di vertice del gruppo Santapaola. [...] Tra le lamentele che venivano fatte quando fui chiamato a riferire sul comportamento dell'Ercolano, ricordo che i vertici dell'associazione ai quali rispondevo, lamentavano – tra l'altro –
che era inconcepibile che l'Ercolano avesse fatto quella scenata assolutamente in contrasto con le "attenzioni" che loro riservavano al Ciancio Sanfilippo» (36).
Vanno menzionati gli sviluppi dell'episodio, contenuti nel rapporto trasmesso dal GICO alla DDA di Catania. Il 29 dicembre 1993, avendo appreso di un'informativa dei carabinieri sull'episodio, La Sicilia si premura di pubblicare un trafiletto dal titolo «Nessuna pressione sul nostro giornale». La direzione, nell'articolo, «respinge indignata le illazioni» ma conferma sostanzialmente l'episodio: «Il signor Giuseppe Ercolano è venuto al giornale, ricevuto dal direttore e dal capocronista, lamentando che in occasione della pubblicazione di un articolo, ove venivano citate una ventina di ditte denunziate per la violazione della legge antinquinamento, solo accanto al suo nome era stata fatta la specifica “noto boss mafioso”. Il signor Giuseppe Ercolano ha fatto presente in tale occasione di essere regolarmente titolare della ditta Avimec con centinaia di dipendenti e che in momento
era un libero cittadino. Direttore e capocronista hanno spiegato che la notizia e il particolare che lo riguardava – come confermato dal cronista che si era occupato del servizio – erano stati fatti dai carabinieri. In tale occasione il signor Ercolano non ha esercitato pressioni di alcun genere».
La mattina del 30 dicembre il direttore Ciancio, convocato in procura, minimizzerà sull'incontro con l'Ercolano: «Il tono era comunque scherzoso».
Spiegherà poi Mannisi, escusso come teste il 27 febbraio 1996 nel dibattimento per il processo Orsa Maggiore: «Mi fu detto che avevo creato danni all'attività del signor Ercolano scrivendo... avendogli dato, diciamo, del mafioso. [...] mi fu detto che secondo quella che era la prassi normale, visto che si trattava di un pezzo legato alle violazioni ambientali e non un pezzo specifico sulla mafia catanese, era quasi superfluo o comunque non era proprio corretto puntualizzare che il titolare della ditta Avimec in questione fosse il massimo esponente della nota famiglia sospettata di mafia. [...] Mi fu detto dal direttore che se lo diceva il Ministro dell'interno che il signor Ercolano era mafioso si poteva scrivere. Noi non... non era nostro compito dire che l'Ercolano fosse mafioso».
È utile infine ricordare la coda polemica, riferita da Rizzo in audizione, che la vicenda ebbe davanti all'Ordine dei giornalisti della Sicilia: «Un anno e mezzo fa ho pubblicato un pezzo sul mio blog in cui parlavo della morte di Giuseppe Ercolano. In questo articolo riferivo un fatto ormai storico, quello del famoso “cazziatone” al collega Pag. 45Mannisi [...]. Quando riporto questa cosa vengo convocato dal consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia che mi chiede conto e ragione del perché mi sono permesso di andare a dire questa cosa che chiaramente mette in cattiva luce un collega. Da notare che il consiglio di disciplina e, prima, il consiglio dell'Ordine dei giornalisti – che era competente in materia di disciplina – non hanno mai convocato Mario Ciancio per questo episodio o per altri episodi come quello della pubblicazione
della lettera del figlio di Nitto Santapaola messa come un normalissimo editoriale nel giornale, oppure il rifiuto di pubblicare i necrologi di alcune vittime della mafia, o ancora la vicenda del depistaggio sul pentito Avola.».
Sulla vicenda, il Comitato ha ascoltato anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Riccardo Arena. Questi i passaggi più significativi della sua audizione:
«RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. Non mi nascondo dietro un dito dicendo che, nel periodo in cui emerse la vicenda, nessun consiglio dell'ordine ebbe mai a chiedere e a chiamare Mario Ciancio perché desse chiarimenti su questo.
PRESIDENTE. Non le sembra strano che su questa vicenda ci sia stato invece un approfondimento, prima del consiglio dell'ordine e poi del consiglio di disciplina, nei confronti del collega che è stato audito anche da questa Commissione, Valter Rizzo, per avere scritto di quest'episodio ? Si è intervenuti in forma disciplinare nei confronti di un giornalista che aveva raccontato quest'episodio, senza essere mai intervenuti nei confronti del protagonista di quest'episodio, Mario Ciancio.
RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. Credo che si siano limitati soltanto a chiedergli dei chiarimenti sul fatto. Poiché loro agiscono autonomamente e separatamente da noi, non sono informato dell'esito della vicenda. Credo che il collega abbia fornito i suoi chiarimenti. Per quel che riguarda l'episodio di partenza, ripeto che osta una serie di impedimenti che hanno a che vedere col lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti.
PRESIDENTE. È, però, un elemento ostativo che non ha impedito di convocare per una possibile azione disciplinare un collega che questa vicenda l'aveva raccontata.
RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. Ma l'ha raccontata recentemente. E per questo è stato convocato...».
Va registrato che il 18 giugno 2015, nel corso della succitata udienza preliminare nei confronti di Mario Ciancio davanti al GUP di Catania, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia ha presentato la richiesta di costituzione di parte civile. «Tale scelta, operata nell'assoluto rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza Pag. 46– si legge in un comunicato- mira a tutelare la categoria dei giornalisti siciliani, il decoro e il prestigio dell'Ordine e la dignità personale e professionale dei dipendenti della Sicilia e del gruppo editoriale guidato da Ciancio, fortemente lesi dalle gravissime imputazioni addebitate al loro direttore-editore. Questo perché i direttori dei quotidiani hanno un fondamentale ruolo di garanzia e di cerniera tra l'Ordine e gli iscritti, nell'ottica e con l'obiettivo del rispetto delle norme di legge,
deontologiche, disciplinari e contrattuali» (37).
Altro episodio significativo, una lunga lettera pubblicata ad un componente della famiglia Santapaola su La Sicilia. Il 9 ottobre 2008 il quotidiano catanese pubblica in cronaca – senza tagli al testo né alcun commento – una lettera di Vincenzo Santapaola, trentotto anni, figlio del boss Nitto, come il padre condannato e detenuto nel regime del 41 bis. Il titolo: «Contro di me pregiudizi perché porto un nome pesante». «Egregio direttore, mi trovo in un carcere di massima sicurezza al 41-bis e da unduci anni giro varie prigioni in attesa di processi perché porto un cognome pesante, discusso, odioso e chiacchierato. I mass media mi indicano come un mafioso, l’ erede di mio padre». La lettera di Santapaola si conclude con un finale denso di messaggi da interpretare: «Personaggi a me ignoti continuano a presentare il mio cognome come etichetta, la cui natura non mi
appartiene. [...] Non ho, non abbiamo nulla da spartire con chiunque pretenda di usare il nostro nome subdolamente».
Il giorno dopo, in una nota ufficiale, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica «...che sono in corso gli opportuni accertamenti per verificare con quali modalità sia stato possibile che la lettera di una persona detenuta al 41 bis sia stata pubblicata sul quotidiano». Ma l'indagine interna del DAP non avrà alcun esito.
Il giornale di Mario Ciancio, dal canto suo, si difende sostenendo che la pubblicazione della lettera era stata autorizzata dal Gip di Catania. Interverrà personalmente, il 17 ottobre, il presidente dell'ufficio Gip, Rodolfo Materia, per smentire formalmente La Sicilia: «Nessun giudice ha autorizzato l'invio della lettera di Santapaola. La notizia così pubblicata risulta gravemente lesiva della dignità e professionalità dei magistrati dell'ufficio Gip di Catania. Nessuno dei magistrati del mio ufficio ha mai autorizzato l'invio di qualsiasi missiva di Santapaola Vincenzo».
Lettere pubblicate ai mafiosi e necrologi negati ai familiari delle vittime di mafia. Nell'ottobre del 1985, ricorrendo il terzo trigesimo dell'omicidio del commissario Beppe Montana, il padre Luigi Montana si vide respingere il necrologio presentato allo sportello del giornale La Sicilia «su disposizione del vice direttore Corigliano e del direttore Mario Ciancio», come risulta in calce al testo del necrologio.
La spiegazione del quotidiano catanese venne affidata all'inviato Tony Zermo: il necrologio in ricordo di Beppe Montana – scrisse Zermo – era stato rifiutato perché «il testo parlava di un delitto di mafia dagli alti mandanti». In realtà il testo del ricordo funebre di un uomo dello Stato ucciso da cosa nostra diceva semplicemente: «La famiglia con rabbioso rimpianto ricorda alla collettività il sacrificio di Beppe Montana, commissario P.S. Rinnovando ogni disprezzo at mafia et suoi anonimi sostenitori».Pag. 47
Anni dopo La Sicilia non mostrerà gli stessi scrupoli quando – il 30 luglio 2012, il giorno dopo la morte del capomafia Giuseppe Ercolano (lo stesso ricevuto da Ciancio nel suo ufficio in occasione della reprimenda verso il suo cronista) – il giornale pubblicherà ben tre necrologi di amici e parenti che ricordano l'Ercolano, compreso il figlio Aldo, oggi all'ergastolo in qualità di autore materiale dell'omicidio del giornalista Giuseppe Fava.
«Un altro episodio particolare fu quello che riguardò l'inizio della collaborazione di Maurizio Avola» ha ricostruito Valter Rizzo durante la sua audizione. «Maurizio Avola è stato uno dei più importanti collaboratori di giustizia catanesi, uno di quelli che hanno permesso di istruire il maxiprocesso e anche il processo per l'assassinio di Giuseppe Fava. Proprio all'inizio della collaborazione apparve una serie di articoli su La Sicilia e su Il Giorno, che miravano palesemente a screditare la credibilità di questo collaboratore di giustizia».
La Sicilia scrive infatti che Avola si è autoaccusato di essere «il killer di dalla Chiesa e di Fava», ma all'epoca del primo delitto in realtà «Avola aveva appena ventuno anni e, dunque, non sarebbe credibile». l'articolo de La Sicilia fu smentito la mattina dopo dal sostituto procuratore Amedeo Bertone della DDA di Catania: «Si sta cercando di fare passare Avola come infiltrato della mafia [...]. Quello descritto sui giornali è un quadro assolutamente confuso. Ci sono notizie completamente false che vengono attribuite ad Avola"». Analogo allarme anche del sostituto Mario Amato che affermerà, senza giri di parole: «Si tratta di un’ operazione studiata a tavolino per far passare la tesi che i pentiti sono dei pazzi, dei mitomani, e in quanto tali inattendibili» (38).
Nino Milazzo è stato – come abbiamo scritto – condirettore responsabile del quotidiano La Sicilia: l'unico a interrompere, per una breve parentesi, il lungo periodo in cui la responsabilità della direzione è stata assunta direttamente dall'editore Mario Ciancio. Gli abbiamo chiesto di ricostruire per il Comitato quell'esperienza.
«Sono tornato dal Corriere della Sera, dove ero appena stato confermato vicedirettore, perché inseguivo il sogno di contribuire con la mia esperienza a migliorare la situazione della città e del territorio in cui il giornale operava ed era diffuso. È stata un'illusione... Il mio sogno era di farne un piccolo Corriere della Sera. Trovai, però, una situazione che conoscevo ma che era ulteriormente peggiorata. C'era, infatti, una forte concatenazione con ambienti politici e il rifiuto di ascoltare i diritti e la voce dei sindacati, che erano messi fuori. Certe parti politiche erano assolutamente inascoltabili. Ho introdotto il principio che il giornale doveva essere aperto a tutti. Riuscii a cambiarlo, ma durò poco. Per dare l'idea della drammatica situazione in cui sono venuto a trovarmi, mio malgrado, il commento che mi è stato riferito da un politico catanese era quello che oramai certe parti
politiche non si riconoscevano più nel giornale. l'espressione fu: «questo non è più il nostro giornale».
(...) Quando sono arrivato da condirettore non sono stato mai richiamato o sollecitato da nessuno. Al contrario, c'era un capocronista, che era l'uomo dinanzi al quale Catania si inchinava – questa era la sua condizione – come lo Scarpia della Tosca... Era Turi Nicolosi, Pag. 48molto legato agli ambienti democristiani. Io introdussi la novità della riunione del mattino per preparare il giornale e lui sistematicamente mi proponeva un articolo di un politico catanese. Io risposi che i politici catanesi o di altre origini non avrebbero più scritto sul giornale per contributi che non fossero opinioni qualificate. Insomma, non erano collaboratori del giornale. Turi Nicolosi si dimise. Lo considero un mio merito. Tuttavia, in quel periodo non ho avuto mai pressioni. Ho scritto un articolo in cui dicevo che i bilanci della regione si facevano in certe ville anche catanesi.
Nessuno obiettò nulla. Di questo debbo dare atto anche a Ciancio, che per altre cose se la vedeva lui. Con me, però, non tentò mai, anche perché ho un brutto carattere sul lavoro» (39).
Un anno e mezzo dopo aver assunto la direzione de La Sicilia, Nino Milazzo si dimette dall'incarico. Questo il ricordo di Milazzo su quell'epilogo e sulle ragioni che lo determinarono.
«Alla fine del 1988 il giornale apriva una redazione a Messina. In vista di questo obiettivo avevo mandato un inviato per fare un'inchiesta sulla città per preparare il lancio del giornale. l'intervista fu con il sindaco di Messina, Provvidenti. In questa intervista il sindaco attaccò tutto l'establishment messinese in maniera pesante, parlando addirittura di un «poterificio»... Successe l'ira di Dio. Vi fu una reazione furibonda di certi ambienti che mise in allarme l'editore. Soprattutto mise in allarme un personaggio della cui esistenza non ero al corrente, cioè un corrispondente a Messina che era uomo di fiducia dell'editore. (...) Una sera si presenta l'editore assieme a questo signore. L'editore porta questo signore nella mia stanza per mettere le cose a posto. Io dissi che a me non stava bene. L'editore mi disse di uscire dalla stanza. Io gli dissi che doveva uscire lui, visto che ero il direttore. Lui disse di
essere il padrone, allora io risposi che non ero il suo massaro... l'indomani mi sono dimesso, spiegando le ragioni. Questa è la mia avventura e disavventura di Catania. La redazione fece sciopero per alcuni giorni, ma ci fu chi commentò la cosa con queste parole: “almeno stiamo in pace”».
È bene comunque mettere in evidenza anche gli aspetti positivi nella lotta alla mafia che hanno caratterizzato l'impegno del giornale La Sicilia. Non sono mancate inchieste e reportage da parte dei giornalisti de La Sicilia sui temi della mafia e le collusioni politico-economiche dando ampia voce e documentazione all'attività della Procura antimafia e spazio alle vicende processuali. Non sono mancate anche iniziative che hanno messo in risalto la presenza della mafia nei quartieri, nel sistema degli appalti non solo a Catania ma in tutta la Sicilia.
4.2.2) Il Giornale di Sicilia.
Anche il ruolo del Giornale di Sicilia e talune stagioni di opacità attraversate in passato dal principale quotidiano siciliano sono state oggetto di approfondimento di questo Comitato.
Anche il Giornale di Sicilia si è caratterizzato, oltre che per opacità, anche per iniziative positive che sono state oggetto – Pag. 49entrambe – di approfondimento di questo Comitato nella ricostruzione di fatti critici.
Nella ricostruzione dei fatti non si poteva non muovere da una vicenda che ha avuto direttamente e dolorosamente protagonista proprio il Giornale di Sicilia, ovvero l'uccisione per mano mafiosa del suo cronista di giudiziaria Mario Francese, assassinato da cosa nostra il 26 gennaio 1979. Lo ha rievocato, nella sua audizione, il giornalista de la Repubblica Roberto Bellavia: «La compiacenza è legata a dinamiche spesso impalpabili. Per spiegare meglio quello che penso ricorro all'esperienza del processo per l'omicidio di Mario Francese. (...) È particolarmente significativa (...) la chiave di difesa che ha utilizzato Michele Greco, l'allora Papa della mafia e capo della Commissione (condannato, a trenta anni, assieme ad altri sei boss di cosa nostra, per l'omicidio Francese, ndr.): «Come facevo io a dire «sì» all'omicidio di Mario Francese, se ero amico del suo editore ?», il
che è una circostanza di fatto, assolutamente autentica. l'allora editore del Giornale di Sicilia, Ardizzone, frequentava lo stesso tiro al piattello di Michele Greco». (40)
Sempre Bellavia, sul Giornale di Sicilia e sugli ultimi mesi di vita di Mario Francese: «Io penso che Francese sia stato piuttosto isolato all'interno del suo stesso corpo redazionale e che si sia tentato in tutti i modi di salvargli la vita ricorrendo a quell'area che era contigua alla mafia palermitana e che i vecchi giornalisti vedono quasi con qualche nostalgia, come se fosse meno sanguinaria e meno violenta di quella successiva. Parlo dei gruppi Bontate e Teresi, che avevano vari collegamenti con uomini che lavoravano in quel giornale. C'era un posto a Palermo, il Circolo della stampa, che si trovava dietro al Teatro Massimo. (...) Il Circolo della stampa era aperto alla crème della società siciliana ed era frequentato per lo più dai mafiosi. La sera si trasformava in una gigantesca bisca. Era una camera di compensazione di vari interessi e vi si trovavano uomini che avevano rapporti con Bontate e Teresi e che
lavoravano al Giornale di Sicilia».
Anche il giornalista de l'Espresso Lirio Abbate si è voluto soffermare nella sua audizione sull'omicidio del giornalista Mario Francese, partendo dalle motivazioni della sentenza di condanna: «Sono queste motivazioni che danno il quadro dell'ambiente degli anni Settanta del giornalismo e, in particolare, di quel giornalismo palermitano e di quel giornale, il Giornale di Sicilia, nonché di quello che avveniva dentro il Giornale di Sicilia e attorno ai colleghi. I giudici ci scrivono che «era proprio l'attività giornalistica di Mario Francese a fare di lui un possibile obiettivo di cosa nostra, per lo straordinario impegno civile con cui egli aveva compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia verificatesi negli anni Settanta, in un periodo nel quale, per la mancanza di collaboratori di giustizia, le informazioni sulla struttura e sull'attività
dell'organizzazione mafiosa erano assai limitate».
«Molti passaggi della motivazione della sentenza fanno rabbrividire, se si pensa a quel giornalismo e al mondo in cui i colleghi erano costretti a lavorare. Fra l'altro vengono fuori [...]due fatti di cronaca che coinvolsero all'epoca i giornalisti del Giornale di Sicilia e di cui non si ebbe grande eco sulla stampa. Il primo riguarda Lino Rizzi, che Pag. 50all'epoca era il direttore del Giornale di Sicilia. Lino Rizzi subì un attentato incendiario dopo la morte di Mario Francese, il 22 settembre 1978. Gli venne bruciata la macchina sotto casa. [...] Subito dopo viene fatta saltare in aria la villa del capocronista del Giornale di Sicilia, Lucio Galluzzo. Questo avvenne il 24 ottobre 1978. Venne fatta saltare questa villa nelle campagne di Casteldaccia».
«Galluzzo ai carabinieri disse: «Dovetti registrare, con profondo rammarico e comprensibile turbamento, che all'incendio di casa non fece seguito alcun atto di solidarietà da parte dei colleghi e dell'organo rappresentativo sindacale interno» Stiamo parlando del Comitato di redazione del Giornale di Sicilia. La notizia dell'attentato, infatti, non fu pubblicata sul Giornale di Sicilia. Galluzzo si dimise dal suo incarico di capocronista del Giornale di Sicilia e cessò l'attività lavorativa con decorrenza 30 dicembre 1978. [...] «La mia decisione di lasciare il Giornale di Sicilia è stata determinata dalla constatazione della sostanziale solitudine sulla quale, di fronte a gravi episodi, tanto io quanto il direttore ci venimmo trovare. [...] Resomi conto della situazione venutasi a creare, decisi di andarmene dal Giornale di Sicilia e invitai Lino Rizzi –
che all'epoca era il direttore del Giornale di Sicilia – da amico, a fare la stessa cosa». Infatti, Rizzi, dopo poco tempo, lasciò l'incarico di direttore del Giornale di Sicilia.»
«[...] Come dicevo prima, l'editore era amico di Michele Greco, che in quel momento era il «Papa» di cosa nostra, il capo di Cosa nostra palermitana, e alcuni giornalisti erano amici di mafiosi. Stefano Bontate e Mimmo Teresi frequentavano spesso la redazione del Giornale di Sicilia. Come si vedrà e come si è visto da alcune indagini, a loro questi giornalisti rivelavano notizie e retroscena su alcuni fatti, in modo da tenere aggiornata e informata cosa nostra. La mentalità mafiosa di mettere mano all'informazione fino a pochi anni fa, almeno fino a quando sono rimasto a lavorare a Palermo, non è cambiata».
Sul clima all'interno del Giornale di Sicilia dopo la morte di Francese e sulla prudenza con cui il quotidiano palermitano continuò a seguire in quegli anni talune cronache di mafia e i personaggi in esse coinvolti, è ancora Abbate a parlarne al Comitato.
«Dopo l'omicidio Francese c’è un fatto eclatante che è opportuno evidenziare in questa sede [...] il licenziamento, nel settembre 1985, del vicecapocronista dell'epoca del Giornale di Sicilia. Sto parlando di Francesco La Licata, il quale aveva l'unica colpa di portare le notizie in quel giornale. La Licata venne licenziato perché aveva pubblicato un articolo con notizie che riguardavano dichiarazioni di collaboratori di giustizia su mafia e politica e che incominciavano a parlare all'epoca dei cugini Nino e Ignazio Salvo, nomi che per il Giornale di Sicilia erano tabù. La Licata aveva pubblicato quelle notizie su un altro giornale, precisamente su l'Espresso. Perché ? Perché il direttore ed editore, Antonio Ardizzone, fino a quel momento aveva rifiutato di mettere in pagina quelle notizie su mafia e politica. Occorre ricordare che quelli erano i primi anni in cui c'erano i
pentiti. Venivano fuori le dichiarazioni dei pentiti e veniva svelato il retroscena di Cosa nostra».
È utile proporre alcuni passaggi della lunga intervista con cui Francesco La Licata ricostruisce quel tempo e quei fatti nella ricerca Pag. 51elaborata da Ossigeno per l'informazione, che la Commissione ha acquisito nel marzo scorso.
«L'esempio più eclatante è il maxiprocesso di Palermo. Allora lavoravo al Giornale di Sicilia e in quel periodo quel giornale era il buco nero nel panorama della stampa italiana. Il 16 febbraio 1986, il giorno che cominciò il maxiprocesso, apparve in prima pagina un titolo terrificante: «Silenzio, entra la Corte». Ma quale silenzio, se da una vita aspettavamo che si cominciasse a parlare ? C'era finalmente la possibilità di parlare e il mio giornale diceva: «Silenzio !». Ricordo che per quel titolo ci fu una grande polemica all'interno del giornale, anche se all'esterno non se ne parlò: i giornali non si attaccavano tra loro, e poi il nostro concorrente diretto era il quotidiano La Sicilia di Catania, che praticamente faceva la stessa informazione. Mi ricordo che questi giornali adottarono la regola di definire tutto presunto. Tutto per loro era presunto. Perfino
Michele Greco era definito «presunto mafioso». Mi viene in mente un altro titolo terrificante a un articolo su un processo alla mafia di Agrigento. Il titolista fu costretto a scrivere: «Processo alla presunta mafia di Agrigento». Era una cosa che non stava in piedi. Poi il giornale cominciò a pubblicare due pagine che si guardavano, una a sinistra e l'altra a destra, una con la testatina «mafia» e l'altra «antimafia», come se le due cose fossero sullo stesso piano. La pagina dell'antimafia era piena di inutili trascrizioni di testimonianze pubblicate pari pari, senza interventi critici. Nell'altra pagina c'erano gli interventi dei difensori degli imputati. Fu realizzata così una perfetta par condicio che non avrebbe mai dovuto esserci».
«Penso al Giornale di Sicilia e al suo atteggiamento nei confronti delle indagini sui cugini Salvo, i potenti esattori di Salemi e su Ciancimino. Sui Salvo posso raccontare un episodio che mi riguarda. [...] Erano molto potenti. Basti dire che Giovanni Falcone dovette aspettare diversi anni per riuscire a emettere un provvedimento restrittivo nei loro confronti e riuscire a metterli sotto accusa. Riuscì a farli arrestare soltanto il 12 novembre 1984, dopo che Tommaso Buscetta gli fornì il materiale e i riscontri per poterli accusare. Le difese che i Salvo avevano messo in campo erano tutte politiche: Andreotti, gli andreottiani siciliani, la Regione, le banche... Controllavano quel mondo. Erano imprenditori e dicevano di aver dato soldi a tutti, pure all'opposizione. Che la cosa fosse vera o no, poco importava. [...]
Quando Falcone emise quella che allora si chiamava comunicazione giudiziaria nei confronti dei Salvo, lavoravo al Giornale di Sicilia. Ebbi la notizia in esclusiva e la comunicai subito al vicedirettore Giovanni Pepi. Lui mi disse che ne avrebbe parlato con il direttore, l'editore Antonio Ardizzone. Dopo una settimana la notizia era ferma, non veniva pubblicata. Nessun'altro sapeva che c'era stata quella comunicazione giudiziaria ai Salvo. Andai di nuovo da Pepi e gli chiesi: «Ne hai parlato col direttore ?». «No – mi disse – me ne sono scordato, gli parlo stasera e poi ti dico». Passarono uno, due, tre, cinque giorni senza alcuna risposta. Era stranissimo ! Le indagini sui Salvo, erano un grande scoop ! Tornai dal vicedirettore. Mi disse: «Il direttore ci sta pensando». Dopo una ventina di giorni passai sottobanco la notizia al cronista di un giornale concorrente, che la
pubblicò subito. Quando uscì, andai da Pepi e gli dissi: «Giovanni, finalmente l'abbiamo “bucata”». Lui mi rispose: «Non ti preoccupare, preparati, comincia a Pag. 52scrivere. Facciamo una “spalla” in prima pagina e una pagina all'interno». Cominciai a lavorarci. Verso le sette del pomeriggio Pepi mi chiamò e mi chiese: «Senti Ciccio, ma la comunicazione giudiziaria per quale reato è ?». Risposi: «Per associazione per delinquere». «Ma allora non è per mafia – replicò lui – e allora cambia tutto». «Scusa Giovanni, ma una comunicazione giudiziaria per associazione per delinquere ti pare un'onorificenza ?», chiesi. E lui: «No, no, allora scrivi quaranta righe che mettiamo a pagina sei». Io rifiutai e dissi di farle scrivere ad un altro. Questo era
il clima negli anni 83-84, dopo le rivelazioni di Buscetta. [...]
Dopo ci furono altre scaramucce. Finché un giorno scrissi per l'Espresso, il settimanale con il quale collaboravo, un articolo sul pentito Vincenzo Sinagra. Avevo fatto il “pezzo” di corsa perché il giornale me l'aveva chiesto all'ultimo momento. Era una notizia di scarso rilievo ricavata dai verbali di Buscetta. Mi sentivo nel giusto perché, prima di scrivere quell'articolo, avevo proposto al giornale di scrivere degli articoli tratti dai verbali di Buscetta. Quei verbali li cercava tutto il mondo e li avevo soltanto io ! Pepi mi aveva detto: «Benissimo, comincia a scrivere». Come primo articolo proposi un ritratto di Michele Greco ricavato dalle carte del maxi processo, dell'istruttoria di Falcone. E fu un errore, perché Greco era considerato soltanto un imprenditore, ed era amico dell'editore del mio giornale; andavano insieme al circolo del tiro a volo. Avevo notato una cosa strana. In quel
periodo avevo cercato una foto di Michele Greco, ero riuscito a trovare la foto segnaletica e ogni volta che la tiravo fuori dall'archivio per pubblicarla spariva. Non si trovava più. Per averla a disposizione ne feci stampare diverse copie, le tenevo in tasca e ne tiravo fuori una quando mi serviva. Poi trovai una foto bellissima di Michele Greco al circolo del tiro a volo di Mondello, insieme con un nobile palermitano, il barone Cammarata, e Federico Ardizzone, padre dell'editore. Decido di usarla per un mio articolo e la mando in tipografia con le indicazioni per pubblicarla. Dopo un po’ arriva il proto (il capo della tipografia, ndr) e mi dice: «Guarda che quello lì è il nostro editore». Fingo di non saperlo. Dopodiché decidono di ritagliare la foto togliendo sia il barone Cammarata sia Federico Ardizzone e lasciando soltanto Michele Greco. Quella è l'unica foto che è rimasta e che verrà poi
pubblicata».
«Scrissi l'articolo su Michele Greco e il Giornale di Sicilia pubblicò quella pagina su Greco. Dopo mi chiamò Pepi e mi disse: «Adesso dai le carte al collega Calaciura e torna in ferie». Infatti, ero rientrato dalle ferie proprio perché avevo avuto quei verbali. La richiesta mi sembrò assurda. «Scusa, Giovanni, ma che richiesta è ? Ti sembra giusto che io che li ho trovati do i verbali di Buscetta a un altro collega perché scriva lui ?». «Prendo atto che non vuoi collaborare», mi disse. «Guarda, voglio collaborare tant’è vero che ho portato un materiale inedito, esclusivo, e tu non me lo stai pubblicando». Ci lasciammo così».
«Quegli articoli non li ha scritti più nessuno. L'articolo su Sinagra per l'Espresso uscì dopo che c'era stato questo episodio. Per quell'articolo mi accusarono di aver dato la notizia al nemico, alla concorrenza, e mi licenziarono. Sostennero che avevo danneggiato l'azienda. Risposi negando, tramite l'avvocato, che cercavano scuse e che quella era una Pag. 53censura politica nei miei confronti. Il caso scosse il giornale che per tre o quattro giorni non uscì. Venne a Palermo il segretario della Federazione nazionale della stampa, Sergio Borsi, e la trattativa si concluse con una commutazione della pena. L'editore mi riassunse e tramutò il licenziamento in una sospensione di quindici giorni. Gli feci presente che il contratto di lavoro prevede una sospensione massima di dieci giorni e lui mi rispose: «Vabbè cinque te li prendi di ferie». Al
rientro [...] mi diedero l'incarico di fare da Palermo le pagine di Enna. Avevamo un solo corrispondente che era un giudice sportivo del Coni che mi chiamava da Oslo per darmi la notizia di apertura della pagina di Enna. E a me mandavano lettere di contestazione per i “buchi” che prendevamo a Enna ! Questo supplizio durò due anni».
«Al Giornale di Sicilia c'erano dei legami molto forti, che sono emersi al processo Francese. [...] Ero molto amico di Giuseppe Montaperto. Pur sapendo che era chiacchierato, gli concedevo il beneficio del dubbio. Lo vedevo come un fanfarone generoso. Lui era “inserito’, e lo diceva lui stesso. Ti raccontava che era stato compare di anello di Mimmo Teresi, che da giovane giocava con Contorno e con i Grado. Gli altri colleghi consideravano queste sue entrature quasi una forma di tutela. [...] Federico Ardizzone era amico di famiglia di Michele Greco, e pure di Girolamo Passantino, il direttore amministrativo. Di Passantino ce ne erano tre, tre fratelli e lavoravano tutti al Giornale di Sicilia. Il maggiore era il direttore amministrativo. Aveva casa a Ciaculli, in un'abitazione costruita su un terreno regalatogli dai Greco».
La Licata torna anche sul delitto Francese: «Nel 1978 bruciarono la macchina al direttore, Lino Rizzi, alla Kalsa. Poi bombardarono la villa di Lucio Galluzzo a Casteldaccia, accanto a quella di Michele e Salvatore Greco, e quindi era ovvio che c'era il loro beneplacito altrimenti una cosa del genere non l'avrebbero fatta. Poi ammazzano Mario Francese. [...] Nel 1979, morto Mario Francese, il Giornale di Sicilia va allo sbando, cambia perfino la ragione sociale. Se si guardano le carte di allora, Antonio Ardizzone non ha più alcun incarico nel consiglio di amministrazione. Affidano l'incarico a Piero Pirri, che stava a New York ed era chiamato “il messicano”, per dire quanto fosse distante. In un certo senso è come se loro avessero venduto il giornale e Piero Pirri, che non ha pregiudizi, prende come direttore De Luca, un comunista che era stato tra i fondatori di Repubblica. De Luca trasforma il giornale
in un vero giornale: dall'81 all'83 è un giornale che fa antimafia. [...] Nell'82, quando ammazzano Dalla Chiesa, torna l'interesse di Ardizzone per il giornale. [...] È a quel punto che Ardizzone torna in campo e fa licenziare Sciascia per un editoriale sull'omicidio Dalla Chiesa, perché aveva scritto che è un omicidio di Stato. E dà la lettera di licenziamento al direttore Fausto De Luca, mentre è in ospedale per fare la chemioterapia per un cancro ai polmoni. Lo licenziano in ospedale. Cambia di nuovo il consiglio di amministrazione, Ardizzone prende nuovamente la direzione e fa un'assemblea, raccontata da «I Siciliani», in cui dice: «Abbiamo scherzato. Prima di dire mafioso a uno, voglio la foto». Nasce così la filosofia del presunto e l'interprete per eccellenza è stato Pepi, che è ancora lì. [...] Mi ricordo che se parlavi di un imputato mafioso te lo trovavi in redazione.
Cassina veniva di persona, Lima pure... Le carte del maxi processo furono mandate per fax alle esattorie di Palermo».Pag. 54
Citato nel corso di più audizioni, il Comitato ha audito anche Giovanni Pepi (41), da trentatré anni ininterrottamente condirettore responsabile de il Giornale di Sicilia, anche per dare voce ad un'altra valutazione che è bene rappresentare nella sua completezza: «Io divento condirettore nel 1982, [...] esattamente un mese dopo l'omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa. È quello il punto di riferimento. [...] Io arrivo a fare il giornalista senza averlo voluto fare – allora capitava – avevo altri obiettivi, ma ho percorso, per una serie anche di circostanze interne, una carriera piuttosto rapida. Pertanto, nell'arco di dieci anni riesco ad assumere questo incarico. Sono arrivato, quindi, a dirigere il giornale – lo riconosco – senza avere alcuna esperienza di cronaca nera. [...] Mai avrei potuto aspettarmi che da quel momento la mafia e lo studio dei fenomeni
criminali a Palermo dovessero diventare la mia prima attività culturale, ma così è stato.»
Spiega Pepi, sul maxiprocesso di Palermo e sull'informazione del suo giornale in tema di mafia: «Noi abbiamo deciso, per esempio, quanto al massimo di informazione da garantire, di pubblicare il resoconto stenografico del maxiprocesso. Quando i riflettori su quel maxiprocesso, che costituisce una svolta storica nel contrasto alla criminalità organizzata, si sono spenti altrove, noi li abbiamo tenuti continuamente accesi. Attraverso il racconto dei fatti, peraltro, in quella circostanza – non dimentichiamolo – arricchiti dai confronti tra i grandi pentiti e i boss che venivano accusati, veniva fuori quel groviglio di efferatezze e di violenza che non sempre i palermitani e i siciliani conoscevano».
«Quando abbiamo avuto da Libero Grassi la richiesta di un'intervista perché lui lanciasse la sfida al suo estortore, noi non ci siamo limitati a registrarla. Abbiamo, con una certa enfasi, messo in prima pagina quell'appello tremendo che lui rivolgeva a tutti. Credo, purtroppo, che quella decisione sia una delle ragioni non secondarie della sua morte. A proposito di rendere visibili alcune scelte di campo, proprio alla luce di quanto Libero Grassi aveva subìto, noi siamo diventati in Sicilia il megafono del movimento Addiopizzo, quel movimento che si è presentato anonimamente in una prima fase con murali che spuntavano nelle strade e che sembravano sgorgare da misteriosi antri, in cui si diceva: «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». Noi abbiamo potuto pubblicare un elenco di 3.000 commercianti che decidevano di scendere in campo dicendo: «Io pago chi non paga». E sempre
per quanto riguarda le scelte di campo visibili, vorrei ricordare la nostra battaglia per garantire, per esempio, un presidio legale, una caserma dei carabinieri prevista sulla carta, che per anni non veniva istituita, in un quartiere come lo Zen di Palermo, che tutti conoscono, essendo il quartiere simbolo di una serie di devianze».
Sul maxiprocesso di Palermo e sui rilievi mossi dal giornalista La Licata partendo proprio dal titolo dedicato alla prima udienza («Entra la Corte: silenzio !»), a domanda – se oggi rifarebbe quel titolo – la posizione del condirettore Pepi è stata netta: «Eccome, se lo rifarei. [...] «Entra la Corte: silenzio» significava una cosa molto precisa: rimettiamoci alle valutazioni dei magistrati e accettiamo che la verità Pag. 55venga fuori dal confronto e dal dibattimento senza tifare e senza esercitare pressioni. Questo è ciò che noi volevamo dire».
Sull'omicidio Francese, e sulle frequentazioni che vennero processualmente svelate tra l'editore de il Giornale di Sicilia Ardizzone e il capo della cupola di cosa nostra Michele Greco, è utile annotare lo scambio tra l'audito e il presidente del Comitato:
«PRESIDENTE. Nel corso di quel processo vennero fuori alcune questioni piuttosto significative, cioè un rapporto di amicizia tra l'editore in carica in quel momento, Federico Ardizzone, e Michele Greco, che era l'imputato principale che è stato condannato in quel processo. Si trattava, peraltro, di un'amicizia consacrata in fotografie che sono state ricordate al processo, con la frequentazione in comune di un tiro al piattello a Palermo, e rivendicate, persino con una punta di orgoglio, per quanto possa esserci orgoglio in tutto ciò, da parte dell'imputato in un'udienza del maxiprocesso. l'imputato, peraltro, disse: «Noi siamo rimasti amici anche dopo la morte di Mario Francese e la nostra frequentazione si è interrotta – cito a memoria la testimonianza di Michele Greco al maxiprocesso – solo dopo la morte di Dalla Chiesa, quando divenne impossibile continuarla, anche perché io ero
latitante». Lei ha mai avuto percezione di questi rapporti tra l'editore del suo giornale e la famiglia Greco ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. Io no, però voglio farle notare un fatto. Lei ha parlato di me come del condirettore più longevo. Io, però, assumo quell'incarico insieme ad Antonio Ardizzone, il figlio di Federico. Tutte le scelte di cui ho parlato finora sono state condivise tra me e lui. Francamente, non ho assolutamente nulla da dire su eventuali influenze di un rapporto di amicizia che, come lei ha ricordato, coinvolgeva il tiro al piattello. Il circolo di tiro a segno era uno dei circoli di notabili di Palermo in cui si incontrava la buona società. Pertanto, quando facciamo questi riferimenti, non dobbiamo dimenticare la storia, perché poi le cose cambiano e le scelte, credo, sono state conseguenti.
PRESIDENTE. Proviamo a vedere la questione da un punto di vista diverso. Lei ha mai saputo dei rapporti tra il suo editore e cosa nostra, nella persona di Michele Greco, prima che tutto questo venisse svelato al processo per la morte di Mario Francese ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. No.
PRESIDENTE. È mai accaduto, nel corso della sua esperienza da condirettore, che lei o altri giornalisti siate stati avvicinati da esponenti della mafia per pretendere attenzione, benevolenza, pezzi da pubblicare o pezzi da non pubblicare ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. Questo sento veramente di poterlo escludere e comunque, anche quando fosse successo, ci sarebbero stati rifiuti, ma non ce n’è stato bisogno. Onestamente, sento di poter escluderlo in modo totale.
Pag. 56PRESIDENTE. Ci dica qualcosa sulla vicenda di Montaperto. [...] Per sua ammissione, oltre che per riferimento di molti testi nel corso del processo, costui era una sorta di public relation man di alcune storiche famiglie dell'aristocrazia mafiosa, i Teresi e i Bontate in modo particolare, cosa che fu da lui, se non rivendicata, ammessa con assoluto candore. Alla luce di quello che è venuto fuori nel 2000 in questo processo, il ruolo di Montaperto, per la sua esperienza – essendo stato anche un suo cronista – lei come l'ha riletto ? [...] Fino a quando è rimasto cronista Montaperto ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. Quando io sono diventato vicedirettore e Antonio Ardizzone direttore, lui era ancora cronista di nera, ma in quella fase i rapporti già cominciarono a incrinarsi, fino a manifestazioni di rottura ben documentate. Pertanto, di lui posso dire ben poco, onestamente, perché non lo frequentavo. Avevamo anche ambiti di impegno professionale molto diversi.
PRESIDENTE. Lui era cronista mentre lei era già direttore ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. Lui è stato cronista di nera, mentre io ero direttore. Peraltro, non è che lavorasse molto. Da questo punto di vista i miei rapporti con lui erano assolutamente sporadici.
PRESIDENTE. Lei ha appreso di questi suoi rapporti soltanto al processo ?
GIOVANNI PEPI, condirettore responsabile del Giornale di Sicilia. Sì, solo al processo».
Infine, la vicenda ricostruita da La Licata (la notizia non pubblicata della comunicazione giudiziaria a Nino Salvo, lo scontro con Pepi, il licenziamento – poi rientrato), Giovanni Pepi la ricostruisce così: «In un momento in cui – non dimentichiamolo – vivevamo i furori di un circuito mediatico giudiziario in cui molti polveroni potevano essere sollevati, noi abbiamo fatto una scelta precisa, ossia quella di pubblicare ciò che era possibile verificare e controllare. Quella notizia ci venne fornita come un'indiscrezione da La Licata e io chiesi se potessimo anche dar conto della conferma. Mi fu risposto che conferme non potevano darne, ma la notizia era certa. Io ho detto che una notizia così importante non mi sentivo di pubblicarla senza che ci fossero da parte degli inquirenti le conferme giuste. [...] Ha detto che c'era questa comunicazione giudiziaria e che la notizia era certa, ma che non poteva darla
con la conferma che io gli chiedevo. Evidentemente, lui la voleva dare in un modo diverso».
La notizia era vera, ha spiegato La Licata. Pepi ammette: «Sì, c'era stata una comunicazione giudiziaria. Poi, a un certo punto, anche qui, venne fuori che quella comunicazione giudiziaria non riguardava, come si pensava, fatti di mafia, ma un'associazione a delinquere semplice per una questione di economia. [...] Tuttavia, ripeto, io voglio dire che in Pag. 57quel clima, in cui si misuravano, anche con una certa asprezza, questo modo di fare informazione e coloro che dicevano di essere garantisti, ci possono essere errori per eccesso da parte degli uni e degli altri». E alla domanda se quella notizia oggi l'avrebbe pubblicata, Pepi risponde: «Può darsi di sì».
A proposito degli esattori Salvo e del loro rapporto con il Giornale di Sicilia, aggiunge l'audito: «I Salvo venivano qualche volta, anzi soltanto Nino Salvo veniva a portare, quando c'erano quelle polemiche, i comunicati del gruppo. Non è assolutamente vero che ci fosse questa frequentazione assidua. [...] Stiamo ai fatti. Quando i Salvo sono ancora i Salvo e non sono i Salvo inquisiti, i Salvo sono i più potenti uomini dell'isola. Lei crede che i più potenti uomini dell'isola non debbano avere rapporti con il maggior giornale dell'isola ? È mai successa una cosa del genere ?». E su eventuali interessi economici dei cugini Salvo nella proprietà del Giornale di Sicilia, dice Pepi: «Lo escludo categoricamente. Non ci sono».
Il Comitato ha voluto infine verificare con il dottor Pepi, per conoscere il suo punto di vista, le informazioni che sul suo conto hanno fornito diversi collaboratori di giustizia (i cui verbali di interrogatorio sono stati tutti acquisiti dalla Commissione).
1. Il collaboratore di giustizia Angelo Siino: «Intendo riferire un episodio riguardo il dottor Pepi, direttore del Giornale di Sicilia. Lo vidi in occasione del matrimonio della figlia di Lipari, Pino Lipari, che lo salutò affettuosamente e mi disse che era un amico». (42)
Giovanni Pepi: «La Lipari era una collaboratrice del giornale, ed era la figlia. Per questa ragione mi trovavo a quel matrimonio. Peraltro, quello era un periodo in cui mi occupavo del reclutamento dei giovani collaboratori, perché volevo organizzare dei gruppi che poi avrebbero dato vita al giornale Cronaca in classe. La Lipari era una collaboratrice e per questo motivo mi trovai a quel matrimonio. Mi presentò suo padre e lo salutai».
2. Ancora Angelo Siino: «In occasione di un altro mio colloquio con il Lipari questi mi disse che il Pepi avrebbe dovuto fare un'intervista al latitante Riina, concordata con il Lipari. Poi, però, non se ne fece nulla per l'opposizione di Antonio Ardizzone, che si preoccupava dei possibili riflessi negativi sul giornale». (43)
Giovanni Pepi: «Questa è una cosa che apprendo adesso [...] Io di questa intervista so ben poco, se non quello che lui ha detto, ripeto, davanti alle televisioni e ai cronisti la prima volta in cui è comparso. Di questa cosa non so nulla. [...] Tenga conto che io ero, e lei lo sa, non solo il condirettore, ma anche un editorialista di punta del giornale, che era assolutamente impegnato a fronteggiare anche le polemiche di cui abbiamo parlato. Evidentemente, essendo una firma in vista, poteva avere un interesse da questo punto di vista [...] ma io non ci vedo niente di strumentale a disegni di cui, ripeto, non so nulla». Infine, sempre su questo punto, l'audito ricorda: «Io scendo dall'aereo e in aeroporto incontro l'avvocato di Riina, Fileccia, il quale mi dice che ci sono molte richieste di intervista. Tuttavia, se Riina avesse deciso di rilasciare un'intervista, aveva detto che l'avrebbe rilasciata soltanto
a me». Il dottor Pepi ha aggiunto di non essere mai stato sentito sul punto da alcun magistrato.Pag. 58
3. Il collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori riferisce sull'intenzione di cosa nostra di sequestrare l'editore del Giornale di Sicilia Ardizzone e su una possibile intervista che Salvatore Riina avrebbe potuto o voluto concedere a Pepi: «Confermo che il sequestro Ardizzone aveva solo scopo estorsivo e nulla aveva a che fare con l'attività di editore del Giornale di Sicilia del medesimo. Al riguardo devo però dire che quando mi venne prospettato il progetto di sequestro dell'Ardizzone la cosa mi stupì in parte, in quanto avevo sentito il Riina, poco tempo prima del suo arresto fare riferimento al direttore del suddetto quotidiano come l'unico giornalista di cui si fidava». Sempre Sinacori, sull'intervista a Riina: «In particolare nell'occasione – che preciso trattarsi della medesima circostanza in cui il Riina parlando di un suo possibile arresto aveva fatto riferimento
alla necessità di proseguire con la linea dura – il Riina disse a me e a Messina Denaro Matteo (il padrone di casa Biondino Salvatore era in un'altra stanza) che, qualora arrestato, egli avrebbe potuto rilasciare un'intervista solo al Pepi che riteneva l'unico giornalista serio». (44)
Giovanni Pepi: «Di questo non so nulla, anzi lo apprendo ora».
Per completezza bisogna anche dar conto che, sotto il periodo della condirezione di Pepi, il Giornale di Sicilia ha dato spazio alle notizie su cosa nostra, in tempi più remoti pubblicando le inchieste di Mario Francese su argomenti che altri giornali non toccavano o, come già riferito dallo stesso Pepi, pubblicando i resoconti integrali del maxiprocesso che hanno fatto conoscere gli orrori di cosa nostra attraverso il racconto dei mafiosi divenuti collaboratori di giustizia. Come pure va segnalata la scelta del Giornale di Sicilia di sostenere l'azione del generale dalla Chiesa e di aver dato quasi esclusivamente voce alle denunzie di Libero Grassi in un momento in cui l'isolamento era palpabile anche all'interno della sua stessa associazione. Più recentemente, come sempre Pepi ha sottolineato nel corso dell'audizione, attraverso l'aperto sostegno alle attività dell'associazione “Addiopizzo”,
partito con la pubblicazione dei nomi dei commercianti che si erano ribellati al racket e proseguito con la campagna «Pago chi non paga» che continua tutt'ora; aprendo un canale di contatto diretto con le scuole sui temi della lotta alla mafia con la rubrica «Cronache in classe», premiata anche dall'ONU come modello di cultura della legalità; sostenendo una campagna per istituire allo Zen una caserma dei carabinieri e un presidio dei vigili urbani; lanciando infine un'altra campagna per far utilizzare le case confiscate alla mafia per l'emergenza abitativa a Palermo.
4.3) L'Informazione in Calabria e il caso di Calabria Ora.
La figura di Michele Albanese, giornalista de Il Quotidiano del Sud (giornale calabrese diffuso anche in Basilicata e in Campania) tuttora sottoposto a tutela, è ben riassunta dal sentimento che emerge nella sua audizione: Albanese è più preoccupato di non poter più essere libero di raccogliere notizie e raccontarle ai lettori che della propria sicurezza.
«Vengo convocato in prefettura, dove il prefetto mi notifica la decisione del comitato di mettermi sotto scorta. Mi hanno detto che avevano avuto elementi per ritenere quelle minacce preoccupanti e per Pag. 59questa ragione mi mettevano sotto scorta. Ho cercato in mille modi, già subito in quella sede, di dire che avrei avuto difficoltà ad accettare la scorta, anche se rispettavo, capivo e avevo un enorme rispetto per le istituzioni che lì erano rappresentate. Dissi che di fatto mi avrebbe cambiato la vita e mi avrebbe creato problemi nel continuare a fare il mio lavoro. Tuttavia, ho dovuto accettare per una serie di ragioni. Non spettava a me decidere. Anche se io ho la libertà di rifiutarla un giorno, cosa che non escludo di poter fare, in quel momento ho dovuto accettare la scorta e avere rispetto dello Stato che in quel momento aveva attenzione nei miei
confronti» (45). La Calabria è piena di giornalisti come lui, tanto quanto è povera di giornali pienamente liberi dalle pressioni esterne, anche per la scarsa presenza ed attenzione da parte delle grandi testate nazionali.
La diversità delle minacce verso Albanese sta nel fatto che non gli sono state rivolte direttamente o inviate a casa o in redazione, ma sono state intercettate delle conversazioni tra esponenti della ‘ndrangheta che pensavano di mettere in atto un'azione violenta contro di lui, azione che sia la magistratura che la prefettura hanno ritenuto possibile che accadesse tanto da sottoporlo subito ad una adeguata protezione.
Tutto comincia quando a Rizziconi, un paese vicino a Gioia Tauro, il 4 giugno 2014 vengono tratte in arresto sedici persone dopo un'inchiesta nata in seguito delle denunce dell'ex sindaco, Nino Bartuccio, «...che era stato «dimissionato» dalla ‘ndrangheta – ricostruisce Albanese – nel senso che la ‘ndrangheta, con i suoi modi, aveva convinto tre o quattro consiglieri comunali a dimettersi e a sciogliere il consiglio comunale, perché il sindaco non era gradito al boss. È stata chiamata «operazione Deus», proprio perché nel corso dell'indagine è emerso che uno degli indagati definiva il boss «Dio in terra». Quando accadono queste cose, il mio giornale e io facciamo una serie di approfondimenti. Prendiamo le carte, ci ragioniamo sopra, cerchiamo di spiegare il contesto e di raccontare i particolari. È un lavoro che dura, dopo un'inchiesta, tre o
quattro giorni di approfondimenti. Abbiamo fatto in questo modo anche per quell'operazione...».
Qualche giorno dopo c’è la convocazione di Albanese in questura.
«Arriva il pubblico ministero in questura, che mi dice: “Michele, non ti preoccupare. Ieri abbiamo ascoltato un'ambientale dove due tizi parlavano di te in un determinato modo e ipotizzavano di fare qualcosa nei tuoi confronti”».
La motivazione dell'astio nei confronti di Albanese è causata dal modo in cui svolge la sua professione, ricercando sul campo notizie che raccontino la realtà degli interessi della ‘ndrangheta ben prima che vengano rivelati dalle indagini giudiziarie. Ha subito furti in casa, danneggiamenti, minacce a lui ed alla sua famiglia, senza mai smettere di fare il suo lavoro. Anche di fronte alla colpevole indifferenza o all'omertà di altri pezzi della società. È sempre Albanese a raccontare: «Faccio un esempio. Vi ricordate Oppido, quando emerse l'operazione Erinni e il tizio ammise che uno dei suoi avversari nella faida Pag. 60venne dato vivo in pasto ai maiali ? Io andai a sentire il sindaco e il prete di quel paese [...]. Chiedevo: «Voi avete la percezione di quello che si dice e di quello che è successo in questo contesto ?».
Quel sindaco mi disse che non aveva letto il giornale né visto la televisione. Il parroco mi disse: «Io non posso fare altro che pregare per quello che è accaduto». Ovviamente un cronista che ha un rapporto con la sua terra come quello che ho io alcune considerazioni le fa !».
«Anche a Rizziconi io andai a sentire l'attuale sindaco per chiedergli come giudicava quello che era accaduto. Ricordo che feci dei pezzi sulla ricerca del figlio del boss (Giuseppe Crea, figlio de capocosca Teodoro Crea, ndr) tuttora latitante, da ormai otto anni, che viene ritenuto pericolosissimo. Ho cercato di raccontare anche l'azione delle forze dell'ordine in quel paese. Forse tutto questo ha dato fastidio. [...] Purtroppo durante un consiglio comunale aperto, in piazza, l'attuale sindaco si alzò e cominciò a inveire contro chi aveva definito Rizziconi «un paese da Medioevo» e «contro il giornalista de Il Quotidiano qui presente che aveva criminalizzato tutto il paese». Pochi giorni dopo, paradossalmente, anche il vicario generale della diocesi di Rizziconi – circa dieci giorni prima avevo fatto un pezzo sull'inchino della Madonna a Oppido – gridò in chiesa:
«Pregate per la Chiesa, che è sotto attacco dei magistrati e dei giornalisti de Il Quotidiano. Ovviamente il giornalista de Il Quotidiano più esposto del territorio sono io. Non ce ne sono altri».
Lo stesso giornalista ha portato ad esempio del diverso comportamento dei giornalisti e delle testate su fatti e inchieste di ‘ndrangheta tre vicende di cronaca. La prima riguarda la collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce, una vicenda nella quale il ruolo dei media, il rapporto con gli avvocati e con i parenti dei mafiosi è stato oggetto di diverse audizioni ed è ampiamente trattato da questa relazione. Dice Albanese: «Io ero nell'ufficio di redazione allora aperto a Polistena quando ricevo una telefonata da parte della cognata dell'attuale collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce. Cercava Michele Albanese. Voleva proprio me. Mi dice: «Volevo dirvi che non è vero che mia cognata si è pentita. Questo è il numero del nuovo avvocato. Chiamatelo e vi dirà tutto lui. Vedete di scrivere bene». Ovviamente io informo gli inquirenti di quella telefonata, poi chiamo l'avvocato e faccio
il pezzo. Era un pezzo tradizionale, perché la cronaca era quella. L'avvocato mi dice che la Pesce aveva deciso di revocare la collaborazione. Faccio un pezzo di 40-50 righe. Il giorno dopo altri giornali regionali riportavano due pagine intere che attaccavano la magistratura».
«Un'altra vicenda riguarda la morte di Maria Concetta Cacciola, altra collaboratrice di Rosarno (anche sullo sventurato caso della Cacciola questa relazione riferisce ampiamente, ndr). Viene presentata in procura una lettera scritta da Maria Concetta con un audio registrato. Il giorno dopo, mentre noi facciamo un pezzo di cronaca normale, escono altre pagine che attaccano i magistrati e che li indicano come presunti responsabili morali del suicidio di quella donna, salvo poi scoprire più tardi dalle indagini che in realtà non si trattava di questo».
«L'ultima vicenda riguarda la morte del boss Alvaro di Sinopoli. Il questore vieta il funerale pubblico. Dopo un paio di giorni, in prima Pag. 61pagina, un giornale regionale (Calabria Ora, ndr) ospita una lettera del figlio del boss che attacca direttamente don Pino De Masi, referente di Libera, che allora era vicario generale della diocesi, per non aver voluto far entrare il papà morto in chiesa, sapendo bene che mentiva, perché il funerale pubblico non lo vietò il vicario della diocesi ma il questore. È possibile che un giornalista abbia pubblicato una cosa di questo genere, manifestando, quantomeno, un'enorme ignoranza ?».
Albanese ha riferito al Comitato di aver segnalato al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria il comportamento dell'allora direttore del quotidiano Calabria Ora ma la risposta è stata che lo stesso, Piero Sansonetti, apparteneva ad un ordine regionale diverso.
Paolo Pollichieni ha lavorato a lungo in quello che è stato per molto tempo l'unico quotidiano regionale, la Gazzetta del Sud. Successivamente ha diretto Calabria Ora, arrivato inizialmente nelle edicole come Quotidiano della Calabria. Attualmente dirige il settimanale Corriere della Calabria e l'agenzia di stampa nazionale Il Velino. La sua audizione è stata l'occasione per ricostruire – a partire dalla sua esperienza – il modo in cui si è modificato in Calabria il rapporto tra l'informazione e la ‘ndrangheta. E in particolare, la determinazione delle cosche mafiose di pretendere dai giornalisti il medesimo sentimento di “rispetto’ preteso da molte altre categorie sociali.
«Ricordo che i giornalisti, anche valenti, dai quali ho imparato molte cose, si dilettavano ancora con questa differenziazione tra la vecchia e la nuova mafia, tra la mafia con il senso dell'onore e quella sopravvenuta come forme di gangsterismo. Sul giornale in cui io ho cominciato a lavorare era possibile leggere titoli del tipo «Angelo Macrì, il bandito romantico dei campi di Bova», oppure «Ciccino Furci, la migliore lama di Fiumara di Muro». [...] All'inizio ti condizionavano come corrispondente, come operatore dell'informazione. I più esposti erano i corrispondenti di alcune aree: sono i meno conosciuti, i più puri e i più duri anche dell'attuale giornalismo calabrese. Andavano puniti, ma non perché la loro informazione creasse un problema alla struttura o agli interessi della cosca. Faccio un esempio. A Locri si bruciava una macchina ogni sera: venne bruciata la macchina del postino. [...]
Quel postino avrebbe dovuto dichiarare che una tale busta, nemmeno di un boss, ma di un figlioccio di un boss, non la poteva recapitare perché il destinatario era sconosciuto. Si rifiutò, non poteva farlo, non lo fece e venne colpito anche lui. In questa realtà non si colpisce il postino che ha fatto un danno con la raccomandata. È l'insubordinazione che viene punita. Molte delle «attenzioni» che venivano riservate ai corrispondenti e ai giornalisti non erano per il danno che la loro informazione produceva, quanto per il fatto che bisognava far capire anche al farmacista, al medico e alle altre categorie che nel paese venivano assoggettate al potere della famiglia mafiosa, compresa quella dei giornalisti, che dovevano stare dentro alcuni confini».
«Ricordo che nel mio giornale io litigavo spesso con i miei superiori, con i miei caporedattori. [...] Noi avevamo gente col terzo ergastolo ma che nei titoli era ancora «presunto colpevole», «presunto boss». [...] Quello era il modo in cui tu dicevi al boss che, se anche dovevi raccontare il suo arresto o la sua incriminazione, il livello di rispetto veniva mantenuto».Pag. 62
Se da un lato Pollichieni riconosce che l'informazione calabrese più attenta ha saputo cogliere gli indizi sull'espansione della ‘ndrangheta fuori dalla regione senza dover attendere le inchieste delle procure del nord Italia, sul clima complessivo in cui si trovano ad operare oggi molti suoi colleghi il suo giudizio è preoccupato.
«La sovraesposizione di alcuni giornalisti è spesso frutto come in ogni categoria – dalla polizia ai magistrati, alla politica, agli amministratori locali – anche e soprattutto [...] del comportamento di altri giornalisti. C’è un giornalismo che attacca le procure per quello che non fanno e c’è un giornalismo che attacca le procure per quello che fanno". Un'opinione particolarmente netta che – è doveroso qui riportarlo – non è condivisa da altri giornalisti ascoltati dal nostro Comitato.
L'audizione di Pollichieni è stata anche lo spunto per approfondire alcune vicende specifiche sul quotidiano Calabria Ora. Il quotidiano, che ha sospeso le pubblicazioni, è stato oggetto di una vicenda complessa con esiti giudiziari tutt'ora non risolti. E con operazioni editoriali che hanno documentato l'estrema vulnerabilità dei giornalisti e della loro professionalità (è doveroso ricordare i numerosi cronisti di Calabria Ora che hanno subito minacce dalla ‘ndrangheta in questi anni: Angela Corica e Agostino Pantano della redazione di Gioia Tauro, il capo servizio della redazione di Vibo Valentia Pietro Comito, Fabio Pistoia, Guido Scarpino, Ilario Filippone, Lucio Musolino...).
Il primo numero di Calabria Ora fu pubblicato il 14 marzo 2006. Primo direttore fu Paride Leporace, giornalista proveniente da Il Quotidiano della Calabria. Il presidente del consiglio di amministrazione della società editrice era Fausto Aquino, vicepresidente nazionale della Piccola Industria. La sede centrale de l'Ora della Calabria era a Cosenza, con diverse redazioni distaccate nelle altre province calabresi. Il 10 aprile 2007 Paride Leporace lascia l'incarico per assumere la direzione de il Quotidiano della Basilicata. Diventa direttore Paolo Pollichieni, fino ad allora responsabile della redazione romana.
«Io parlai chiaro con gli editori, ma soprattutto con la redazione: «Fino a quando io sarò in grado di garantire l'autonomia della redazione, resterò. Il giorno in cui non sarò in grado di garantire l'autonomia della redazione, me ne andrò». Lì abbiamo commesso, forse, un'ingenuità. Abbiamo pensato che, in un tempo di crisi, nel momento in cui il giornale cresceva e faceva utili, più si sarebbe irrobustito economicamente, più noi avremmo conquistato autonomia. È stato un errore, ma questo riguarda tutti gli editori calabresi, perché l'obiettivo non è vivere raggiungendo il break even o guadagnando con il proprio prodotto editoriale. [...] Quasi tutti gli editori di giornali calabresi hanno interessi nell'edilizia, o nella sanità».
«Portammo questo giornale a 11 mila copie, mentre il punto di pareggio era 9.000. Lo portammo a un partenariato con il Sole 24 Ore. Il giornale era in ottima salute, tanto da creare anche qualche problema e qualche fibrillazione ai giornali concorrenti. [...] L'editore si chiamava Piero Citrigno. Mi chiama e mi dice: «Il giornale sta andando bene. Investiamo. Nel giornale io, però, ci devo mettere naso». Io ho ribattuto: «Piero, se tu vuoi il giornale, è tuo. Se tu vuoi metterci naso, me lo dici e io me ne vado. Non creo nemmeno casino, però me ne vado». Pag. 63Lui ha detto: «Va bene, allora te ne devi andare». Sono entrato, quindi, per una promozione e sono uscito senza più un posto. Era il 20 luglio del 2010. Le elezioni regionali erano state a maggio. A ottobre del 2010 la famiglia Citrigno ha avuto concessioni per nove
cliniche, che si aggiungevano a quelle che aveva già. Saranno tutti fatti assolutamente sganciati da un'idea o da un progetto, ma sono fatti che hanno questa sequenza cronologica».
«Nell'ultimo giorno in cui io scrivo, redigo il mio editoriale, in cui spiego pubblicamente le ragioni. Non è mai successo in Calabria e questo lo rivendico. Non ce ne siamo andati in punta di piedi. Abbiamo detto: «Ce ne andiamo perché la linea del giornale è questa». [...] Scrivemmo anche quel giorno uno scoop, che è stato poi ripreso da molti, sugli incontri milanesi, su Paolo Martino e Giuseppe Scopelliti. Paolo Martino, per capirci, è stato condannato con sentenza definitiva e ha anche collaborato, dopo altre condanne che ha avuto. Era ambasciatore delle cosche della ‘ndrangheta reggina a Milano... Quella sera fu la prima volta che la tipografia De Rose si guastò [...] per il fondo col quale noi lasciavamo il giornale e per l'articolo di Paolo Martino assieme a Scopelliti. Il tipografo, che aveva questa tipografia con un tasso di “sensibilità” molto alto, subito dopo
venne nominato da Scopelliti presidente della Fincalabra. [...] Il giornale arrivò in edicola nella sola edizione di Catanzaro, non nelle tre edizioni, tant’è che su questo poi si innescò una polemica. Dopodiché, davanti alla nostra reazione l'editoriale fu ripubblicato il giorno dopo, ma il pezzo su Paolo Martino no».
A dirigere il giornale al posto di Pollichieni viene chiamato Piero Sansonetti. La sua direzione incrocia un'altra vicenda che questo Comitato ha voluto approfondire: le minacce e il successivo licenziamento del giornalista di Calabria Ora Lucio Musolino. Il Comitato ha audito (46) Musolino chiedendogli di ricostruire i fatti che portarono al licenziamento di Pollichieni e, successivamente, al suo allontanamento.
«Nel giugno 2010 scatta l'operazione «Meta» e decidiamo di pubblicare con il giornale un'informativa inserita nel fascicolo, in cui spuntano anche alcuni rapporti tra politici e gli indagati. Lì erano finite le intercettazioni di alcuni consiglieri comunali con il boss Cosimo Alvaro; l'ex sindaco di Reggio ed ex governatore Giuseppe Scopelliti è stato a un pranzo con l'imprenditore Barbieri, condannato per mafia, e con il boss Cosimo Alvaro di Sinopoli. Noi che cosa abbiamo fatto ? Noi abbiamo semplicemente pubblicato il contenuto di un'informativa, il virgolettato di un'informativa. Il mio direttore, come dicevo, è stato invitato a dimettersi o comunque si è dimesso dopo aver rotto con l'editore. Io decido di non farlo perché per me era anche un posto di lavoro, ero assunto a tempo indeterminato».
«Dopo tre giorni dalle dimissioni del mio ex direttore mi arriva una prima lettera anonima in redazione: «Ora chi ha tenuto la mano a Pollichieni in questi anni se ne deve andare. Pensate che gli editori vi dicono qui ci sono i soldi e fate il giornale che volete ? Non funziona così» o una cosa del genere. All'epoca ho portato questa lettera anonima Pag. 64in questura. [...] Passa un'altra settimana. È il primo agosto del 2010. Rientro a casa alle quattro del mattino, era il mio primo giorno di ferie, e trovo una bottiglia di benzina accompagnata da un altro biglietto stavolta lasciato non in redazione ma nel cortile della mia abitazione, in cui mi si invitava espressamente a seguire Pollichieni. La bottiglia era piena di benzina ed era specificato che la benzina serviva per me e non per la macchina, perché a Reggio c'era quest'usanza dell'autocombustione
delle macchine. Allora ho chiamato subito la polizia e ho depositato anche la prima lettera. Ho detto: “Se può essere utile, qui c’è la prima lettera”».
«Intanto era cambiato il direttore, c'era Piero Sansonetti. Nei mesi estivi, subito dopo le ferie, dall'editore e da Piero Sansonetti mi arrivavano sempre più inviti ad accettare un trasferimento a Lamezia Terme o a Catanzaro. Un trasferimento che io non ho accettato arrivando quasi allo scontro con Sansonetti; uno scontro che poi nel giro dei mesi è aumentato fino ad arrivare addirittura al fatto che i pezzi che io mandavo alla redazione centrale il giorno dopo venivano pubblicati con i nomi cancellati, nei verbali dei pentiti venivano modificate le dichiarazioni...».
«Il 7 ottobre a Reggio viene Anno Zero e c’è la puntata dedicata ai giornalisti minacciati. Non li avevo contati, ma mi hanno detto che io ero il ventitreesimo giornalista minacciato solo nel 2010, ed eravamo ancora ad agosto. In quella puntata ho detto le stesse cose che avevo detto in questura, cioè «io non so chi ha messo la bottiglia di benzina nel cortile della mia abitazione; non lo so, se l'avessi saputo sarei andato a denunciarlo, come ho fatto altre volte; so solamente cosa ho scritto prima». Ho raccontato un'altra volta il discorso del processo «Meta», tutti i rapporti con la politica... Il giorno dopo il giornale mio, Calabria Ora, non esce in edicola. Misteriosamente le famose rotative di Umberto De Rose, dopo la puntata di Anno Zero, si rompono. Esce il giorno successivo, il 9 ottobre, con il titolo sulla prima pagina «Antimafia sì, forcaioli no». Il
mio giornale, il mio direttore mi aveva dato del forcaiolo ! [...] Mi metto in ferie e mentre sono in ferie noto subito che la mia casella di posta elettronica è stata bloccata dal mio giornale; ho denunciato l'editore perché il tecnico del giornale mi ha detto che l'editore ha disposto la cancellazione delle mail della mia casella di posta elettronica, dove c'erano le fonti e dove qualcuno ha avuto la possibilità di entrare. Dopo qualche ora la redazione reggina di Calabria Ora riceve un fax dalla redazione centrale con cui l'amministratore del giornale dice che, siccome si è rotto il rapporto di fiducia tra me e il direttore, io ero licenziato. Con un fax, mentre ero in ferie, senza alcuna contestazione prima».
«Vengo licenziato in tronco e ricorro al giudice del lavoro, che accoglie la richiesta di procedura d'urgenza per il reintegro. Non vengo reintegrato, cioè il mio giornale disattende la decisione del giudice [...] e dopo tre anni e mezzo si arriva a una sentenza definitiva. Il tribunale del lavoro dice che io devo essere risarcito di 54 mila euro più 15 mensilità. Di quei soldi non ho visto una lira, né tanto meno sono stato reintegrato, perché nel frattempo il giornale ha svuotato una società, ne ha costituito un'altra, ha travasato dipendenti e beni nella nuova, lasciando in vita la vecchia. [...] Dopo il licenziamento sono nuovamente invitato ad Anno Zero, racconto di nuovo dei rapporti tra la politica Pag. 65e la ‘ndrangheta e dopo quella puntata il governatore Scopelliti mi chiede un milione di euro».
«Quanto al mio rapporto con Sansonetti, lui ha provato ad avere un buon rapporto con me, però evidentemente la mia permanenza a Calabria Ora aveva i mesi contati. Questo già lo avevo percepito perché il clima era quello, sia perché mi è arrivata due volte la richiesta di trasferimento sia perché io mi lamentavo dei pezzi e non ricevevo alcuna risposta. Per ogni pezzo modificato inviavo una mail al direttore, alla redazione, a chi impaginava, ma non ricevevo alcuna spiegazione sul perché... Le faccio un esempio. Una sera di settembre – il giorno preciso non lo ricordo – del 2010, avevano appena eseguito l'operazione Agatos a Reggio, un'operazione contro la cosca Tegano. Arrestato Roberto Moio, nell'interrogatorio di garanzia decide di collaborare. [...] Ho dato la notizia e se non ricordo male qualche giorno dopo sono riuscito ad avere anche un po’ di virgolettati. Il pentito
Moio diceva «La ‘ndrangheta a Reggio vota a destra» e il giorno dopo mi ritrovo l'articolo con il virgolettato «la ‘ndrangheta a Reggio vota a destra perché è la parte politica che governa, altrimenti voterebbe a sinistra». [...] Accade che io lamento il trattamento ricevuto dalla redazione centrale attraverso e-mail; comunico al direttore, ai capiredattori, al Cdr e ne parlo anche a voce con i colleghi della redazione reggina. Ma i colleghi che mi erano più vicini al massimo facevano spallucce, proprio per il discorso che molti giornalisti in Calabria sono condizionati perché o fai quello o non fai nulla; mentre da parte della redazione centrale, di chi aveva il compito di darmi delle spiegazioni, le spiegazioni non arrivavano. Non arrivava nessuna spiegazione. [...] Con il direttore, dopo il primo tentativo di trasferirmi, si era rotto il rapporto. Non riuscivamo neanche a parlare senza litigare. Quando lui, a
poche settimane dall'intimidazione subìta, in cui qualcuno mi invitava a lasciare Reggio, mi ha proposto di lasciare Reggio, io gli ho risposto «è la stessa proposta che mi ha fatto la ‘ndrangheta, a lei ho detto di no, quindi...». Lui mi ha detto che l'ho accusato di essere mafioso, ma poi la cosa è rientrata, nel senso che non ci siamo mai presi, come colleghi».
Dopo il licenziamento, la FNSI si mobilita per Musolino. Reazioni tiepide, invece – ricorda il giornalista – all'interno del Comitato di redazione di Calabria Ora.
«L'atteggiamento del sindacato ? Se per sindacato si intende la Federazione nazionale della stampa, questa mi è stata sempre al fianco. [...] Per quanto riguarda, invece, il famoso comitato di redazione del giornale, che doveva comunque avallare e dare anche un parere sui licenziamenti, è vero che formalmente ha dato un parere negativo, però è anche vero che quando io sono stato licenziato il comitato di redazione ha scritto un comunicato stampa per dire “la giustizia faccia il suo corso”».
Il Comitato ha dedicato una lunga audizione al giornalista Piero Sansonetti (47) su questo e su altri punti, e più complessivamente sullo stato di salute del giornalismo in Calabria. Sul licenziamento di Musolino, riportiamo integralmente lo scambio di battute con Sansonetti:
«PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Sono sceso in Calabria a dirigere Calabria Ora nel luglio del 2010. Precedentemente, non conoscevo la Calabria, anzi era la regione del sud che conoscevo di meno. Mi fu chiesto di dirigerla dagli editori, all'epoca Piero Citrigno e Fausto Aquino. [...] Successivamente, alla fine del 2013, sono entrato in contrasto con gli editori per una vicenda che, a quanto risulta a me, riguardava la ristrutturazione del giornale. [...] Da quel momento, ho iniziato a lavorare per fare un altro quotidiano, che fosse nazionale e che poi ho fatto, Il Garantista, ma che avesse un fortissimo radicamento in Calabria che rappresenta più del 90 per cento del nostro mercato [...] Entrai rapidamente in scontro con Musolino per motivi professionali. Non riuscivo a dirigere. Io gli chiedevo di fare il cronista e lui commentava. Ci furono rapporti molto difficili tra lui e la redazione, in particolare quelle di Reggio Calabria e di Cosenza. In quella fase, durante una ristrutturazione del giornale proposi a Musolino, se non ricordo male, di andare a Lamezia, perché volevamo rafforzare la redazione di Lamezia. Adesso non ricordo benissimo, anche perché erano i primissimi tempi che ero lì. Credo che tutto ciò avvenga nel primo mese e mezzo della mia permanenza a Calabria Ora. Ricordo una sua risposta al telefono, che penso lui stesso abbia confermato, che mi fece molto arrabbiare, perché mi disse che la mia proposta era irricevibile in quanto veniva dalla ‘ndrangheta. Diciamo che non fui molto contento di quella risposta, perché...
PRESIDENTE. Per la precisione, almeno per riportare le frasi di Musolino, dice che era la stessa proposta che gli fu fatta dalla ‘ndrangheta, che il 1o agosto – diciamo anche questo per la cronaca – gli aveva lasciato una bottiglia di benzina accanto all'automobile con la scritta: «Questa bottiglia di benzina è per te e non per l'automobile». Parliamo, quindi, anche di un cronista che era stato pesantemente minacciato pochi giorni prima.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Esattamente di questo tenni conto, che non si trattava di un giornalista qualunque, ma di uno che faceva il giudiziario...
PRESIDENTE. La mia domanda era un'altra. La ragione di trasferimento ad altra sede per un giornalista minacciato.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Gliel'ho detto. Aveva pessimi rapporti con la redazione di Reggio, a quel punto cattivi rapporti anche con me e con la redazione di Cosenza, e quindi nella ristrutturazione pensammo a questa iniziativa.
PRESIDENTE. C’è un altro punto. Il fatto che si trattasse di un giornalista che aveva ricevuto una minaccia...
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Ne tenni assolutamente conto.
Pag. 67PRESIDENTE. Nel modo, però, opposto. Generalmente, come almeno è stato detto da diversi direttori, quando un giornalista è stato minacciato, fanno di tutto perché non vada via, perché è fondamentale dare la sensazione che quel giornalista abbia la redazione alle spalle e che il luogo e il territorio del suo lavoro restino quelli in cui ha ricevuto le minacce.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Le spiego come andarono le cose. Gli feci questa proposta e lui mi rispose in questo modo decisamente brusco. Era stato presentato, nel frattempo, un piano di ristrutturazione, nel quale si prevedeva lo spostamento di Musolino. Questo piano fu bloccato dopo la sua risposta e lo spostamento di Musolino fu cancellato.
PRESIDENTE. Per ricostruire la cronaca della vicenda, non tralasciando nessun passaggio, abbiamo il direttore del giornale che si dimette, otto giornalisti che si dimettono, in quei giorni Musolino riceve una minaccia precisa e personale e poi gli viene proposto un trasferimento: ci piacerebbe capire come questa concatenazione, fino alla richiesta del trasferimento, sia stata valutata dalla direzione.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Avevo esattamente questo problema, di ricostruire un clima di collaborazione e di ragionevolezza in un giornale che era...
PRESIDENTE. Ma la preoccupazione per le sorti personali, la salute fisica, l'incolumità di Musolino, è stata mai presente ?
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Sono andato a fare il direttore lì, non il poliziotto. Sono andato a fare il direttore e ho cercato di fare le cose...
PRESIDENTE. Se un suo giornalista viene minacciato, non deve fare il poliziotto, ma il direttore del giornale.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Certo, e ho ritenuto ragionevole spostarlo per evitare gli screzi, evitargli la situazione che si era creata ed evitare anche la situazione di grande difficoltà che c'era nei rapporti con l'editore, con la redazione in cui lavorava, di Reggio Calabria, e con gli altri giornalisti. Posso anche aver sbagliato. Tanto posso aver sbagliato che cinque giorni dopo, mandando giù l'accusa di essere uno ‘ndranghetista, decido di non spostare Musolino. Decido di non spostarlo e comunico al comitato di redazione, quindi in forma ufficiale, il piano nel quale Musolino non sarà spostato. Non so cosa abbia dichiarato Musolino, ma non so chi gli abbia detto, invece, in quelle stesse ore che lui era stato spostato. Ci sono i documenti che dimostrano che non era stato spostato. Musolino, se non ricordo male, dice in televisione o fa una dichiarazione all’Ansa dicendo le ragioni per cui lo avrei spostato, io mi... innervosisco e faccio una cosa molto semplice: lo querelo, perché ha dichiarato delle cose false all’Ansa e infamanti nei miei confronti. Pag. 68La vicenda si è conclusa pacificamente pochi mesi fa, quando ci siamo incontrati. Lui mi ha chiesto di ritirare la querela e io gliel'ho ritirata.
PRESIDENTE. Scusi, da chi viene licenziato Musolino ?
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Dall'editore, che gli manda una lettera di licenziamento. Lui ricorre immediatamente.
PRESIDENTE. Cosa fa il direttore di fronte alla lettera di licenziamento di un proprio redattore ?
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Se un editore licenzia un suo lavoratore, il direttore può dimettersi. Potevo dimettermi, ma non lo ritenni opportuno.
PRESIDENTE. Il 7 ottobre, a Reggio arriva la troupe di Annozero. C’è una puntata dedicata ai giornalisti minacciati. Tra i tanti giornalisti, viene intervistato anche Musolino, che racconta le minacce che ha ricevuto qualche settimana prima. Il 9 ottobre, dal momento che l'8 il giornale non esce, il titolo sulla prima pagina – siamo in un periodo precedente al licenziamento di Musolino – è «Antimafia sì, forcaioli no»: ci racconta cosa voleva rappresentare questo titolo ?
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. C'era anche un articolo sotto piuttosto ampio.
PRESIDENTE. Siccome non possiamo leggerlo tutto, volevamo che ce lo sintetizzasse.
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Spiegavo che il giornalismo antimafia non è il giornalismo giustizialista e forcaiolo, che la mafia si combatte con lo Stato di diritto. È una mia vecchia idea.
PRESIDENTE. Musolino si riconobbe in questo suo editoriale. Era una sua impressione o davvero lei si riferiva a Musolino ?
PIERO SANSONETTI, direttore del quotidiano Il Garantista. Non potevo assolutamente riferirmi a Musolino, perché la polemica era molto più complessa. Non ricordo adesso esattamente l'editoriale. Ne ho scritti decine, molti sullo stesso tema... Le dico la verità: di tutte le cose che mi ha detto, su nulla tornerei indietro, su nulla. Penso di aver fatto bene tutto. [...] l'unica cosa sulla quale posso, invece, pensare di aver fatto una stupidaggine è stato nel non oppormi frontalmente al licenziamento di Musolino, che pure era un elemento quasi ingestibile, perché non seguiva le indicazioni, lavorava solo con dei verbali suoi, non faceva lavorare gli altri. Ciononostante, penso di aver fatto un errore».
Pag. 69 Il Comitato ha voluto approfondire anche la vicenda di Maria Concetta Cacciola e del modo in cui il suo caso è stata affrontato dall'informazione calabrese.
Maria Concetta Cacciola era una testimone di giustizia, una delle prime che avesse deciso di rompere i muro di omertà familiare che in Calabria protegge la ‘ndrangheta. Decide di collaborare con i magistrati, poi improvvisamente ritratta e «si uccide» ingerendo acido muriatico: in una lettera accusa i magistrati di averle «estorto» sulla sua famiglia accuse che non rispondevano alla verità.
La vicenda è stata ripercorsa in audizione dal dottor Giovanni Musarò (48), sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Roma, all'epoca dei fatti in forza presso la DDA di Reggio Calabria.
«Maria Concetta Cacciola apparteneva a una famiglia di ‘ndrangheta di Rosarno, i Cacciola, che sono una sorta di braccio armato dei Bellocco. [...] Questa ragazza senza essere mai stata oggetto di attenzione investigativa da parte nostra si presenta presso la stazione dei Carabinieri di Rosarno l'11 maggio del 2011. Andiamo a sentirla il 25 maggio 2011 io e la collega Alessandra Cerreti. Ricordo che in questo primo verbale lei parlò di una serie di omicidi di cui mi ero occupato io e di uno in particolare che purtroppo era rimasto insoluto. Mentre parlava io mi rendevo conto che gran parte delle cose che diceva erano già riscontrate dalle indagini, quindi era attendibile. Questo verbale sarà durato due ore ma è stato un calvario, perché lei era terrorizzata perché doveva andare via, perché non poteva giustificare un'assenza di due ore da casa e i familiari sospettavano che avesse un amante. Quindi
viene messa sotto protezione il 29 maggio del 2011. Succede però che i familiari riescono a rimettersi in contatto con lei, approfittando del fatto che aveva tre figli minorenni a Rosarno. La costringono a tornare a Rosarno, la costringono a registrare una ritrattazione delle dichiarazioni che aveva reso a noi. [...] In una telefonata terrificante con una sua amica dice: «so che succede: io torno, mi fanno ritrattare e poi mi ammazzano, ma io ho paura a tornare, però non posso non tornare perché devo tornare per i miei figli» e succede esattamente questo, con la «chicca» che simulano un suicidio. Lei torna a Rosarno il 9 agosto, fa questa registrazione il 12 agosto, è terrorizzata, contatta i carabinieri del ROS che erano il suo anello di congiunzione con il servizio centrale, chiede di tornare nel programma ma quando sembra tutto pronto per tornare ci sono due giorni di silenzio telefonico e poi la trovano morta per aver
ingerito acido muriatico, che purtroppo è anche un gesto evocativo, cioè una fine che viene riservata ai collaboratori di giustizia, a chi parla troppo.».
La svolta sulla ritrattazione e sulla morte di Maria Concetta Cacciola arriva però quasi subito: l'avvocato Pisani, uno dei due legali che l'avevano assistita nella sua «ritrattazione», viene arrestato e decide di collaborare confermando che quella ritrattazione fu una messa in scena organizzata dalla famiglia della ragazza. Ciò che interessava al lavoro di questo Comitato è anche l'evidenza con cui quella «ritrattazione» fu raccolta e raccontata sui giornali calabresi. Ricostruisce il sostituto procuratore Musarò: «Pisani è stato condannato in abbreviato e ha iniziato a collaborare. La collaborazione di Vittorio Pisani è stata particolarmente soddisfacente [...] e Pisani ci ha Pag. 70parlato dei rapporti con la stampa. Qualche giorno dopo (la morte della Cacciola, ndr) partì una campagna stampa molto pesante su un
quotidiano, l'Ora della Calabria. Erano degli articoli in esclusiva fatti per giorni e il titolo era: «Cronaca di un suicidio annunciato». Veniva attaccata pesantemente la DDA di Reggio Calabria, il modo in cui era stata gestita, e veniva pubblicato un esposto dei familiari in cui gli inquirenti venivano accusati di aver approfittato di una depressione psichica di Maria Concetta Cacciola, che poi si è accertato non essere mai esistita, di averle prospettato la possibilità di un futuro migliore se avesse reso una collaborazione che, come scrivevano in questo esposto, “mai avrebbe potuto rendere”».
«All'esposto pubblicato su questo giornale erano allegate la trascrizione della ritrattazione e una lettera. Questa lettera è stata artatamente allegata dai familiari all'esposto, cioè sembravano le ultime volontà di una persona che decide di suicidarsi, che quindi registra una ritrattazione, dice di aver detto cose inventate, [...] Poi si scopre facilmente che questa lettera di addio non l'aveva scritta prima di suicidarsi, ma l'aveva scritta a maggio, prima di andare via da Rosarno quando era stata messa sotto protezione. In dibattimento l'avvocato Pisani, sentito come collaboratore, ha raccontato che mentre redigevano questo esposto, l'avvocato Cacciola era in contatto con la stampa, non solo con l'Ora della Calabria, ma anche con La Gazzetta del Sud, con i due direttori ai quali preannunciava l'invio di questo materiale prima o in concomitanza con il deposito dell'esposto. [...] l'avvocato Pisani in
dibattimento ha detto chiaramente che il fine dei Cacciola era quello di utilizzare la stampa per delegittimare il modo in cui venivano gestiti i collaboratori di giustizia dalla DDA di Reggio Calabria in quel momento storico».
Sul punto il direttore Sansonetti ha spiegato al Comitato: «Ricordo che eravamo stati informati che c'era questo documento, che lo abbiamo aspettato. Non so se una volta abbiamo telefonato per sapere se arrivasse o meno, ma secondo me no. [...] Poi il documento arrivò e lo pubblicammo».
Altro caso controverso è quello di Giuseppina Pesce, collaboratrice di giustizia proveniente da una delle famiglie più altolocate della ‘ndrangheta. Anche la Pesce inizia a collaborare e poi ritratta. Ma anche in questo caso si scoprirà che la ritrattazione è stata imposta alla ragazza dalla sua famiglia. Ha ricostruito il dottor Musarò al Comitato: «Giuseppina Pesce, che apparteneva alla famiglia Pesce, altra famiglia importante di Rosarno, era una collaboratrice di giustizia. Era stata arrestata nell'operazione “All Inside” dell'aprile 2010 e dopo sei mesi di detenzione aveva scritto alla DDA di Reggio Calabria e aveva iniziato a collaborare. [...] A distanza di alcuni mesi, nell'aprile 2011, Giuseppina Pesce invia una lettera al GUP di Reggio Calabria in cui dichiara di ritrattare le accuse, di aver detto cose non vere, e utilizza anche un'espressione: le domande che le venivano poste durante gli
interrogatori contenevano un'esplicitazione per cui «...più accusi i tuoi familiari, più sei credibile, ma io mi vergogno di quello che ho fatto, mi sento usata».
«L'avvocato Pisani ha detto che nella vicenda della Pesce è successa sostanzialmente la stessa cosa, cioè lei fu avvicinata dai familiari, convinta a uscire dal piano di protezione. [...] I cognati portano a Pag. 71Giuseppina Pesce una lettera dattiloscritta, scritta dall'avvocato Giuseppe Madia del foro di Palmi, che lei doveva copiare a mano e inviare al GUP. [...] Questa lettera – che non è scritta da lei – viene inviata al GUP, poi pubblicata su Calabria Ora il 28 aprile 2011. [...] l'articolo si concludeva in questo modo: «è evidente, racconta l'avvocato Madia, che la signora Pesce non ha detto la verità, ha solo detto quello che i magistrati volevano che dicesse». Dopo due mesi e mezzo Giuseppina Pesce viene arrestata per evasione, chiede di essere interrogata, ritorna a collaborare e racconta tutto [...] La Pesce disse
che la lettera è stata trasmessa alla stampa dal suo difensore, l'avvocato Madia, e che lui teneva i contatti con il quotidiano Calabria Ora. La lettera sarebbe stata data a Sansonetti perché l'avvocato diceva che era l'unico disposto a pubblicargliela e a sposare la loro causa».
Ricostruisce così l'episodio Sansonetti: «Sicuramente a darci l'informazione fu l'avvocato, come è normalissimo, della signora Pesce. Ricordo la lettera, autografa, scritta dalla signora Pesce, nella quale sostanzialmente diceva di essere stata indotta a confessare per il problema dei figli. Non ricordo, ma forse era nel carcere di Milano all'epoca e chiese di essere trasferita nel carcere di Lecce. Nella lettera sosteneva – cito a memoria, ma la lettera c’è, quindi si può riscontrare – che le era stato detto che poteva avere il trasferimento, quindi rivedere i figli, solo se avesse collaborato. [...] La ritrattazione era vera, non falsa. Non abbiamo pubblicato un falso, ma la pura verità, la ritrattazione di queste due testimoni di giustizia, punto e basta, così come spesso i giornali pubblicano la pura verità, le informative dei ROS, che talvolta, anzi molto spesso, si rivelano false,
ma non chiedono scusa. [...] Nel momento in cui ci fu la ritrattazione, era vera e il giornalista deve pubblicare ciò che sa».
Resta il fatto di due donne costrette a ritrattare dalle loro famiglie mafiose. E di una terra, la Calabria, drammaticamente avara di testimoni e di collaboratori di giustizia. Una terra in cui scrivere in prima pagina che la procura avrebbe costretto al «pentimento» due donne non può non avere conseguenze sul piano della formazione dell'opinione pubblica.
Il Comitato ha voluto approfondire il punto con il direttore Sansonetti chiedendogli perché fu dato tale rilievo a quelle notizie in un tempo in cui era persino auspicabile che ci fossero testimoni o collaboratori di giustizia disposti a scardinare all'interno di una famiglia mafiosa il patto di impunità e di omertà. Questa la sua risposta al Comitato: «Qui devo fare un ragionamento un po’ più complesso su tre punti. Il terzo è il più drammatico. Il primo è la mia opinione personale, che non conta molto. Penso che, soprattutto negli ultimi anni, la gestione dei pentiti non sia stata eccellente da parte di gran parte della magistratura, come ho provato a dimostrare anche in quell'interrogatorio sicuramente forzato che è stato fatto del pentito Pisano nei miei confronti. Penso che spesso i pentiti siano indotti a parlare e che non sempre siano credibili».
«La seconda questione sempre generale riguarda il ruolo della stampa. Anche in una terra come la Calabria, credo che la stampa debba essere equanime e stare sempre dalla parte dello Stato del diritto. Non ho mai pensato a una stampa che si arruola, si mette l'elmetto e diventa embedded, come si dice adesso, della magistratura. Non credo che abbia Pag. 72un fine etico. La stampa deve riportare quello che ha e la difesa e l'accusa sono sullo stesso piano. Le veline che la procura spesso passa ai giornali, non sempre a tutti, ad alcuni più che ad altri, sono sullo stesso piano di ciò che passano gli avvocati difensori. Se l'avvocato difensore della signora Pesce mi passa un documento assolutamente oggettivo, ho il dovere di pubblicarlo. [...] Non ho avuto nessun rapporto particolare con gli avvocati, tranne aver ricevuto delle lettere, dei documenti e averli fatti
verificare dai miei collaboratori. [...] È vero piuttosto che avevamo un rapporto difficile con la procura e che, quindi, avevamo meno notizie degli altri. Altri giornali avevano tutte le veline della procura, non c’è dubbio. Noi ne avevamo di meno, e quindi da questo punto di vista eravamo svantaggiati».
«La terza questione riguarda la situazione della gestione dei pentiti in quel momento in Calabria, che era molto complessa. [...] La nostra sensazione netta era che l'uso dei pentiti fosse alquanto spregiudicato. In alcuni casi avevamo ragione, in altri probabilmente torto».
Il 5 agosto 2013 il quotidiano cambia la sua testata da Calabria Ora a l'Ora della Calabria. l'editore Alfredo Citrigno annuncia contestualmente un piano editoriale con la necessità di ridurre i costi per non rischiare il tracollo. Il direttore Piero Sansonetti viene sollevato dall'incarico e al suo posto è nominato direttore Luciano Regolo.
Otto mesi più tardi, nella serata di venerdì 18 aprile 2014, il direttore Regolo annuncia che il giornale non verrà più pubblicato. La decisione, presa dal liquidatore della società editrice Giuseppe Bilotta, è stata comunicata al direttore Luciano Regolo tramite e-mail motivandola con l'esigenza di «non gravare con ulteriori spese di stampa il bilancio». Il direttore riterrà «pretestuosa» quella motivazione ritenendo che la sospensione improvvisa della pubblicazione dell’Ora sia motivata dall'intenzione di «mettere i bavagli alla redazione» del quotidiano.
La chiusura del quotidiano calabrese era stata preceduta, il 19 febbraio, da un singolare e inquietante episodio. L'Ora della Calabria quel giorno sarebbe dovuta uscire con la notizia di un'indagine della procura di Cosenza per abuso d'ufficio, falso ideologico e associazione a delinquere a carico di Andrea Gentile, figlio del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Antonio Gentile. Quel giorno il giornale non arriverà in edicola, bloccato in tipografia da un presunto guasto alla rotativa, denunciato dal proprietario della tipografia Umberto De Rose. Nel pomeriggio il direttore Luciano Regolo in una conferenza stampa affermerà di aver subito forti pressioni da parte del proprietario della tipografia perché il giornale non andasse in stampa con l'articolo sul figlio di Gentile. Nel corso della conferenza stampa, Regolo rende noto l'audio di una telefonata avvenuta la sera prima tra l'editore del giornale Alfredo Citrigno e
il tipografo De Rose. Dalla telefonata emerge con chiarezza che De Rose suggerisce con insistenza a Citrigno di togliere l'articolo e di non «inimicarsi» la famiglia Gentile. L'episodio è stato oggetto di un'inchiesta della procura delle Repubblica di Cosenza che si è conclusa con l'iscrizione di un procedimento penale nei confronti di Umberto De Rose per il reato di violenza privata. Nel corso delle indagini è stata disposta una consulenza tecnica sui macchinari che ha tassativamente escluso qualsiasi guasto alle rotative la sera del 19 febbraio 2014.Pag. 73
Due mesi dopo, il 26 maggio 2014 il tribunale per le misure di prevenzione di Cosenza ha disposto la confisca dei beni di Pietro Citrigno (il vecchio editore di Calabria Ora), del figlio Alfredo e dei loro familiari. La confisca era anche in esito a una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per usura, divenuta definitiva il 21 giugno 2011, nei confronti di Pietro Citrigno. Il 22 luglio 2015, correggendo la precedente decisione del tribunale, la Corte d'Appello di Catanzaro ha ordinato il dissequestro dei beni dell'editore Citrigno.
L'editore Citrigno è stato chiamato a rispondere anche di violenza privata nei confronti di Alessandro Bozzo, il giornalista di Calabria Ora che si è tolto la vita, appena quarantenne, il 15 marzo 2013. Secondo i magistrati della procura di Cosenza, che ne hanno disposto il 28 gennaio 2014 il decreto di citazione diretta a giudizio, Citrigno avrebbe imposto al giornalista «mediante minaccia» di rinunciare ai benefici del contratto di lavoro a tempo indeterminato come condizione per conservare il posto al giornale. «Citrigno Piero disse chiaramente che chi voleva continuare a lavorare doveva dimettersi e accettare il nuovo contratto ma alle sue condizioni [...] Da quel momento Alessandro precipitò in uno stato di frustrazione che gli fece perdere anche la passione per il proprio lavoro» (49). La relazione di Ossigeno per l'informazione, acquisita agli
atti della Commissione, lo ricorda così: «Bozzo era un redattore scomodo, metteva il naso in vicende di appalti e di corruzione che disturbavano lo svolgimento di affari poco chiari. Secondo numerose testimonianze, l'editore avrebbe costretto Alessandro Bozzo a risolvere il suo contratto a tempo indeterminato con Calabria ora per trasformarlo in uno a tempo determinato. L'azione, secondo i testi e la procura, non si limitò a questo, ma passò per una costante azione tendente a liberarsi di un giornalista scomodo». Il processo è pendente in sede dibattimentale presso il tribunale di Cosenza.
Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, audito sull'insieme delle vicende analizzate e sui risvolti che esse potevano avere sul piano della deontologia professionale, ha ammesso che poco si è fatto (50): «l'ordine dei giornalisti ha, oggi come oggi, dei compiti molto limitati e sempre più limitati. Si può dire che ormai sia diventato semplicemente una sorta di notaio di quel che riguarda gli albi professionali. Quel poco che c'era in termini di autonomia, ad esempio il fatto di intervenire per motivi deontologici, è stato trasferito da poco ai collegi di disciplina». Ma quello calabrese, ci ha confermato Soluri, «...non ha mai istruito casi che riguardino questo fenomeno».
5. Deontologia, contratti, freelance.
5.1) L'Ordine dei giornalisti.
Al termine delle nostre audizioni, il Comitato ha voluto ascoltare il presidente dell'Ordine dei giornalisti e il presidente della Federazione Pag. 74nazionale della stampa per raccogliere una loro valutazione complessiva sulle fragilità della professione di giornalista di fronte alle minacce delle mafie e sui possibili rimedi per restituire autonomia, dignità e sicurezza agli operatori dell'informazione.
Alcuni spunti, tratti dall'audizione di Vincenzo Iacopino (51), presidente dell'Ordine, sono stati già utilizzati nel corso di questa relazione. Qui abbiamo raccolto le sollecitazioni proposte dal presidente Iacopino sui temi più sensibili: la trasparenza degli assetti editoriali e il rischio di un'informazione consociativa con i poteri criminali; le minacce, non solo fisiche, ai giornalisti, portate anche attraverso un uso spregiudicato dei mezzi offerti dal diritto; infine, le condizione di estrema precarietà in cui questa professione si esercita nella maggior parte dei casi, precarietà che rende i giornalisti più esposti al ricatto e alla violenza delle organizzazioni criminali.
Sul primo punto, la proprietà delle testate, quella vera, effettiva, oltre lo schermo eventuale dei prestanome: «Occorre capire quali sono le reali proprietà dei giornali, non solo nel Sud. Se ci diciamo che la criminalità è ovunque, occorre capire di chi sia la proprietà dei giornali con l'istituzione di un registro che non vuole e non deve essere assolutamente limitativo della libera iniziativa. Vogliamo, però, tutelare i cittadini, vogliamo consentire loro di sapere a quale interesse corrispondono alcune iniziative che nascono in maniera precaria...».
Sui rischi di un'informazione poco reattiva, reticente o – peggio – consociativa con i poteri mafiosi, abbiamo voluto ricordare al presidente Iacopino l'accusa che egli lanciò nel 2008, da segretario dell'Ordine, in occasione di un convegno a Casal di Principe: «Cominciamo a parlare dei nostri doveri, di chi per osservarli corre rischi per osservarli e poi subisce attacchi non solo dalla camorra, ma, inspiegabilmente, anche da altri giornalisti. È una vergogna che non possiamo tollerare. Gli ordini regionali si rendano conto che è ora di fare pulizia nelle nostre file e che di fronte a queste cose dobbiamo agire senza indulgenza». Ma, ammette oggi il presidente Iacopino, poco hanno saputo o potuto fare su questo terreno gli Ordini regionali. «Il punto più dolente è la conseguenza – io ritengo non voluta – della riforma degli ordini professionali determinata dal Ministro
Severino per semplificare, che ha creato i consigli di disciplina. Così come sono previsti essi non possono funzionare, non riescono a funzionare. Sono Collegi composti da tre persone. Immaginate in una regione piccola come il Molise – cito quella perché è una delle più piccole – o come la Valle d'Aosta un collegio di tre persone che processa qualcuno che è conosciuto da tutte e tre le persone. Non possono funzionare... Noi abbiamo chiesto di modificare la norma prevedendo che il Collegio diventi di nove persone, ma ci è stato detto che non è possibile così e che ci vuole una modifica legislativa.
[...] Abbiamo già fatto da alcune settimane – stiamo raccogliendo i dati in questi giorni – una ricerca sui consigli di disciplina per avere i dati sui procedimenti disciplinari. Nell'ultima riunione della Consulta con i presidenti e i vicepresidenti degli ordini regionali io ho denunciato che sembra che in Italia l'informazione vada benissimo e che non ci siano violazioni deontologiche perché non abbiamo procedimenti disciplinari. Pag. 75Noi abbiamo un consiglio nazionale di disciplina che è fermo perché non ha ricorsi in appello. Con una battuta che l'interessato mi perdonerà, dico meno male che c’è stato il caso Sallusti, altrimenti il nostro Consiglio nazionale di disciplina non avrebbe potuto fare nulla, perché si è occupato solo – mi pare – di due casi che riguardavano il collega Sallusti. Questa esperienza
è fallimentare. Non so per colpa di chi, ma è sicuramente fallimentare. La legge, così come è stata ipotizzata, non funziona. [...] l'azione di vigilanza non c’è stata. Quasi mai, purtroppo, vengono fatti i procedimenti disciplinari. [...] Io non ho titolo neanche per impugnare un'archiviazione. L'unico che ha questo titolo è il procuratore generale».
Sulle minacce e le violenze subite dai giornalisti, il presidente dell'Ordine ha proposto al comitato una lettura più complessiva: «È riduttivo ipotizzare che l'intimidazione ai giornalisti venga solo dalla mafia, dalla camorra o dalla ‘ndrangheta. Ci sono intimidazioni molto più diffuse... Posso citare tre casi. L'osservatorio Ossigeno per l'informazione ha pubblicato la notizia della condanna dell'ex sindaco di Calvi Risorta, un comune in provincia di Caserta, il quale è stato condannato perché aveva perseguitato con una serie di querele un pubblicista, Vito Taffuri, che peraltro è anche un agente di custodia. L'agente di custodia venne perfino sospeso dal suo lavoro per aver denunciato le collusioni tra la criminalità e l'amministrazione. È una situazione analoga a quella che era avvenuta a Sedriano con Ester Castano. La consideravano tutti matta, fino a quando il Ministero dell'interno
decise di dover sciogliere quel comune per infiltrazioni mafiose. (Per i suoi articoli, la Castano è stata querelata per diffamazione – e prosciolta – dal sindaco di Sedriano, poi arrestato con l'accusa di corruzione, ndr) Da ultimo, Ester Castano ha fatto un colloquio con Burger King per poter pagare l'affitto di casa. Lo dico perché si sappia che c’è un mondo diverso da quello che noi, me compreso, frequentiamo. Ha dovuto fare un colloquio da Burger King, perché i giornali per i quali collaborava, e che le erano valsi le intimidazioni, le minacce e tutto il resto, la pagavano 3 o 4 euro, tasse comprese, ad articolo. [...] Sempre nella mia Calabria un collega (Claudio Cordova, collaboratore del Quotidiano della Calabria, ndr) [...] si è visto chiedere per due articoli 500 mila euro di danni con una lettera da un magistrato (Gerardo Dominijanni, sostituto procuratore presso
la procura di Catanzaro, ndr.): se non avesse pagato 500 mila euro, sarebbe stato portato davanti al tribunale.
Vi immaginate come vivono i colleghi che vedono nella loro cassetta della posta queste raccomandate ? Ricevono la richiesta di centinaia di migliaia di euro di danni veri o presunti per poi magari, a ridosso dell'udienza conclusiva, sentirsi proporre una remissione della querela. Sto parlando di parte penale, perché poi ci sono le citazioni in civile, che sono solitamente molto più, quanto a richieste, onerose. [...] Il pericolo maggiore per i colleghi che onorano questo mestiere e che per questo vengono sottoposti a minacce di ogni tipo, compresa quella della fame, che non trascurerei, è che si spengano i riflettori su di loro» perché «...le criminalità crescono nel buio».
Infine, la marginalità sociale, materiale, di un mestiere sempre meno garantito, sempre più precario. Ricorda Iacopino: «Ci sono più di 10 mila colleghi iscritti all'ordine che non guadagnano 5 mila euro l'anno e ce ne sono più di 20 mila che non guadagnano 10 mila euro Pag. 76l'anno. Perché ? Perché, in base a quanto prevede una legge, noi non possiamo limitare l'accesso alla professione. È evidente che gli unici a trarre profitto da questo sono gli editori, soprattutto quelli più disinvolti, perché, se non uno non vuole più collaborare a tre euro ad articolo, ce n’è un altro al posto suo. l'ultima performance che io ho è un'offerta di lavoro di settanta centesimi ogni 300 parole. [...] 300 parole, tutti mi dicono, sono quattro o cinque righe. No, sono poco meno di una cartella».
5.2) La Federazione nazionale della stampa.
«Noi facciamo bene a fare le battaglie per i diritti, però dovremmo ricordarci che abbiamo anche molti doveri. [...] Questi doveri vengono spesso dimenticati, spesso non vengono perseguite le violazioni dei codici deontologici, non mi vergogno a dirlo, anzi personalmente sono molto attratto dalla cultura anglosassone dove ci sono meno regole scritte, però ci sono delle prassi di comportamento chiare. In Inghilterra o in America il giornalista o un altro professionista che sbaglia, se commette un errore grave, deve cambiare mestiere. In Italia questo non funziona».
Diretto ed esplicito il pensiero di Santo Della Volpe (52), il presidente della Federazione nazionale della stampa prematuramente scomparso il 9 luglio 2015, audito dal nostro Comitato nel marzo 2015 assieme al segretario della FNSI, Raffaele Lorusso (53).
L'audizione dei vertici della FNSI ha offerto al Comitato un ulteriore preoccupato punto di vista sul tema degli abusi del diritto ai danni dei giornalisti e segnatamente delle querele temerarie, «...un'altra forma di intimidazione che, sia pure meno violenta di quella perpetrata con aggressioni fisiche o con minacce, è altrettanto limitativa e intimidatoria» ha spiegato il presidente Lorusso. «Mi riferisco al fenomeno purtroppo sempre più diffuso delle querele temerarie. È diventato quasi una moda cercare di colpire o quantomeno di fermare giornalisti e cronisti ritenuti scomodi, preannunciando o avviando azioni di risarcimento danni fondate sul nulla. Il solo annuncio di un'azione di questo tipo in cui spesso viene richiesto un risarcimento danni milionario, quando tale azione viene rivolta nei confronti di giornalisti freelance – che non hanno un editore o sono giornalisti precari o sono giornalisti che
lavorano per giornali molto piccoli che quindi devono barcamenarsi ogni giorno per essere presenti in edicola – diventa una forma di limitazione della libertà di stampa».
Aggiungeva su questo punto Della Volpe: «Se non sono libero di scrivere e di dare notizia di un fatto perché temo una querela da 200.000 euro che mi può mettere sotto sequestro la casa lasciando moglie e figli per strada, è evidente che l'autonomia professionale viene colpita. [...] Noi offriamo alle persone che non hanno il giornale alle spalle la tutela gratuita dal punto di vista legale, perché questo serve per dire che possono scrivere perché comunque abbiamo i migliori Pag. 77avvocati d'Italia che li possono coprire in sede giudiziaria. Lo facciamo con lo sportello antiquerele che è intitolato al compianto Roberto Morrione perché fu una delle sue prime idee».
Lorusso, come molti altri auditi, insiste su un possibile rimedio normativo: «Introdurre nel nostro ordinamento un principio, più volte sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui chi si rende colpevole di un'azione temeraria non va soltanto condannato al pagamento delle spese giudiziarie, come avviene oggi, ma va anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria proporzionale al risarcimento richiesto».
Il compianto Della Volpe ha voluto ricordare gli ultimi dati forniti da Reporters sans frontières sull'Italia: 129 cause di diffamazione ingiustificate contro giornalisti nei primi dieci mesi del 2014, mentre nel 2013 il dato si era fermato a 84. «Questo però è soltanto un dato parziale, perché nell'intero 2014 sono state conteggiate (da Reporters sans Frontières) 421 minacce ai giornalisti, con un aumento del dieci per cento rispetto al 2013».
Esisteva un tempo la manleva, cioè la possibilità che l'editore si facesse carico di tutte le querele che arrivavano per gli articoli pubblicati sulla sua testata. La manleva non era normata, ma era considerata una prassi rispettata da tutti gli editori: «Era inserita all'interno della forma contrattuale – ha ricordato Della Volpe – Oggi non è più inserita e viene tolto anche dai contratti per i direttori. Ancor di più per quanto riguarda i giornalisti, soprattutto gli inviati, e soprattutto quelli che fanno le inchieste. [...] Siamo di fronte in questi giorni a un caso esemplare di vuoto normativo: [...] il caso dei giornalisti de l'Unità che, in mancanza della proprietà che è in liquidazione, sono lasciati a se stessi. Coloro che hanno sporto querele per diffamazione, che sono purtroppo tanti, si sono rivalsi sui giornalisti anche per la quota che sarebbe di competenza
dell'editore: con il risultato che abbiamo colleghi giornalisti che hanno dai 20, 30 ai 380 mila euro di risarcimenti arrivati già all'esecuzione, perché nella causa civile, anche dopo la prima sentenza, si avvia direttamente l'esecuzione. [...] Questo perché la norma stabilisce che l'editore – che ha avuto comunque un vantaggio dalla pubblicazione di quella notizia in termini di vendita di copie e di prestigio del giornale – non ha più la responsabilità in caso di fallimento o di liquidazione per l'azione giudiziaria successiva, quindi tutto resta a carico dei giornalisti. Questo è un vuoto che va colmato !».
Ma è possibile imporre per contratto agli editori di farsi carico delle spese legali giudiziarie dei giornalisti ? «Il tema della codificazione di questa regola fa parte dei tavoli contrattuali da tempo ormai memorabile. Io le posso dire quello che avviene nella stragrande maggioranza dei casi: tutti gli editori, almeno quelli più strutturati dell'area FIEG (Federazione italiana editori giornali) si fanno carico delle spese anche per giornalisti non dipendenti. Mi riferisco a collaboratori e anche in qualche caso a freelance o titolari di altre forme di rapporto di collaborazione. [...] Il problema riguarda molti editori più piccoli, non strutturati. [...] Oggi, in Italia abbiamo poco meno di 600 emittenti radiotelevisive locali, a fronte delle quaranta della Germania o delle trenta dell'Inghilterra e della Francia, e non mi pare che in Inghilterra, in Francia e in Germania ci siano problemi di
Pag. 78pluralismo. Il pluralismo non è un problema di quantità: il pluralismo è un problema di qualità dell'informazione». Subiamo, spiega Lorusso, l'obsolescenza di una legge sulla stampa «che scrissero Moro e Gonella in tempi che però erano completamente diversi da quelli che stiamo vivendo. Quando introdussero l'elenco dei giornalisti pubblicisti il loro modello era Benedetto Croce. Oggi quel tipo di rapporto si è completamente rovesciato...».
6. La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati.
6.1) L'articolo 21 della Costituzione.
Libertà di manifestazione del pensiero, (54) libertà di opinione (55), libertà di parola (56) o libertà di stampa (57) sono i termini utilizzati nelle carte costituzionali di diversi Paesi europei per indicare la libertà di espressione quale valore cardine della democrazia.
Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, all'articolo 19, sancisce che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
Allo stesso modo, l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955, non esita ad affermare che «ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».
Nell'ordinamento italiano, la libertà di manifestazione del pensiero è consacrata nell'articolo 21 della Costituzione. «Pietra angolare dell'ordine democratico» in quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (58), essa è inserita tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’“inviolabilità” (articolo 2 Cost.), e traducendosi, in ragione del contenuto, direttamente e immediatamente, in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto. (59)
La libertà di informare, ovvero di comunicare e di diffondere idee e commenti relativi a vicende di interesse generale, è implicitamente riconosciuta nella più ampia libertà di espressione prevista dall'articolo 21 della Costituzione.Pag. 79
Di converso, accanto al diritto di informare, cioè l'aspetto attivo della libertà di espressione, è stato individuato anche il diritto all'informazione, cioè ad essere informati. Nonostante diverse posizioni contrarie dottrinali, la Corte costituzionale non ha esitato ad individuare nel diritto all'informazione, e quindi nel diritto di ciascun a ricevere e cercare le informazioni, il profilo implicito della libertà di espressione, connesso all'esigenza che «la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica che dia a tutti la possibilità di concorrere alla formazione della volontà generale» (60).
La previsione costituzionale del diritto ad informare (e a essere informati) tra le libertà fondamentali, non si risolve comunque in una sua tutela incondizionata ed illimitata.
Oltre al buon costume, espressamente contemplato dall'articolo 21 della Costituzione, inteso come rispetto del comune senso del pudore, è ormai pacificamente ammesso che la libera manifestazione del pensiero incontra i limiti derivanti dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione (61), come la sicurezza pubblica, (62) la tutela del segreto, l'onore e la reputazione della persona, desumibili dalla pari dignità sociale di tutti i cittadini (articolo 3 Cost.).
La Costituzione, inoltre, per rendere effettivo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, tutela il libero uso dei mezzi di divulgazione. (63) Entrambi i diritti, infatti, godono della stessa garanzia costituzionale in ragione del nesso di indispensabile strumentalità del secondo rispetto al primo (64).
La stampa, quindi, è incompatibile con autorizzazioni preventive o censure, ma è soggetta soltanto al (successivo) sequestro; sequestro peraltro realizzabile solo per i casi che la legge espressamente prescrive e necessita di un atto motivato dell'autorità giudiziaria (articolo 21, comma 3, Cost.).
6.2) La legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47).
La legge sulla stampa è stata approvata l'8 febbraio 1948 dall'Assemblea Costituente proprio per dare attuazione e contenuto all'articolo 21 della Costituzione.
Emanata all'indomani della liberazione, si poneva in aperto contrasto con le gravi limitazioni della libertà d'espressione che avevano caratterizzato l'epoca fascista, e si proponeva come espressione di innovazione e di garanzia delle istanze libertarie.
Nel suo combinato disposto con l'articolo 595 del codice penale sul reato di diffamazione, la legge, nell'opera di bilanciamento tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità, ha Pag. 80introdotto un'aggravante per le diffamazioni commesse con il mezzo della stampa e consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, ritenendo che, in tal caso, la condotta sia più offensiva (articolo 13); ha semplificato il processo (articolo 21) prevedendo che al giudizio si proceda con il rito direttissimo, che la sentenza venga emessa entro un mese dalla presentazione della querela e che la causa sia trattata anche nel periodo feriale, e ciò al fine di reintegrare al più presto l'onore e il prestigio dell'offeso che altrimenti verrebbe irrimediabilmente leso; ha introdotto il dovere di rettifica e ne ha disciplinato i tempi all'insegna della brevità
(articolo 8).
6.3) Il delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Il delitto di diffamazione, disciplinato all'articolo 595 del codice penale, tutela l'onore della persona, inteso sia nella sua dimensione soggettiva, cioè nel sentimento che ciascuno ha del proprio valore morale (onore in senso proprio) e sociale (decoro), sia in quella oggettiva e interpersonale, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività (la reputazione).
Gli elementi costitutivi della fattispecie penale consistono, dal punto dell'elemento materiale, nell'offesa dell'altrui reputazione, nella comunicazione con più persone ovvero nella presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso rendendoli partecipi di fatti lesivi della dignità di costui, nell'assenza dell'offeso (tale caratteristica distingue il reato da quello di ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale).
Con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che sia sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza dell'offensività della comunicazione, non necessitando invece un animus diffamandi e prescindendo, dunque, da qualsiasi indagine sulle motivazioni perseguite dall'autore del reato. Ne consegue che il delitto è altresì punibile a titolo di dolo eventuale.
Il regime sanzionatorio del delitto è diversificato a seconda della gravità della lesione arrecata. In particolare, la condotta diffamatoria si rivela più grave allorché l'offesa, in considerazione della capacità divulgativa del mezzo di comunicazione, sia realizzata attraverso la stampa (e viene punita con la pena detentiva o, alternativamente, con la pena pecuniaria ex articolo 595 del codice penale, comma 3). Ancora più grave si rivela la medesima condotta quando l'offesa, non solo sia recata attraverso la stampa, ma abbia ad oggetto l'attribuzione, al soggetto passivo, di un fatto determinato (e viene punita, stavolta, con la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria ex art. 13 della legge n. 47 del 1948).
La verità e la notorietà del fatto lesivo, contrariamente a quanto avviene in altri ordinamenti europei, non costituisce in via di principio un'esimente.
In quest'ottica, l'articolo 596 del codice penale esclude la prova liberatoria (cosiddetto exceptio veritatis), così che l'imputato dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, salvo i casi tassativi, disciplinati dai commi secondo e terzo della medesima norma.Pag. 81
Anche per la condotta diffamatoria operano, ovviamente, le cause di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale («l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità»).
In particolare, è ormai consolidato, a far data dalla storica sentenza della Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259, che sotto la nozione di «esercizio del diritto» di cui all'articolo 51 del codice penale, vanno pacificamente ricompresi l'esercizio del diritto di cronaca (che consiste nell'obiettivo racconto di fatti) e di quello di critica (che consiste in un dissenso verso l'altrui operato e si svolge con toni più aspri), come idonei, rispetto ai reati commessi con il mezzo della stampa, a scriminare la fattispecie penale, trattandosi di attività rientranti nel più ampio concetto di libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di stampa. Ma ciò purché vengano esercitati entro tre limiti essenziali:
la verità delle notizia pubblicata, vale a dire la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (65);
l'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni (66).
La carenza anche di uno solo di questi requisiti fa rivivere il diritto inviolabile all'onore del singolo individuo in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del pensiero: l'esercizio del diritto non è più configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di diffamazione.
6.4) L'articolo 57 del codice penale.
Il giornale è considerato un'opera collettiva e il suo direttore, in quanto coordinatore del piano generale, viene considerato titolare della responsabilità di ogni singolo scritto di cui si compone l'opera.
Per tale ragione, egli, o il vice-direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 c.p., nell'attuale formulazione dell'articolo, è chiamato a rispondere sul piano penale di un'autonoma ipotesi di reato rispetto a quella dell'autore della pubblicazione, per omesso controllo, punita Pag. 82a titolo di colpa per lo stesso reato contestato all'autore, e sanzionata con una pena ridotta.
Non basta, pertanto, accertare che il direttore abbia obiettivamente violato l'obbligo di controllo, ma è necessario potergli rivolgere l'addebito di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale. È evidente, poi, che qualora l'omesso controllo dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso dell'autore dello scritto.
6.5) Le azioni a tutela dell'offeso e l'abuso del loro esercizio.
In presenza di un fatto ritenuto lesivo del proprio onore o della propria reputazione, la parte lesa può sporgere querela dando luogo all'instaurazione di un procedimento penale volto ad accertare la responsabilità dell'autore della comunicazione ritenuta offensiva; ha diritto inoltre di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e/o morale subito (articolo 185 del codice penale) e, a tal fine, l'azione civile diretta ad ottenere il ristoro economico può essere spiegata in seno al processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, o in via autonoma in sede civile. L'articolo 12 della legge sulla stampa, prevede che la parte lesa dal reato possa altresì chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, la condanna anche dei responsabili civili ad un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità
dell'offesa e alla diffusione dello stampato.
Il meccanismo sopra esposto, che assicura ampia tutela patrimoniale alle persone offese dal reato di diffamazione, non trova eguale contrappeso nei casi in cui, al contrario, la querela o la connessa azione civile di risarcimento del danno siano strumentalizzate dalla presunta parte offesa con un fine volutamente condizionante, se non addirittura intimidatorio, della libertà di stampa (molte audizioni svolte dal Comitato testimoniano la progressiva estensione di questo fenomeno).
In particolare, per la temerarietà delle azioni, civili o penali, il sistema giuridico prevede strumenti «sanzionatori», quali per certi versi il delitto di calunnia laddove configurabile e, comunque, in sede di statuizioni civili (oltre alla naturale condanna alle spese in caso di soccombenza), un risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 ultimo comma c.p.c., conseguenti all'avere dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato e che possono essere liquidati, anche d'ufficio, dal giudice.
Questi strumenti, tuttavia, si rivelano particolarmente insoddisfacenti in tema di diffamazione a mezzo stampa. Deve infatti considerarsi, in primo luogo, che – allo stato dei fatti – è possibile addivenire alla dichiarazione di temerarietà della querela/azione civile solo quando si smentiscono in mala fede fatti indubbiamente veri. Quando invece il querelante/attore contesta il pubblico interesse di una notizia ovvero la continenza dell'esposizione che lo riguardava (si Pag. 83consideri che la giurisprudenza ritiene offensivi anche gli scritti allusivi), dimostrare che egli percepiva chiaramente che l'articolo pubblicato, al contrario, rispondeva ad un interesse collettivo e/o utilizzava terminologie non evocative, è invece una probatio diabolica.
A ciò si aggiunga l'oggettiva difficoltà di valutare la temerarietà di una pretesa risarcitoria per un subito danno all'immagine anche sotto il profilo dell'entità dell'eventuale ristoro.
Si consideri poi, in secondo luogo, che la mera notifica di un atto di citazione a giudizio contenente una richiesta di risarcimento dei danni, in alcuni casi esorbitante, è idonea di per sé ad esercitare una situazione di cogenza da riverberare un effetto condizionante sulla testata giornalistica e/o sul singolo autore dell'articolo. Il solo fatto di ricevere la notifica di un atto di citazione a giudizio potrebbe comportare la necessità, per la società editrice o per la testata giornalistica, di disporre degli accantonamenti in bilancio (ancorché di una sola parte della pretesa), con il rischio di esporre le più piccole imprese alla perdita dell'equilibrio economico finanziario di bilancio, con tutte le connesse conseguenze anche sul piano dei rapporti esterni soprattutto con il mondo finanziario dell'erogazione del credito, fino al rischio di chiusura.
Quanto al singolo giornalista, e si pensi specialmente ai cosiddetto freelance, dovrà comunque costituirsi in giudizio, sopportarne gli oneri, affrontare i costi di anticipazione delle spese legali e accollarsi il rischio di vedersi, ancorché non condannare, quanto meno compensare alle spese. Del resto, la natura dell'accertamento diretto a verificare, anche, l'esistenza di un patito danno morale e materiale/economico, il più delle volte impone un rigoroso onere della prova non esauribile in una mera attività documentale, e, in quanto tale, incanala il procedimento in un iter il cui tempo tecnico di definizione non è certamente breve.
6.6) La tutela contrattuale dei giornalisti e i freelance.
Nel nostro Paese, per esercitare la professione di giornalista è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, organismo istituito con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quale è affidata anche la tutela della correttezza dell'informazione.
La disciplina dell'attività lavorativa è dettata, oltre che da tale legge, anche dalla legge 416/1981, come modificata dalla legge 67/1987, e dalla legge 62/2001.
Esiste inoltre un contratto collettivo di categoria che si applica a tutti i giornalisti e che disciplina sia gli aspetti normativi sia quelli economici. Per i giornalisti che esercitano la loro professione in modo stabile, continuativo ed esclusivo, è obbligatoria l'iscrizione nel relativo albo professionale che determina la differenza tra i giornalisti professionisti e i giornalisti pubblicisti. Questi ultimi sono infatti coloro che non svolgono, in via esclusiva, l'attività giornalistica retribuita, ma sono comunque iscritti in un particolare registro tenuto presso l'Ordine dei giornalisti.
Il rapporto di lavoro che intercorre tra i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con Pag. 84vincolo di dipendenza (con gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali) è disciplinato dalle norme del contratto collettivo nazionale che prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro nelle forme del contratto a tempo indeterminato, del contratto a termine (previsto e possibile per periodi non superiori ai 36 mesi, in presenza, per lo più, di esigenze di sostituzione di giornalisti assenti per ferie, aspettativa ed altre causali), a tempo parziale (disciplinato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61) e di somministrazione di lavoro
(di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Così come regolati dal contratto collettivo sono i rapporti di praticantato e tirocinio. È altresì regolamentata la forma della collaborazione continuata, per cui un giornalista o un pubblicista presta il proprio lavoro intellettuale in cui si esplica l'attività giornalistica per una o più testate.
Diversa è invece la condizione dei freelance, anello debole della catena, intendendosi con tale termine tutti coloro che non fanno parte di alcuna redazione, che non hanno contratti di collaborazione continuativa con una testata giornalistica o altra fonte di informazione come equiparata dal contratto collettivo nazionale (artt. 1 e 2), che scrivono articoli, e più in generale realizzano forme di comunicazione, poi venduti alle varie testate, e che pur svolgendo una attività giornalistica non necessariamente devono essere iscritti all'ordine.
La condizione dei freelance è stata, da ultimo, stigmatizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunitosi a Roma alla fine del gennaio 2015, che ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno: «No allo sfruttamento dei giornalisti e a contratti-ricatto per i collaboratori. La libera informazione passa anche per il rispetto della dignità dei giornalisti e del loro giusto compenso. In questo inizio di 2015 si moltiplicano le notizie su contratti vergognosi proposti a collaboratori pena il mancato rinnovo. Riduzioni del compenso e pezzi pagati pochi euro. Eludendo anche la legge sull'equo compenso con clausole che non prevedono, ad esempio, il pagamento di video e foto, dirette web, oppure dando compensi irrisori per articoli che superano il minimo “concordato”. Con la beffa che chi più lavora meno viene pagato e meno diritti ha. Tale forma di lavoro non trova alcuna
regolamentazione e di fatto ad oggi è stata segnalata per essere fonte di sfruttamento».
7) Il percorso di riforma legislativa in Italia.
7.1) La posizione della Corte europea per i diritti dell'uomo.
Nella maggior parte dei Paesi europei, ed ancor più in quelli di tradizione giuridico romanistica, la diffamazione, intesa come offesa all'onore e alla reputazione, integra un'ipotesi di reato.
In diversi Stati europei, il delitto, se realizzato con il mezzo della stampa, è spesso punito con la pena detentiva. Ciò accade, ad esempio, oltre che in Italia, anche in Spagna, Portogallo, Irlanda, Germania, Pag. 85Belgio, Austria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Grecia e Finlandia.
Invece, in Gran Bretagna la diffamazione a mezzo stampa è stata definitivamente depenalizzata nel 2009 e la violazione è ascrivibile tra gli illeciti civili (torts) che danno diritto alla persona offesa di promuovere un'azione civile di risarcimento.
La Corte europea per i diritti dell'uomo, spesso adita per la violazione del citato articolo 10 della Convenzione, al fine di verificare se la condanna per il reato di diffamazione interferisca con la libertà di espressione del ricorrente, sottolineando il ruolo di «cane da guardia» della democrazia esercitato dalla stampa, ha spesso considerato le sanzioni comminate ai giornalisti dagli Stati membri come un'ingerenza nell'esercizio del diritto di informare.
In particolare, la Corte ha ritenuto che tale ingerenza possa essere legittima solo a tre condizioni, e cioè che: sia prevista dalla legge; sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; sia proporzionata al fatto (per tutte Steel e Morris c. Regno Unito, 15 febbraio 2005).
E, a proposito del criterio della proporzionalità, ha più volte segnalato come la previsione del carcere sia «suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa», perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni» (cfr. sentenza del 2 aprile 2009 Kydonis c. Grecia).
In altre occasioni, la Corte ha considerato eccessiva anche la sanzione economica a carico del giornalista accusato di avere diffamato (Cfr. Riolo c. Italia, 17 luglio 2008; Saaristo c. Finlandia, 12 ottobre 2010, e Publico c. Portogallo, 7 dicembre 2010).
Da queste posizioni, molti hanno fatto discendere l'incompatibilità tout court con l'articolo 10 della Convenzione, dello stesso delitto di diffamazione o comunque delle pene detentive per esso previste. Mentre altri ne hanno anche ricavato che la sanzione economica a carico del giornalista vada proporzionata alle capacità patrimoniali del condannato.
In realtà, quale sia effettivamente la posizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia lo si ricava chiaramente dalla sentenza del 27 novembre 2012 (ricorso Mengi vs Turchia n. 13471/05 e 38787/07), dove sono stati fissati i punti per valutare la compatibilità delle sentenze dei giudici dei singoli Stati con la Convenzione europea.
Nella pronuncia, in primo luogo, si precisa che la libertà di espressione, come tutte le altre libertà, non è assoluta ma incontra taluni limiti, quali il diritto alla privacy e alla reputazione. Limiti però che sono ammissibili solo se risultino necessari a proteggere un altro diritto: dunque la prova della «necessità» richiede di stabilire se l'ingerenza corrisponda ad un «bisogno sociale imperativo».
Inoltre, poiché l'esercizio di un diritto comporta anche doveri e responsabilità, chi esercita l'attività giornalistica deve rispettare alcuni parametri: interesse pubblico alla notizia; verifica della notizia; rispetto delle regole deontologiche; agire in buona fede.
Tuttavia, poiché la valutazione del giudice nazionale deve sempre essere onnicomprensiva e non limitata ad un singolo aspetto, devono Pag. 86essere considerati ulteriori fattori. Pertanto, ad esempio, è rilevante il ruolo del soggetto criticato, perché un soggetto pubblico non può pretendere la medesima protezione della privacy accordata ad un cittadino comune, e deve accettare un livello di critica superiore. Altrettanto rilevante è la forma dell'articolo, perché se un linguaggio offensivo può cadere fuori dalla protezione dell'articolo 10 quando equivale a denigrazione estrema, non si può dire lo stesso nel caso in cui l'intento dell'articolo, pur colorito da linguaggio aggressivo o anche volgare, sia non quello di insultare ma di esternare una critica basata su fatti.
Anche il giudizio per la scelta della sanzione, nella sua forma e gravità, deve considerare qualunque aspetto, per assicurare la proporzionalità della pena alla violazione, potendo altrimenti risolversi in un effetto dissuasivo nell'esercizio della libertà di espressione.
La Corte, quindi, non affermando de plano l'incompatibilità della pena detentiva con la Convenzione, la ritiene giustificabile solo in circostanze eccezionali, facendo un elenco di esempi concreti (diffusione di discorsi di odio o incitamento alla violenza), tuttavia non esaustivo. In altri termini, ciò che la Corte ha chiarito è che qualsiasi tipo di pena può essere in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo se è tale da alterare il corretto bilanciamento dei diritti e se determina un'inibizione a proseguire nell'attività di informazione, laddove la forma della sanzione è solo un elemento della valutazione globale. Non è, quindi, un problema di sanzione prevista in astratto quanto piuttosto di applicazione concreta della norma.
7.2) Il progetto di legge n. 925.
Alcuni eclatanti casi di noti giornalisti condannati alla pena detentiva per il delitto di diffamazione nonché la posizione espressa al riguardo dalla Corte europea hanno prodotto, quale effetto immediato, diverse proposte di legge (67) per la riforma del delitto di diffamazione il cui elemento comune era proprio l'abolizione tout court delle pena detentiva.
Tra i molteplici disegni, quello che è finora giunto all'approvazione di un ramo del Parlamento, è la proposta di legge n. 925. Le principali novità introdotte, limitatamente a ciò che interessa in questa sede, possono essere riassunte come segue:
innanzitutto, come si diceva, l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, sostituita da una pena pecuniaria che diventa più consistente «se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità»;
l'introduzione, per le ipotesi di recidiva aggravata (il richiamo è all'articolo 99, comma 2, n. 1 del codice penale), della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un certo periodo di tempo;Pag. 87
l'estensione delle norme sulla stampa, compreso l'articolo 57 del codice penale, alle testate giornalistiche on line, nonché a quelle radiotelevisive; ma sotto il profilo della responsabilità del direttore, viene tipizzata ulteriormente la condotta colposa come violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto;
l'attribuzione all'istituto della rettifica (di cui si puntualizzano ulteriormente le modalità) della funzione di causa di non punibilità, prevedendo che «l'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche»;
la previsione, per il caso di querele temerarie e di azione civile temeraria, di un compenso in via equitativa liquidato dal giudice.
7.3) I rimedi legislativi auspicati nel corso dell'inchiesta parlamentare.
Nel corso della nostra inchiesta parlamentare sono emerse una serie di problematiche che dimostrano come la libertà di stampa possa subire, e spesso subisce, numerosi condizionamenti.
La prima serie di criticità è di ordine generale, cioè non direttamente connessa alle pressioni mafiose ma destinata ad essere comunque percepita dal giornalista o dalla testata come un’intimidazione. Con il risultato di agevolare indirettamente anche quei poteri criminali che hanno tutto l'interesse ad una stampa non libera.
È stato evidenziato in diverse audizioni il ruolo dissuasivo svolto di fatto dall'esistenza nel nostro ordinamento del delitto di diffamazione, sia in sé, in quanto prevede l'applicazione di severe pene detentive e dà luogo a procedimenti per il connesso risarcimento del danno, sia in quanto spesso oggetto di strumentalizzazioni e di abusi giuridici.
Molti degli auditi hanno segnalato come spesso sono state sporte querele o sono state proposte azioni civili, anche con richieste esorbitanti di danni, rivelatesi infondate ma che hanno comunque sortito l'effetto di esercitare una sorta di pressione, nelle forme della ritorsione o dell'intimidazione, sui giornali e sui loro redattori, e di porre il giornale in una situazione di difficoltà economica che, in taluni casi, poteva determinarne la chiusura.
È stato anche rilevato che la retribuzione irrisoria per i giornalisti privi di contratto rende questi ultimi ancora più fragili rispetto al «rischio» di scrivere.
Un'altra serie di condizionamenti invece sono marcatamente di natura mafiosa. Nelle pagine precedenti si è avuto modo di evidenziare la pluralità di casi, che vanno numericamente ben al di là degli episodi resi noti, in cui i giornalisti che si occupano di inchieste di mafia hanno subito minacce, violenze, danneggiamenti. E ciò spesso nel silenzio generale. E, di converso, è anche emersa la capacità di alcune testate giornalistiche, asservite o comunque contigue alle mafie, di condizionare l'attività di propri giornalisti.Pag. 88
Ha ricordato, sul punto, il direttore del Corriere del Mezzogiorno Antonio Polito nel corso della sua audizione: «La minaccia della querela temeraria o anche la citazione per danni temeraria ormai è uno strumento più diffuso della querela per diffamazione perché, come è noto, la querela è con ampia facoltà di prova, mentre nel caso della citazione per danni questo non avviene. Personalmente, mi è capitato di essere assolto in sede penale e poi condannato in sede civile, con una prova di astrusità del nostro sistema giudiziario francamente sorprendente. Devo aggiungere che questa pressione è esercitata, prima ancora che dai poteri criminali, dai poteri economici tout court, cioè è un atteggiamento ormai diffuso nei confronti della libertà di stampa. È uno dei modi per condizionare la libertà di stampa. A questo va aggiunto che le imprese editoriali sono in
una fase di gravi crisi economica, per cui sono estremamente attente alla gestione dei bilanci e anche alle poste messe da parte in caso di danni, di azioni giudiziarie. Anche se è indirettamente una forma di condizionamento, credo che nelle redazioni si senta. Rispetto al passato, ci si pensa sempre una volta in più prima di dire qualcosa di vero o verificato, ma difficile da sostenere in una causa giudiziaria. [...] Un direttore di giornale ha un contratto che lo garantisce sul piano della difesa legale, l'editore gli fa da malleva dal punto di vista legale. Questo spesso non capita, per esempio, per un collaboratore, per un giornalista che spesso non è neanche un dipendente del giornale».
Diverse sono state le indicazioni, provenienti dagli auditi o riportate nella relazione di Ossigeno per l'informazione, per sollecitare riforme legislative idonee a risolvere le problematiche evidenziate.
Alcuni hanno insistito sulla necessità di depenalizzare il delitto di diffamazione, la cui esistenza limita la libertà di stampa; altri hanno sollecitato l'abolizione della pena detentiva; altri ancora hanno ritenuto che la pena pecuniaria e la condanna al risarcimento del danno vanno proporzionate, nel quantum, alla capacità economica del giornalista/testata condannati.
Si è anche proposto di introdurre un doppio binario per i processi per diffamazione (attraverso una sorta di istruttoria preliminare, un'udienza-filtro) in modo da evitare che, nelle more dei procedimenti, un giornale possa andare in sofferenza o un giornalista senta l'intimidazione delle querele sporte a suo carico (specie alla luce del proposta di legge Costa ove la recidiva comporterebbe anche la pena della sospensione della professione).
E, infine, per creare un serio deterrente alle querele/azioni civili temerarie, è stata sollecitata la previsione di una condanna, per il querelante/attore temerario, al pagamento di una somma di denaro stabilità in percentuale rispetto a quella richiesta al giornalista querelato/citato.
Si tratta certamente di importanti spunti di riflessione. Tuttavia, come si nota, il delitto di diffamazione a mezzo stampa ha finora rappresentato il bersaglio da centrare per rendere effettiva la libertà di stampa e, comunque, l'alveo entro cui ricercare possibili aggiustamenti per evitare che la fattispecie di reato, di fatto, svolga una funzione di censura all'informazione.
Invece, l'analisi dell'insieme delle criticità accertate dall'inchiesta parlamentare se, da un lato, consente di ridimensionare le problematiche Pag. 89connesse al delitto di diffamazione, risolvibili con taluni interventi, dall'altro, impone, come si vedrà, di dilatare l'ambito della tutela penale in favore della libertà di stampa intesa, stavolta, nella sua ampia accezione costituzionale, traducibile nella nota espressione di «cane da guardia della democrazia», la cui salvaguardia non sarebbe altrimenti assicurata nemmeno con la depenalizzazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale.
8. Le prospettive di riforma.
8.1) Il delitto di diffamazione come possibile limite alla libertà di informazione.
Esaminando il rapporto intercorrente tra il delitto di diffamazione e la libertà di espressione, va innanzitutto chiarito che il primo, nell'armonia dell'ordinamento giuridico italiano, non costituisce affatto un limite estrinseco alla seconda, cioè uno sbarramento che, dall'esterno, comprime e restringe il diritto di manifestazione del pensiero. Vero è che, come visto, l'unico divieto espressamente contemplato dall'articolo 21 della Costituzione riguarda le pubblicazioni contrarie al buon costume, ma nella medesima carta costituzionale sono tutelati altri beni di pari rilevanza, quali, per ciò che qui rileva, quelli della dignità della persona, considerata sia singolarmente che nelle formazioni sociali in cui si estrinseca (artt. 2 e 3 Cost.), delle istituzioni della Repubblica, di coloro che esercitano pubbliche funzioni (articolo 54 Cost.). Beni che, ontologicamente, delineano il limite intrinseco della libera
manifestazione del pensiero oltre il quale essa perde la fisionomia di diritto per trasformarsi in un abuso.
Del resto, anche la Corte EDU, come visto, ha segnalato che la libertà di stampa può incontrare limiti che risultino necessari a proteggere un altro diritto.
Lo sforzo della giurisprudenza penale si è pertanto concentrato sull'individuazione di quei marcati confini che consentano di stabilire se, e fino a quando, l'attività di cronaca o di critica, che per loro natura sono lesive di posizioni soggettive, possano considerarsi esercizio di un diritto e, dunque, un'esimente rispetto ad astratte fattispecie di reato.
Secondo questa impostazione, la prassi giurisprudenziale, ormai consolidata, ha, appunto, individuato i tre noti canoni (veridicità della notizia, interesse pubblico alla sua divulgazione, forma civile dell'esposizione) entro cui la cronaca si rivela manifestazione del diritto di informare e di essere informati, discendenti dalla più ampia categoria della libertà di manifestazione del pensiero.
Il delitto di diffamazione a mezzo stampa, dunque, opera a partire dal confine entro cui la libertà prevista dall'articolo 21 Cost. si dissolve e perde la sua natura perché straripante rispetto ai suoi limiti intrinseci.
Nessuna incompatibilità, pertanto, tra libera informazione e i c.d. «reati di opinione» che si configurano solo quando, secondo i criteri riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale, ma anche secondo la Pag. 90Corte EDU, il diritto di libera manifestazione del pensiero non è più tale.
Si può allora affermare, in primo luogo, che la depenalizzazione del delitto di diffamazione, auspicata da più parti a tutela della libertà di stampa, può, in ipotesi, rivelarsi debordante rispetto alle sue finalità e dissonante rispetto al sistema giuridico italiano. Ed invero, si determinerebbe un vuoto di tutela per altri beni di sicura rilevanza costituzionale quali, appunto, la dignità dell'individuo, cioè il «passaporto» di accesso di ciascuno alla vita sociale e politica. Beni che trovano finanche autorevole riconoscimento nell'art 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo cui «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata..., nelle a lesioni del suo onore della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze lesioni».
Peraltro, imponendo un sacrificio a tali valori, non corrisponderebbe un'utilità marginale alla libertà di stampa. Infatti, l'abrogazione del reato di diffamazione non può comunque avere come effetto quello di espandere il bene giuridico di cui all'articolo 21 della Costituzione oltre i suoi confini naturali, individuabili, ancor prima che nel codice penale, nella stessa carta costituzionale, e di rendere legittime condotte che legittime, comunque, non possono essere. Non è un caso, quindi, che anche in molti altri Paesi europei la diffamazione a mezzo stampa continui ad essere considerata un illecito penale.
Non può tacersi, al riguardo, che la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1577 del 2007 (richiamata nella più recente risoluzione n. 1920 del 2013 in cui si prende in considerazione anche il caso italiano relativo alla condanna di Sallusti a 14 mesi di pena detentiva) deplora la circostanza che in un elevato numero di Stati si ricorra allo strumento penale, ritenendo che la minaccia di agire per diffamazione è una forma di intimidazione particolarmente insidiosa ed è un inaccettabile abuso della normativa antidiffamazione.
Peraltro, non si può negare che l'esistenza del delitto di diffamazione e, soprattutto, la sua severa punizione da parte della legislazione italiana che contempla anche la pena detentiva, possono di fatto costituire un deterrente rispetto al libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. Non si può ignorare che, talvolta, il delitto di diffamazione viene strumentalizzato attraverso la minaccia di sporgere querela, dando luogo alla c.d. intimidazione giudiziaria. Né si può negare che la pendenza di un procedimento penale o civile costituiscono già da soli un deterrente per il giornalista specie se scarsamente garantito dal punto di vista contrattuale (c.d. intimidazione economica).
Ma si rischia un errore di prospettiva. In realtà, partendo dal presupposto che la Corte EDU ha finora ritenuto conforme ai principi europei il delitto di diffamazione e ha anche ritenuto adeguata la pena detentiva seppure per casi assolutamente eccezionali, devono individuarsi soluzioni bilanciate che, secondo il criterio della pari utilità marginale dei sacrifici, siano idonee a tutelare in maniera adeguata tutti, e non solo alcuni, i beni di rilevanza costituzionale in posizione antagonistica.Pag. 91
Nel caso specifico del rapporto diffamazione-libertà di stampa, un intervento riequilibratore dovrebbe riguardare due differenti versanti: quello dell'astratta proporzionalità della pena alla lesione nella formulazione legislativa del delitto, e quello della punibilità della condotta in astratto diffamatoria in presenza di un'offesa concreta.
Con riferimento alla proporzionalità della pena, va ricordato che, nella concezione del legislatore, il reato di diffamazione tutela esclusivamente l'onore dell'individuo, inteso, dal lato soggettivo, come il sentimento che ciascuno ha di sé, e, dal lato oggettivo, come reputazione, cioè la stima di cui il singolo gode in un gruppo sociale.
Il delitto di diffamazione, dunque, di fatto punisce la c.d. «parola di troppo» che si riveli offensiva per l'individuo, mentre è ben lungi dal tutelare da altri e più gravi fenomeni, quali quello della distorsione della funzione del giornalismo, quando cioè «la stampa .. come un torrente lasciato scorrere liberamente, può sommergere e devastare intere campagne e raccolti così come una penna adoperata senza freno non può portare altro che distruzione» (68).
La prevista pena detentiva per il giornalista (da sei mesi a tre anni di reclusione, ma in alternativa alla pena pecuniaria, ovvero da uno a sei anni di reclusione congiuntamente alla pena pecuniaria per il caso di attribuzione di un fatto determinato), probabilmente, ab origine, non appariva di per sé eccessiva rispetto al bene tutelato. Ma tale lo è certamente oggi, alla luce dei radicali cambiamenti del costume e, di pari passo, della legislazione. Intanto perché il carcere, nell'opera di modernizzazione dell'ordinamento, viene sempre più percepito come un’extrema ratio difficilmente ravvisabile per una condotta diffamatoria. Inoltre, perché la diffusione dei mezzi di informazione, la facilità di accesso ad essi e la crescente divulgazione delle notizie (anche ad opera dei privati sui social network) da un lato, ha ridotto la distanza tra pubblico e privato, sicché viene sempre
meno percepita la negatività della diffusione di fatti o immagini inerenti la propria persona, e, dall'altro, ha dilatato il senso critico sulla non necessaria veridicità di quanto riportato nella stampa. In sostanza, il bene dell'onore e della reputazione si rivela sempre meno profondamente leso in presenza di una notizia diffamatoria.
La stessa Corte di cassazione sì è adeguata al cambiamento sociale e a quello derivante dalla posizione della Corte europea.
Con la decisione del 13 marzo 2014 n. 12203, è stata annullata una condanna a sei mesi di reclusione pronunciata contro un giornalista che aveva pubblicato una notizia falsa. In particolare la corte di legittimità, partendo dall'orientamento della Corte europea che esige, per l'applicazione della più severa sanzione, «la ricorrenza di circostanze eccezionali», ha statuito che l'irrogazione del carcere in luogo della pena pecuniaria deve essere riservata alle ipotesi di diffamazione «connotate da più spiccata gravità».
La pronuncia è sicuramente innovativa perché, non solo ha affermato tali principi, ma ha ritenuto che, nonostante il caso specifico trattato riguardasse una notizia non veritiera, nemmeno la falsità integrava evidentemente un caso di «più spiccata gravità» né tantomeno una di quelle ipotesi eccezionali menzionate dalla Corte europea.Pag. 92
La giurisprudenza, dunque, ha già fatto da apripista per l'abolizione della pena detentiva per i giornalisti. Di pari passo, come si è detto, il citato proposta di legge 925 ha proprio introdotto tra le sue principali novità l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa. E, a differenza di altri disegni di legge analoghi, è già stato approvato da un ramo del Parlamento lasciando prevedere che, quantomeno sul punto dell'eliminazione della pena detentiva, possa trovare definitiva approvazione. I tempi, dunque, sono certamente maturi per armonizzare la sanzione rispetto alla mera «parola di troppo».
Va detto, invece, che l'invocato adeguamento della pena della multa, ma anche del risarcimento dei danni, alla capacità economica del giornalista diffamante, attualmente non potrebbe trovare spazio nel nostro sistema.
Invero, il criterio della proporzionalità della sanzione alle sostanze del debitore, dovrebbe riguardare, pena l'incostituzionalità della previsione, tutti i condannati, e non solo i giornalisti, o, quantomeno, anche coloro che, come i giornalisti, hanno posto in essere un illecito nel (presunto) esercizio di libertà garantite dalla Costituzione (vi rientrerebbero così numerose categorie di persone, come insegnanti, avvocati, medici). Inoltre, si rischierebbe che colui che nulla possiede, godrebbe di una sorta di «licenza» a perpetrare illeciti poiché, di fatto, nulla avendo, non subirebbe condanne ovvero subirebbe condanne penali prive di ogni capacità preventiva-repressiva e condanne civili prive di ogni capacità reintegrativa, finendo dunque per snaturare la stessa funzione della pena o dell'azione risarcitoria.
Del resto, posto che la sanzione penale o civile sono previste non per chi eserciti il legittimo diritto di manifestazione del pensiero, ma per chi mortifica la libertà di stampa, l'obiettivo legislativamente perseguibile non può essere certo quello della tutela dell'autore dell'illecito ma della libertà di informazione che è ben altra cosa e che, come si dirà, necessita di ben altri accorgimenti.
Va anche ribadito che il principio di proporzionalità della pena invocato dalla giurisprudenza della Corte europea non si traduce, sic et simpliciter, nella commisurazione della sanzione pecuniaria proporzionalmente alle sostanze economiche del condannato ma, più che altro, alla portata lesiva, e non sempre particolarmente lesiva, della condotta di questi.
Un danno va commisurato in base all'entità della lesione arrecata e, pertanto, non può essere considerato irrisorio se colui che lo provoca è un indigente e non può, il medesimo danno, divenire grave se il suo autore è invece un benestante.
Semmai, allora, la normativa italiana, recependo le indicazioni della Corte EDU, secondo cui il giudizio di proporzionalità deve essere onnicomprensivo, dovrebbe ulteriormente puntualizzare che, nella scelta della sanzione penale e nella quantificazione del risarcimento in sede civile, il giudice, deve tenere conto di diversi criteri per determinare l'entità dell'offesa. Tra questi certamente la connotazione meno negativa che oggi assume una condotta diffamatoria (specie se verrà abolita la pena detentiva per il relativo reato); l'intervenuta rettifica, e soprattutto, tra i criteri prioritari, la capacità diffusiva del Pag. 93mezzo di comunicazione valutata in base, non tanto alla facilità di reperimento della notizia (altrimenti ogni informazione riportata dai siti Internet risulterebbe a priori di eccezionale offensività), ma alla capacità di incidere nella
formazione dell'opinione pubblica.
Con riferimento al secondo versante, cioè quello della punibilità della condotta in presenza di un'offesa reale, andrebbe meglio delineato l'ambito di operatività della diffamazione.
Già, come detto, il mero fatto diffamatorio non desta particolare allarme sociale. Ma bisogna anche chiedersi quando, in concreto, un fatto diffamatorio sia effettivamente lesivo o, comunque, lesivo in modo tale da giustificare l'intervento sanzionatorio statale. E ciò non solo alla luce della spinta europea alla decriminalizzazione della diffamazione, ma anche in considerazione della nuova tendenza del sistema giuridico italiano ad escludere la punibilità di fattispecie in cui la lesione sia di particolare tenuità.
A tal proposito il citato disegno di legge ha ridelineato la rettifica, già contemplata dalla legge sulla stampa, attribuendole anche la funzione di causa di non punibilità.
Ora, a prescindere dalle modalità con cui essa dovrebbe essere effettuata (che sono al centro di numerose critiche), appare certamente apprezzabile l'introduzione nel sistema italiano del nuovo istituto perché consente un effettivo bilanciamento degli interessi: se l'offesa alla reputazione è immediatamente ed efficacemente sanata attraverso il medesimo strumento con cui l'offesa è stata arrecata, il bene giuridico protetto viene reintegrato o, comunque, finisce per subire una lesione minima che fa scemare la pretesa punitiva dello Stato.
In particolare, secondo la nuova previsione del comma IV dell'articolo 13 legge sulla stampa, «l'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on-line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57 bis del codice penale, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche».
Tuttavia, la norma, per come formulata, potrebbe non rivelarsi idonea allo scopo di rendere non punibile ciò che è effettivamente non lesivo. Né, comunque, può fungere da elemento di sbarramento ad azioni penali o civili per il caso in cui nessuna lesione meritevole di apprezzamento si sia verificata.
In primo luogo, va evidenziato che la non punibilità si giustifica solo con una reintegrazione dell'interesse leso. Ma la rettifica non sempre può rivelarsi sanante. Essa certamente appare efficace quando la diffamazione riguardi l'attribuzione di un fatto (ad esempio, la notizia riporta erroneamente che una persona è stata condannata e questa, rettificando, segnala che è stata rinviata a giudizio). Invece, quando l'articolo di stampa esula l'interesse pubblico poiché riporta fatti veri ma appartenenti alla sfera esclusivamente privata dell'individuo, ovvero utilizza termini manifestamente offensivi che comunque denigrano la persona, la lesione appare in sé immediata e insanabile. In tali ultimi casi, la successiva pubblicazione di una rettifica, di una smentita o di una nota di scuse può, semmai, ridurre la lesione, ma Pag. 94di un quantum non
astrattamente determinabile normativamente ma soltanto valutabile dal giudice nel caso concreto.
Lo stesso PDL 925, evidentemente partendo dal fatto che la nuova causa di non punibilità non sempre si rivela reintegrativa, prevede che, nella determinazione dell'ammontare del danno, deve tenersi conto anche dell'eventuale intervenuta rettifica, ma in tal modo finisce per spostare il piano della tutela esclusivamente nella ben più complessa sede civile.
In secondo luogo, la rettifica come causa di non punibilità, secondo la proposta di legge 925, opera se il presunto offeso esercita o meno, a suo piacimento, la relativa facoltà. Sicché è rimessa alla volontà dell'offeso, o del presunto offeso, la scelta tra una reintegrazione reale del bene leso (attraverso la rettifica) e una reintegrazione per «rivalsa» (attraverso la querela o l'azione civile per risarcimento dei danni).
Vero è che la nuova norma utilizza la locuzione «anche spontaneamente» che può essere interpretata nel senso che lo stesso autore dell'offesa possa provvedere autonomamente alla rettifica, ma è evidente che si tratterebbe di casi residuali.
Lo strumento andrebbe quindi rafforzato e perfezionato. La rettifica, prima ancora di rivelarsi causa di non punibilità, dovrebbe rappresentare una condizione di procedibilità, sia dell'azione penale che di quella civile.
Invero, a fronte dello strumento naturale, in ipotesi reintegrativo del bene giuridico tutelato dall'articolo 595 del codice penale o comunque parzialmente sanante, sembrerebbe consono – sia a tutela della libertà di stampa spesso compromessa dalla minaccia dell'agire penalmente o civilmente, sia nell'ottica sempre più diffusa di rimettere alla composizione privata la risoluzione delle liti – attribuire all'istituto della rettifica un effetto preclusivo, nel senso che, in sua assenza, non debba potersi esercitare il diritto di querela/citazione in giudizio.
Intervenuta la rettifica secondo le modalità previste dalla legge, e adite egualmente le vie legali, a quel punto sarà compito del giudice penale valutare se essa abbia avuto o meno un effetto reintegrativo.
Nel primo caso dichiarerà la sussistenza della causa di non punibilità della rettifica, nel secondo caso valuterà se la residua lesione sia di lieve tenuità e, in tal caso, dichiarerà la sussistenza della diversa causa di non punibilità recentemente prevista dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l'articolo 131 bis del codice penale («la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, .. l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»).
A sua volta, il giudice civile, intervenuta una rettifica sanante, dichiarerà l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, salvo che l'attore provi concretamente di avere subito un danno ulteriore, rispetto a quello morale, connesso alla diffamazione (ad esempio taluno che viene licenziato in tronco dopo un articolo di stampa). Ovvero, in presenza di una rettifica parzialmente sanante, come previsto dal citato proposta di legge Costa, nella determinazione dell'ammontare del danno, terrà conto solo del danno residuo.
L'istituto della rettifica, come condizione di procedibilità e come causa, a certe condizioni, di non punibilità e di non risarcibilità, Pag. 95eviterebbe quindi inutili procedimenti penali o civili o comunque li semplificherebbe, anche nei termini di durata. Il delitto di diffamazione e il relativo risarcimento residuerebbero, dunque, solo per i casi eclatanti di sviamento dalla libertà di stampa.
La rettifica, costruita nei termini prima descritti, rappresenterebbe anche una efficace, seppure parziale, soluzione al problema delle querele/azioni temerarie.
Sebbene essa, come condizione di procedibilità, non impedisca la querela o l'azione civile, tuttavia il querelante o l'attore, ma anche il giornalista querelato o convenuto, ben sanno che la portata dell'istanza punitiva e/o risarcitoria è, già a priori, scemata essendo altamente prevedibile la dichiarazione penalistica di non punibilità del reato, per rettifica sanante o per tenuità dell'offesa, e la dichiarazione civilistica di insussistenza del diritto di risarcimento del danno o di sussistenza di un danno parecchio ridotto nel suo quantum.
Altre soluzioni per arginare ulteriormente la problematica della temerarietà, possono essere rinvenute anche in altre diverse direzioni.
La liquidazione in via equitativa prevista, come detto, nel proposta di legge non può che intervenire dopo che il procedimento si è concluso, quando cioè l'intimidazione/ritorsione ha già prodotto i suoi effetti. Ma in un procedimento breve, penale e civile, si ridurrebbero drasticamente sia i tempi di durata dell'intimidazione/ritorsione sia, di conseguenza, i loro effetti.
Con riferimento al giudizio penale, già la legge sulla stampa prevede (o meglio, prevedeva) che si proceda con il rito direttissimo, che la sentenza venga emessa entro un mese dalla presentazione della querela, che il processo sia trattato anche nel periodo feriale.
In realtà tali prescrizioni sono prive di concreta applicazione perché il rito direttissimo, per come attualmente strutturato, si rivela inidoneo, nel caso di specie, a rispondere alla necessità di formazione della prova, non sempre agevole, spesso richiesta per l'accertamento della responsabilità.
Tuttavia, nonostante la disapplicazione della norma, rimane però sempre attuale la ratio di tali previsioni individuata dalla stessa Assemblea costituente, che è, cioè, quella di reintegrare, al più presto possibile, l'onore e il prestigio dell'offeso essendo ovvio che restituire dignità ad una persona dopo anni non ha alcun effetto reintegrativo. A ciò si aggiunga che, a fortiori, i tempi brevi di durata processuale, tutelano altresì un altro bene di rilevanza costituzionale, quale appunto la libertà di stampa che potrebbe essere compressa dalla pendenza di procedimenti che, da un lato, intimidiscono chi scrive e, dall'altro, minano la credibilità di una testata giornalistica nel suo complesso.
La soluzione che, a tal fine, potrebbe essere individuata è quella di inserire i delitti commessi con il mezzo della stampa tra quelli contemplati dall'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per i quali è prevista la priorità assoluta di trattazione.
Del resto, da un punto di vista strettamente pratico, tali delitti ben poco inciderebbero nell'economia della formazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi, posto che, secondo le prospettive prima descritte, il delitto di diffamazione giungerebbe alla fase dibattimentale solo in casi eccezionali.Pag. 96
Con riferimento al processo civile, deve premettersi che la natura dell'accertamento diretto a provare l'esistenza di un danno morale e economico impone un gravoso onere probatorio, non eludibile, nella maggior parte dei casi e comunque in quelli più rilevanti, attraverso una mera produzione documentale, cosicché il conseguente giudizio non può che svolgersi nelle forme del rito ordinario, con esclusione dei più veloci riti sommari, i cui tempi tecnici di definizione, ad oggi, nella migliore delle ipotesi, possono stimarsi in un periodo medio di tre anni.
Va però ricordato che è stato introdotto nel nostro ordinamento, quale condizione di procedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale di risarcimento del danno, il tentativo obbligatorio di mediazione. Pertanto, la parte che intende proporre un'azione civile risarcitoria deve prima invitare la controparte a presentarsi dinanzi al mediatore per verificare la possibilità di una definizione concordata. Solo ove vi sia dissenso espresso dalle parti rispetto alla possibilità di mediare la controversia, sarà possibile la prosecuzione dell'azione in sede giudiziale.
Se pur la previsione del tentativo di mediazione ove non accolta, non abbia la valenza dell'auspicata un'udienza filtro preliminare finalizzata a valutare profili di ammissibilità della pretesa, essa rappresenta una modalità comunque idonea ad approfondire gli elementi di conoscenza della pretesa risarcitoria in una prospettiva anche di valutazione della sua fondatezza.
Per ovviare alle criticità dell'attuale sistema, inidoneo a una tutela prioritaria del rischio di condizionare la libertà di informare, e dovendosi escludere la possibilità di introdurre l'istituto dell'udienza-filtro solo per la categoria dei giornalisti, si potrebbe ipotizzare, recependo altresì le indicazioni provenienti dall'attuale riforma del processo civile di esternalizzazione del giudizio, di prevedere per tali tipi di azioni, dopo il filtro preventivo della mediazione, l'attribuzione della competenza in via esclusiva ad un organo arbitrale, di nuova individuazione e/o creazione deputato a decidere, in uno stretto arco temporale, sulle richieste risarcitorie conseguenti ai fatti di diffamazione commessi con il mezzo della stampa.
Un'altra percorribile direzione è quella del rafforzamento della tutela dei giornalisti privi di contratto che, più degli altri, subiscono l'intimidazione giudiziaria ed economica.
È ovvio che il colpevole, civilmente o penalmente, in quanto tale dovrà farsi carico del pagamento delle sanzioni penali pecuniarie, del risarcimento del danno e delle spese processuali, e del risarcimento danni. Ipotesi queste che però, alla luce delle riforme sopra proposte, sarebbero veramente residuali e, in ogni caso, comporterebbero pagamenti di quantum molto ridotti.
Il problema rimane integro, seppure più contenuto, (in vista della previsione dei tempi brevi per il processo penale e civile) al momento dell'avvio di un procedimento che, indipendentemente dal suo esito, spesso comporta spese legali non sempre sostenibili.
È soprattutto in tale fase, dunque, che bisognerebbe estendere le garanzie, prevedendo in capo all'editore/proprietario l'obbligo di assicurazione obbligatoria per tutti coloro che scrivono, con qualunque forma contrattuale, per la sua testata o, comunque, l'obbligo di Pag. 97anticipare le spese del procedimento (da recuperare, in caso di condanna, dallo stesso giornalista o dall'assicurazione, o in caso diverso, dall'attore/querelante soccombente o temerario, o, in caso di archiviazione, dall'assicurazione).
Tali previsioni, però, potrebbero rivelarsi un deterrente per gli editori nel consentire ai giornalisti privi di contratto di scrivere nelle loro testate. Pertanto, all'intervento legislativo sull'obbligo di assicurazione, non può non affiancarsi un'adeguata contrattazione collettiva e il fattivo interessamento della Federazione e dell'Ordine dei giornalisti.
8.2) La tutela del diritto di informare.
Come si anticipava, il problema della tutela del diritto di informare, va ben oltre le problematiche connesse al delitto di cui all'articolo 595 del codice penale.
È superata da tempo la vexata quaestio sulla configurabilità di una libertà di informare, ovvero di diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione, notizie idee e commenti relativi a vicende di interesse per la generalità, come discendente dalla libertà di espressione prevista dall'articolo 21 della Costituzione. La tesi di chi nega che non esiste un diritto di cronaca costituzionalmente sancito è stata ampiamente superata dalla più autorevole dottrina, da numerosi fonti internazionali e dallo stesso orientamento della Corte costituzionale e della Corte europea per i diritti dell'uomo. Anzi, si sostiene ormai che la libertà di cronaca è il momento attuativo della libertà del pensiero, che sarebbe sicuramente svuotata di significato se la prima non ricomprendesse, nonché condizione necessaria per l'esistenza della democrazia e per rendere effettivo il principio della sovranità
popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione.
Eppure questo diritto, con tale portata e tale suo significato, non solo risulta sempre più compromesso e mortificato, ma, di fatto, non gode di alcuna effettiva tutela.
Il problema della strumentalizzazione del reato di diffamazione appare poca cosa rispetto a quanto emerso dall'inchiesta parlamentare che ha rilevato come la stampa sia diventata il bersaglio delle mafie o di altri poteri o, al contrario, il loro strumento.
Non pochi giornalisti, a causa delle loro attività, sono stati destinatari di continue violenze, minacce, danneggiamenti provenienti dal substrato della criminalità organizzata; altri hanno subito i condizionamenti dagli stessi vertici del giornale, asserviti ai poteri mafiosi; e un altro più che rilevante numero di cronisti è stato destinatario di reiterate querele e azioni temerarie volte a scoraggiare la prosecuzione della propria attività.
Si tratta di condotte, come è evidente, la cui offensività supera la pressione verso il singolo destinatario ma insidiano la libertà di informare e, dunque, «il cane da guardia della democrazia».
Se, in particolare, si pensa a quelle minacce finalizzate, non tanto a «punire» l'autore di un articolo scomodo, quanto ad intimidire gli organi di stampa nel loro complesso, si comprende come fatti così gravi – in cui la parte offesa è, invece, non solo il destinatario Pag. 98immediato dell'atto di prevaricazione, ma la stessa libertà sancita dall'articolo 21 della Costituzione – siano privi di adeguata punizione.
Unica norma specifica prevista nel nostro ordinamento a tutela della stampa è costituita dall'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (la legge sulla stampa) che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per colui che, per impedirne la vendita, distrugge o deteriora stampati, ovvero chi, ancora prima, ne impedisce la stampa, con violenza o minaccia. Ma si tratta, in tutta evidenza, di una norma rivolta alla tutela dello stampato e non anche al momento antecedente della libera formazione del pensiero.
A loro volta, gli ipotizzabili delitti di minaccia, violenza privata e danneggiamento, prevedono pene irrisorie che, seppure aumentate, qualora ne ricorrano le condizioni, dall'aggravante prevista dall'articolo 7 decreto-legge 151/91 (relativa alla finalità di favorire l'associazione mafiosa o al ricorso al metodo mafioso), o aumentate introducendo una specifica aggravante per colui che agisca al fine di limitare la libertà di stampa (di cui, comunque, necessita l'introduzione nel sistema legislativo), difficilmente raggiungono limiti edittali significativi, tali da potere consentire l'applicazione di misure cautelari o, in ogni caso, da rilevarsi proporzionati alla gravità del fatto, e cioè all'offesa arrecata alla libera manifestazione del pensiero.
Occorrerebbe, quindi, sanzionare ex novo tali condotte, così intrise di disvalore sociale, con una specifica norma penale che punisca chiunque, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, ponga in essere condotte di violenza, minaccia, danneggiamento, reiterata pressione comunque manifestata, al fine di condizionare, limitare, impedire la libertà della stampa e degli altri mezzi di comunicazione.
8.3) La tutela del diritto ad essere informati.
Più problematico è stato rinvenire, accanto al diritto di informare, un correlativo diritto ad essere informati.
Senza volere ripercorrere in questa sede le argomentazioni della nota diatriba, l'esistenza di un vero e proprio diritto ad essere informati è comunque stato ribadito sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea per i diritti dell'uomo.
Diritto che, in un regime di libera democrazia, implica la pluralità delle fonti, il libero accesso alle medesime, l'assenza di ingiustificati ostacoli alla circolazione delle notizie e delle idee. Diritto che va collocato, da una parte tra le garanzie di indipendenza dell'individuo nei confronti del potere e, dall'altra, tra i diritti di partecipazione in quanto insostituibile strumento per assicurare il concorso dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
Esula dalle finalità dell'inchiesta parlamentare svolta la questione, pur di fondamentale importanza, sull'effettivo pluralismo dell'informazione. Deve essere invece affrontata la diversa problematica inerente l'eventuale presenza di «ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle notizie» nella forma, per ciò che qui rileva, del condizionamento della stampa da parte dei poteri mafiosi.Pag. 99
Nelle pagine precedenti si è rilevato che giornalisti sono stati ostacolati dagli stessi vertici del giornale. Ed è emerso che la stampa è stata, e ben ancora può essere, lo strumento delle mafie non tanto per diffamare un singolo ma per destabilizzare un sistema o perseguire scopi di delegittimazione di un corpo politico, giudiziario o amministrativo.
L'apparente libera informazione, in tali casi, trasforma la stampa in un subdolo strumento di offesa alle libertà riconducibili all'articolo 21 della Costituzione. Anche in questo caso si è in presenza di un vuoto legislativo, mentre il delitto di diffamazione, seppure in ipotesi dilatato, non può fungere, poiché ancorato all'onore e alla reputazione, da soluzione adeguata a cui la prassi giurisprudenziale possa attingere.
È certamente difficile ipotizzare, stavolta, una nuova figura di delitto che non si risolva, con i suoi precetti, in un limite alla libertà di stampa, che non faccia da arbitro su ciò che va detto e su ciò che non va detto, che non si traduca in «un controllo esercitato dall'esterno, più dannoso, addirittura, della mancanza di controllo». (69)
Tuttavia è possibile individuare condotte che, macroscopicamente, oltrepassano i limiti intrinseci della libertà di stampa, e manifestamente perseguono scopi ben ulteriori da quello dell'informare.
È dunque possibile pensare ad una norma penale rivolta a punire, esclusivamente, chi, attraverso la reiterata pubblicazione di notizie false, con la piena consapevolezza della loro falsità, persegue, con dolo specifico, finalità di denigrazione e o di delegittimazione di singoli o di istituzioni.
Come detto, si sono anche registrati nel corso dell'inchiesta parlamentare, episodi di manipolazione dell'informazione da parte di alcune testate giornalistiche che hanno impedito la pubblicazione di notizie o dato risalto, al contrario, a particolari fatti con l'effetto di mortificare la portata della notizia principale e creare nell'ignaro fruitore del sevizio una visione distorta della realtà.
Consentire la formazione di un'opinione pubblica cosciente non significa solo evitare la strumentalizzazione della stampa per finalità di destabilizzazione di un sistema ma pretende, ancor prima, di attribuire al lettore il diritto di conoscere l'identità di chi la notizia gli fornisce, così da potere valutare criticamente la portata dell'informazione anche con riferimento ai soggetti che la veicolano.
La legge sulla stampa, attualmente, impone ai giornali l'iscrizione nel registro presso il tribunale del luogo ove avviene la pubblicazione. I giornali devono altresì pubblicare i dati del direttore responsabile, quelli identificativi degli organi, della sede legale, della società o del singolo titolare del giornale. Ma molto spesso lo schermo societario non rende possibile, o quanto meno, agevole identificare l'effettivo proprietario del mezzo di informazione.
Anche Vincenzo Iacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, ha sottolineato, come visto, la necessità della trasparenza degli assetti editoriali: «Occorre capire quali sono le reali proprietà dei giornali, non solo nel Sud. Se ci diciamo che la criminalità è ovunque, occorre capire di chi sia la proprietà dei giornali con l'istituzione di un registro che non vuole e non deve essere assolutamente limitativo della libera Pag. 100iniziativa. Vogliamo, però, tutelare i cittadini, vogliamo consentire loro di sapere a quale interesse corrispondono alcune iniziative che nascono in maniera precaria...».
Orbene, in un momento in cui le legislazioni tendono ad assicurare la consapevolezza sui prodotti di mercato, sulla loro composizione e provenienza, è impensabile che non venga offerta analoga tutela al «consumatore» degli articoli di stampa, cioè al titolare del diritto costituzionale ad essere informati.
Al fine di consentire la conoscenza sulla reale identità delle persone fisiche o giuridiche che effettivamente detengono la proprietà dei giornali o che, in qualche modo, controllano l'informazione, dovrebbe allora prevedersi, anche mutuando la normativa europea in tema di antiriciclaggio, un vero e proprio obbligo, la cui violazione sia adeguatamente sanzionata, per i mezzi di comunicazione di rendere noti gli elementi identificativi del dominus de facto, evitando che schermi societari possano rendere incerta la sua individuazione.
9. Conclusioni.
Fare il giornalista in un Paese percorso e lacerato dalla violenza delle mafie vuol dire mettere in conto che, nel mirino di quella violenza, ci puoi essere anche tu. Siamo certi che questa consapevolezza fosse ben chiara nei quasi cinquecento giornalisti (per fermarci al dato più recente) che nel 2014 hanno subito in vario modo avvertimenti, minacce o violenze. Sono stati loro stessi (molti li abbiamo auditi durante i dieci mesi di lavoro di questo Comitato) a confermarci che non c’è stupore per quello che accade: semmai rabbia, solitudine, frustrazione. Paura, naturalmente. Stupore mai.
Eppure quella cifra imbarazza. Soprattutto per una nazione che ha una solida e civilissima tradizione di informazione democratica, un «cane da guardia del potere» che è stato complessivamente capace, dal dopoguerra in poi, di offrire agli italiani gli strumenti per sapere, crescere e giudicare. Quella cifra imbarazza perché racconta un sistema di poteri, non solo mafiosi, che continuano a considerare come un intollerabile fastidio ogni voce libera, ogni cronista con la schiena dritta, ogni racconto – su quei poteri e sulle loro miserie – che non si pieghi all'adulazione o alla menzogna.
Il primo dato allarmante che ci consegna il lavoro del Comitato è, da un lato, l'incremento degli atti di ostilità nei confronti dei giornalisti; dall'altro, l'impunità di quegli atti (pochissimi gli episodi in cui gli autori di minacce o violenze siano stati identificati, giudicati e condannati).
L'altro dato è il ricorso sempre più frequente – accanto a metodi più diretti e più tradizionali – a un uso spregiudicato e intimidatorio di alcuni strumenti del diritto. Parliamo delle querele temerarie e di azioni civili per danni altrettanto temerarie: dove la temerarietà è solo apparente, visto che in questi casi l'obiettivo dell'azione giudiziaria contro il giornalista non tanto è quello di dimostrare le proprie ragioni quanto quello di indurre quel giornalista a comportamenti e scritture più «rispettosi». La giornalista Milena Gabanelli ha spiegato al Comitato di aver ricevuto citazioni in giudizio per oltre 250 milioni Pag. 101di euro (con un picco, paradossale, di 137 milioni richiesti da una multinazionale della telefonia). A fronte di una sola causa persa per 30 mila euro, la sproporzione con l'ammontare delle cifre
pretese fa cogliere bene l'elemento pretestuoso di quelle azioni.
C’è poi una violenza più subdola, ma non meno dolente, che si manifesta nelle condizioni di estrema precarietà contrattuale ed economica dei giornalisti minacciati. Molti cronisti auditi, a fronte di un devastante repertorio di intimidazioni subite (pallottole per posta, auto bruciate, minacce verbali, avvertimenti più o meno felpati), hanno ammesso di dover lavorare per pochi euro ad articolo, spesso senza contratti e con editori raramente disponibili ad andar oltre una solidarietà di penna e di facciata. La giovane giornalista Ester Castano, costretta a difendersi da toni e comportamenti intimidatori dopo aver contribuito, con i suoi articoli, allo scioglimento per mafia (il primo in Lombardia) del comune di Sedriano, ha lavorato fino a tutta la primavera del 2015 in un fast food, non riuscendo a mantenersi con il ricavato delle proprie collaborazioni. Solo recentemente la Castano è stata assunta presso
l'agenzia LaPresse di Torino. La sua vicenda non è un caso limite: le audizioni e l'attività di documentazione del Comitato hanno svelato – soprattutto in Calabria, Sicilia e Campania – un perimetro di giornalisti bravi, giovani, quotidianamente a rischio. Ma senza alcun contratto.
Un altro tema, il cui approfondimento questa relazione affida ad all'indagine specifica di un altro comitato, riguarda l'informazione sul web, la proliferazione dei blog e l'uso intimidatorio o perfino colluso con la criminalità organizzata che in alcune realtà se n’è fatto.
C’è infine, nei confronti dell'informazione libera, una diffusione di episodi di aggressività non sempre riferibili alle organizzazioni criminali mafiose. Difficile, in questi casi, capire quale sia la linea di confine tra minacce malavitose in senso stretto e semplici atti di intolleranza di poteri e potenti che mal sopportano una stampa non allineata. Non di rado gli uni si fanno scudo attraverso gli altri, come testimoniano alcuni episodi ricostruiti soprattutto in Sicilia e in Calabria.
Le conseguenze si riflettono anche sulla qualità dell'informazione, che spesso ne risente. Molte testimonianze raccolte dal Comitato raccontano di un clima difficile in alcune redazioni, di giornalisti isolati, allontanati o persino licenziati anche quando queste decisioni li ponevano oggettivamente in una condizione di maggior rischio. Significativa, sia pur lontana nel tempo, la ricostruzione dell'omicidio Francese, degli ultimi suoi mesi di lavoro al Giornale di Sicilia e del modo in cui l'informazione su cosa nostra – in quegli anni – abbia finito per provocare lacerazioni profonde nella redazione di quel giornale. Preoccupanti gli elementi raccolti anche sull'altro grande quotidiano dell'isola, La Sicilia, e sui tratti di opacità che hanno segnato l'informazione sulla mafia catanese. Come grave risulta – per ciò che evoca e documenta – la richiesta di rinvio a giudizio del suo editore Mario
Ciancio per concorso esterno in associazione mafiosa. Grave soprattutto per una terra, la Sicilia, che ha già contato otto giornalisti uccisi da cosa nostra.
È l'altra faccia della medaglia: accanto a un numero sempre crescente di giornalisti minacciati, aggrediti, offesi, sopravvivono Pag. 102alcune sacche di informazione compiacente o reticente. Di editori attenti a pretendere il silenzio delle loro redazioni su fatti o nomi innominabili. E di direttori che si prestano a sorvegliare, condizionare e redarguire quelle redazioni. Casi poco numerosi, per fortuna, ma non del tutto isolati. Su cui l'Ordine dei giornalisti ha ormai abdicato a esercitare una funzione di fattivo controllo, avendola dovuto delegare per legge ai cosiddetti Consigli di disciplina. Che fino ad oggi – nei dati che ci sono stati messi a disposizione – hanno funzionato poco o nulla.
Va rilevato – e l'ha fatto Nino Milazzo (70), lucidamente, nel corso della sua audizione – il ruolo insufficiente della stampa nazionale, come se l'approfondimento dei temi d'indagine giornalistica legati al fenomeno mafioso resti marginale appena ci si sposta al nord. Ricordava Milazzo, che è stato a lungo vicedirettore del Corriere della Sera, d'una scarsa attenzione complessiva verso la vita del Mezzogiorno: «Perfino al Corriere la Sicilia veniva concepita come un fastidio». Vicedirettore de l'Indipendente ai tempi delle stragi di Capaci e via D'Amelio, Milazzo ricorda ancora il commento di un editorialista del quotidiano milanese in quei giorni: «La Sicilia ha rotto i coglioni». Insomma, il problema non era la mafia, ma il Sud.
In un tempo in cui la lotta alla mafia diventa per taluni un biglietto da visita a cui non sempre corrisponde un reale impegno su quel fronte, l'attività del Comitato ha peraltro incontrato anche episodi di millantati rischi e di giornalisti sul cui effettivo livello di esposizione occorre procedere ad attente verifiche. Che questo Comitato, per la delicatezza e la rilevanza del tema, rinvia all'indagine che la Commissione ha già avviato sull'uso e «l'abuso» dell'antimafia.
Come spiega la relazione, offrendo anche proposte di soluzione legislativa, il percorso di riforma dovrà concentrarsi sul tema dell'abuso di alcuni strumenti del diritto. Ma occorre un intervento altrettanto urgente, non delegabile al Parlamento, per costruire condizioni di maggiore sicurezza economica e dignità professionale per gli operatori dell'informazione. Soprattutto per chi opera nei territori più marginali, più esposti, più colpiti dalla violenza mafiosa o dall'arroganza dei poteri. Non aver ancora normato contrattualmente la figura dei freelance, che è di fatto l'ossatura dell'intero sistema informativo italiano, è una lacuna grave alla quale dovrà essere posto rimedio al più presto.
Il dato positivo, che non era scontato all'inizio di questa indagine, è la determinazione con cui una nuova generazione di giornalisti ritiene che la funzione etica del loro mestiere non possa essere svilita da condizioni di lavoro a volte umilianti. E che ha scelto di non piegare la schiena pur sapendo che quella scelta li espone ai morsi del pericolo e della precarietà. Sono giornalisti poco conosciuti, schivi, generosi, determinati. Raramente li incontreremo sulle ribalte mediatiche, ma leggeremo o ascolteremo spesso i loro racconti sul sistema di potere mafioso, sui suoi innominabili amici, sui suoi oscuri mallevadori. Degli undici giornalisti uccisi da mafie e terrorismo in Italia, questa silenziosa e tenace comunità di giovani cronisti è l'eredità più autentica. Certamente la più preziosa.
NOTE:
(1) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Roberto Rossi – 1o agosto 2014
(2) Mani Roberta, Rossi Roberto – Avamposto. Nella Calabria dei giornalisti infami, ed. Marsilio, 2010
(3) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista de la Repubblica, Enrico Bellavia – 18 luglio 2014
(4) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni, criminali anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Paolo Pollichieni – 31 ottobre 2014
(5) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista de L'Espresso, Lirio Abbate – 25 luglio 2014
(6) Cfr. articolo de la Repubblica on line (www.Repubblica.it) dell'8 dicembre 2014, dal titolo Mafia Capitale, Carminati intercettato: "Bisogna mettere un freno a quel cronista dell'Espresso".
(7) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Giovanni Tizian – 25 luglio 2014
(8) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Francesco Castaldo – 9 settembre 2014
(9) La Domenico Sanfilippo Editore S.p.A. è la più importante casa editrice della Sicilia ed appartiene a Mario Ciancio Sanfilippo
(10) Filippo Salomone, titolare dell'Impresem, era stato indicato dal collaboratore di giustizia Angelo Siino come uomo legato a cosa nostra
(11) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni, criminali anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Riccardo Arena – 27 novembre 2014
(12) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Domenico Valter Rizzo – 9 settembre 2014
(13) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del giornalista Nino Milazzo – 20 luglio 2015
(14) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione dell'onorevole Michela Giuffrida – 28 luglio 2015
(15) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione dell'onorevole Michela Giuffrida – 28 luglio 2015
(16) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione dell'onorevole Michela Giuffrida – 28 luglio 2015
(17) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del giornalista Nino Milazzo – 20 luglio 2015
(18) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione dell'onorevole Michela Giuffrida – 28 luglio 2015
(19) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Federica Angeli – 23 settembre 2014
(20) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Luigi Centore – 23 settembre 2014
(21) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Carlo Bonini – 1oagosto 2014
(22) La ricerca “Smascheriamo gli editori” è stata presentata il 18 maggio 2010 dall'Ordine nazionale dei giornalisti
(23) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione della giornalista Milena Gabanelli – 10 marzo 2015
(24) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Giuseppe Maniaci – 16 settembre 2014
(25) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione di rappresentanti di Radio Siani – 30 settembre 2014
(26) Cfr. Audizione di Alberto Spampinato alla Commissione giustizia della Camera dei deputati. «Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato» – 9 dicembre 2014
(27) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione della giornalista Rosaria Capacchione – 21 ottobre 2014
(28) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del direttore Antonio Polito – 19 novembre 2014
(29) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del direttore Alessandro Barbano – 19 novembre 2014
(30) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Ottavio Lucarelli – 20 novembre 2014
(31) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del giornalista Nino Milazzo – 20 luglio 2015
(32) Oltre agli interessi nella costruzione di centri commerciali (ICOM a Catania e OUTLET ad Agira). Ciancio – a titolo di esempio – e per limitarsi solo agli ultimi anni, si è interessato della costruzione dell'aeroporto di Comiso (SR), della costruzione di villette per gli USA nella zona di Lentini (cosiddetto Progetto XIRUMI) (SR), nell'affitto di terreni per l'installazione di impianti fotovoltaici nella zona di Scordia (CT), del futuro ospedale San Marco di Librino (Catania). Lo stesso opera poi nell'ambito del turismo, essendo proprietario di un prestigioso albergo a Taormina, e nell'ultimo periodo è interessato a portare a termine una operazione per la riqualificazione della zona sud di Catania (per una estensione di 5.3000 ettari), cosiddetto P.UA Variante Catania Sud, Stella Polare (rogatoria internazionale della procura della Repubblica di Catania nel procedimento penale n. 3768/14 N.R.)
(33) Oltre alle emittenti locali Antenna Sicilia, Teletna e Telecolor, quest'ultima acquisita nella seconda metà degli anni Novanta, Ciancio controlla anche Telejonica e Rete8, ed ha importanti partecipazioni anche in MTV e Radio SIS. Nel 2007 l'imputato Ciancio vendeva numerose frequenze televisive a Telecom Italia e MTV ricevendo un prezzo pari a 21 milioni di euro (rogatoria internazionale della procura della Repubblica di Catania nel procedimento penale n. 3768/14 N.R.)
(34) A proposito di tale modus operandi, scrive la sentenza: "Acquistavano terreni agricoli nella prospettiva di ottenerne la variazione di destinazione urbanistica, e poi realizzare elevati guadagni con la plusvalenza della proprietà". E proprio parlando di questa ”tecnica”, la sentenza cita l'editore catanese Mario Ciancio che "annoverava tra i soci un soggetto vicino a cosa nostra palermitana. [...] Il modus operandi e la presenza di elementi vicini alla mafia fanno ritenere con un elevato coefficiente di probabilità che lo stesso Ciancio fosse soggetto assai vicino al detto sodalizio. (l'editore), attraverso i contatti con cosa nostra di Palermo avrebbe quindi apportato un contributo concreto, effettivo e duraturo alla “famiglia” catanese" (sentenza del Gup di Catania, 19 febbraio 2014)
(35) Sul punto si riportano le dichiarazioni di Ferone del 8.10.2010 secondo cui "Ancora nel periodo in cui ero vicino a Giuseppe Calderone [alla fine degli anni ’70] ero a conoscenza del fatto che i più importanti imprenditori di Catania avevano dei rapporti diretti con la nostra organizzazione criminale. Nel senso che – oltre a pagare all'associazione mafiosa somme di denaro in relazione ai lavori pubblici o privati in misura del 5 per cento dell'importo dell'appalto – avevano interessi reciproci. [ ... ] Adr: di questo gruppo di imprenditori vicino all'associazione faceva parte anche l'editore del giornale La Sicilia che si chiama Ciancio Sanfilippo. Ricordo che la nostra associazione era interessata ad ottenere che la linea editoriale di questo quotidiano fosse in alcune occasioni modificata a favore dell'associazione (rogatoria internazionale della procura della Repubblica di Catania nel procedimento penale n. 3768/14 N.R.)
(36) Verbale di interrogatorio dell'8 ottobre 2010, procedimento 4888/2008. Siino indicherà tutti i giornalisti presenti in redazione al momento della scenata del boss Ercolano: il vicedirettore Domenico Tempio, il capocronista Vittorio Consoli, i giornalisti Andrea Lodato, Salvatore La Rocca e Giuseppe Testa, e il presentatore televisivo Salvo La Rosa
(37) Agenzia AGI, 19 giugno 2015
(38) cfr. la Repubblica, 3 giugno 1994
(39) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del giornalista Nino Milazzo – 20 luglio 2015 {/FOOT;f40;1}
(40) Sentenza della IV sezione della Corte d'assise di Palermo, 11 aprile 2001
(41) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Giovanni Pepi – 12 febbraio 2015
(42) Verbale di interrogatorio del 19 agosto 1997
(43) ibidem
(44) Verbale di interrogatorio dell'11 marzo 1997, procedimento 4495/94
(45) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Michele Albanese – 7 ottobre 2014
(46) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Lucio Musolino – 14 ottobre 2014
(47) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del giornalista Piero Sansonetti – 9 dicembre 2014
(48) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del dottor Giovanni Musarò – 21 aprile 2015
(49) Procura della Repubblica di Cosenza, decreto di citazione diretta a giudizio nr. 7496/2013
(50) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. VIII Comitato: Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione. Audizione del presidente Giuseppe Soluri – 17 dicembre 2014
(51) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del presidente Vincenzo Iacopino – 17 marzo 2014
(52) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del presidente Santo Della Volpe – 26 marzo 2015
(53) Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del segretario Raffaele Lorusso – 26 marzo 2015
(54) Art. 8 Cost. Francia 1848; articolo 21 Cost. Italia
(55) Art. 11 Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese 1789; articolo 8 Cost. Francia 1814; articolo 7 Cost. Francia 1830; tit. VI, articolo IV, par. 143, Cost. Francoforte 1849; articolo 118 Cost. Germania 1919; articolo 5 Legge fondamentale Germania 1949; articolo 20 Cost. Spagna 1978; articolo 16 Cost. Svizzera 1999
(56) I emendamento Cost. U.S.A. 1787
(57) Art. 18 Cost. Belgio 1831; articolo 28 Statuto Albertino
(58) Corte Costituzionale sentenza n. 84 del 1969
(59) Corte Costituzionale sentenza n. 112 del 1993
(60) Cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 112 del 1993; tra le altre n. 122/70; n. 194/87
(61) Corte Costituzionale sentenza n. 86 del 1974
(62) Corte Costituzionale sentenze n. 19 del 1962; n. 87/1966; n. 84/ 1969; n. 65/1970
(63) Sebbene l'articolo 21, comma 1, Cost. garantisca la libertà di manifestazione del pensiero con qualunque «mezzo di diffusione», i rimanenti commi dell'articolo 21 Cost. disciplinano uno strumento in particolare, cioè la stampa. È stato giustamente notato che, su questo punto, la nostra Costituzione sconta un mancato aggiornamento, con particolare riferimento non solo alla radiotelevisione, ma anche alle più recenti forme di manifestazione del pensiero (ad esempio, Internet)
(64) Cfr. ad es. sentenza n. 48 del 1969 della Corte Costituzionale
(65) «La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è «mezza verità» (o comunque, verità incompleta) – omissis- La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa» Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259
(66) «La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. (..) E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre – con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato – ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette): a) al sottinteso sapiente, – omissis –; b) agli accostamenti suggestionanti» Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259
(67) C. 191, Pisicchio, 15 marzo 2013; C. 925, Costa, 13 maggio 2013; C. 1100, Gelmini, 29 maggio 2013; S. 734, Casson, 30 maggio 2013; C. 1165, Dambruoso, 6 giugno 2013; C. 1190, Liuzzi, 12 giugno 2013; C. 1242, Molteni, 20 giugno 2013; S. 866, Stefani, 21 giugno 2013; S. 1067, Stefani 18 ottobre 2013
(68) Gandhi, «La mia vita per la libertà», 1925
(69) Gandhi, «La mia vita per la libertà», 1925
(70) Audizione del giornalista Nino Milazzo – 20 luglio 2015.